 |
||||
 |
||||
| Note sulla filosofia e la teologia inaccettabili della Laudato si’ di
Arnaldo Xavier da Silveira
La traduzione è nostra L'articolo pubblicato sul sito dell'Autore Gli articoli dell'Autore sono disponibili nel sito Bonum Certamen 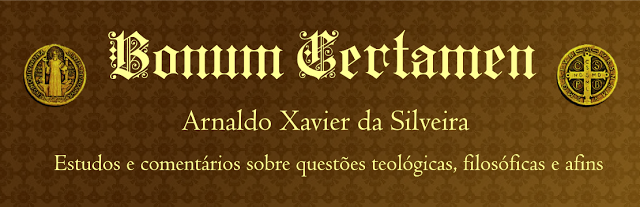 3 agosto 2015 “L’uomo è creato per
lodare, riverire e servire Dio nostro Signore,
e così raggiungere la salvezza; le altre realtà di questo mondo sono create per l’uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue che l’uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine, e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo.” (Sant’Ignazio di Loyola – Esercizi Spirituali) 1. Introduzione: una “visione filosofica e teologica dell’essere umano e della creazione” di sapore panteista ed evoluzionista Tra le reazioni sfavorevoli alla recente Enciclica Laudato si’, di Papa Francesco, vi è un aspetto che nelle pubblicazioni antimoderniste è stato poco considerato: la sua nebulosa “visione filosofica e teologica dell’essere umano e della creazione” (n° 130). E tuttavia, questa nuova Antropologia e questa nuova Cosmologia, di sapore panteista (1) ed evoluzionista, sono inaccettabili alla luce della Teologia cattolica e della sana Filosofia. Infatti non è chiaramente affermata l’assoluta trascendenza di Dio (solo qualche riferimento di passaggio, come al n° 79 (2)); né sono chiaramente affermate la distinzione tra la creatura e il Creatore e la nozione metafisica della creazione ex nihilo, per un atto libero di Dio. Queste note sono redatte con
tutto il rispetto dovuto al Sommo Pontefice, ma nelle presenti
circostanze la verità dev’essere detta per intero, per onorare
la Santa Madre Chiesa e preservare l’integrità della sana
dottrina.
Senza sminuire le critiche già formulate sugli aspetti economici, sociali o scientifici del documento – in generale ben fondate -, ci sembra che tali aspetti siano meno profondi e gravi di questa nuova concezione dell’uomo e dell’universo. Uno studio più approfondito dei princípi metafisici che ispirano l’Enciclica Laudato si’ comporterebbe l’esame dettagliato di ogni tesi in essa difesa, secondo le buone regole dell’apologetica cattolica tradizionale; cosa che però non ci sembra necessaria in queste brevi note, che hanno soprattutto un carattere di pubblica denuncia e di avvertimento per i fedeli. Non intendiamo presentare un’analisi esaustiva dell’Enciclica e in queste considerazioni ci limiteremo alla visione filosofica e teologica prima menzionata, evidenziando alcuni punti che parlano da soli al cattolico di buona formazione, che è colui al quale ci rivolgiamo. 2. Un misticismo panteista ed evoluzionista ispirato a Teilhard de Chardin Nell’Enciclica Laudato si’, Papa Francesco si propone di presentare una “visione filosofica e teologica dell’essere umano e della creazione” (n° 130). A partire da tale concezione dell’uomo e dell’universo, egli svolge, non in forma sistematica, ma evidente, una nuova Teologia, una nuova Morale, una nuova Liturgia, una nuova concezione dei Sacramenti e della preghiera, una nuova spiritualità e infine una nuova Mariologia. Sulla base di tali concetti, egli offre anche soluzioni che finiscono col proporre un’autorità internazionale al di sopra dei governi nazionali (cfr. n° 175). Questa visione filosofica e teologica si muove sulla linea del misticismo panteista ed evoluzionista del Padre Pierre Teilhard de Chardin SJ, personalmente citato nel documento (n° 83). Vediamo alcuni esempii: - “Il traguardo del cammino dell’universo
è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta
da Cristo risorto, fulcro della
maturazione universale” (n° 83).
Questa affermazione, di sapore immanentista ed evoluzionista, è molto simile al concetto teilhardiano del “Punto Omega”, punto di unificazione dell’evoluzione di tutti gli esseri creati, identificato con Cristo. Per non lasciare dubbi quanto all’ispirazione di Theilhard, l’Enciclica, nella nota a pie’ di pagina, rimanda il lettore all’opera del Gesuita: - “In questa prospettiva
si pone il contributo del P. Teilhard de Chardin” (n° 83,
nota 53).
E di fatto sono le concezioni theilhardiane che ci danno la chiave di lettura del documento e della comprensione della nebulosa “visione filosofica e teologica dell’essere umano e della creazione”, proposta dall’Enciclica, e di tutte le sue conseguenze (vedi l’Appendice 1) Vale la pena ricordare che le opere di Teilhard de Chardin furono oggetto di un Monitum (avvertimento) del Sant’Uffizio, del 30 giugno 1962, in cui si afferma che i suoi scritti abbondano di ambiguità e “contengono perfino gravi errori che offendono la dottrina cattolica” (3).
5. “Spiritualità ecologica” In tutto il documento, l’“ecologia”, l“ambiente”, la “natura” sono presentati come assoluti che devono guidare tutta l’attività umana - morale, spirituale, economica, educativa, ecc. Sulla base di questi principi, Francesco propone una “spiritualità ecologica”: - “Desidero proporre ai cristiani alcune
linee di spiritualità ecologica che nascono dalle convinzioni
della nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna
ha conseguenze sul nostro modo di pensare, di sentire e di vivere. …
non sarà possibile impegnarsi in cose grandi soltanto con delle
dottrine, senza una mistica che ci animi, senza «qualche movente
interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso
all’azione personale e comunitaria » [Evangelii gaudium, 261]. Dobbiamo riconoscere che non sempre noi
cristiani abbiamo raccolto e fatto fruttare le ricchezze che Dio ha
dato alla Chiesa, dove la
spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né
dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto vive
con esse e in esse, in comunione con tutto ciò che ci circonda”
(n° 216).
Il Papa chiede una “conversione ecologica” e presenta l’ecologismo come facente parte dell’essenza della vita virtuosa: - “(…) la crisi ecologica è un appello a
una profonda conversione interiore. … una conversione ecologica, che
comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con
Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi
dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa,
non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario
dell’esperienza cristiana.” (n° 217).
Questa “conversione ecologica” implica la coscienza “di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale” (nº 220). Questa “spiritualità ecologica” ci fa sobrii, umili, senza il desiderio di dominare (cfr. nn° 224-225) e ci aiuta ad ascoltare le “parole d’amore” della natura (cfr. n° 225). 6. Una nuova Mariologia ecologica Questa nuova “spiritualità” modifica anche in chiave ecologica la devozione a Maria Santissima: - “Maria, la madre che
ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore
materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore
trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza
dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal
potere umano.” (n° 241).
7. Appello ad un “maestro spirituale” della Gnosi islamica Il Papa Francesco, a sostegno della sua nuova “spiritualità ecologica”, cita un “maestro spirituale” della Gnosi islamica sufi: - “Un maestro spirituale, Ali Al-Khawwas, (…)
diceva: «(…) Gli iniziati
arrivano a captare quello che dicono il vento che soffia, gli
alberi che si flettono, l’acqua che scorre, le mosche che ronzano, le
porte che cigolano, il canto degli uccelli, il suono delle corde o dei
flauti, il sospiro dei malati, il gemito degli afflitti… »”
(n° 233, nota 159).
8. La terra trattata come un essere vivente In varii passi l’Enciclica parla della terra, della natura e dell’ambiente come fossero degli esseri razionali (4): - “Questa sorella [la terra] protesta per il male che le provochiamo, a
causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in
lei.” (n° 2).
- “Per questo, fra i poveri più abbandonati
e maltrattati, c’è la nostra
oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie
del parto» (Rm 8,22)” (n° 2).
Si noti l’impiego della categoria marxista del “povero” come “oppresso”. - L’Enciclica raccomanda un approccio ecologico “per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” (n° 49). - “Queste situazioni provocano i
gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati
del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta”
(n° 53).
L’enciclica parla di un “rapporto interiore” dell’uomo con se stesso, “con gli altri, con Dio e con la terra” (n° 70). E più avanti dice che il Levitico “Ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle relazioni dell’essere umano con gli altri e con la terra dove viveva e lavorava.” (nº 71). Ora, le relazioni di equità esistono solo tra esseri razionali, tra persone. Così, secondo l’Enciclica, l’uomo cessa di essere il re della creazione corporea (vedi Appendice II).
10. Post scriptum Le presenti note erano già state redatte quando siamo venuti a conoscenza di una intervista concessa per posta elettronica dalla Professoressa Deborah Terezinha de Paula alla Rivista IHU online, dell’Istituto Umanitas della UNISINOS [Università brasiliana dei Gesuiti], pubblicata col titolo: “Laudato si’: um texto impregnado de Teilhard de Chardin”. L’intervistata si è laureata in Pedagogia presso l’Università Federal de Juiz de Fora, insegna Scienza delle Religioni e recentemente ha dibattuto la tesi di dottorato “Diafania di Dio nel cuore della materia: la Mistica di Teilhard de Chardin”. Il fatto rilevante è che l’intervista è stata concessa ad un organo dell’Università UNISINOS, diretta dai gesuiti da Rio Grande do Sul, che l’ha accolta con entusiasmo; la stessa Università che nel 2005 ha promosso un simposio che ha avuto una grande ripercussione nei media specializzati e che si è tenuto in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Teilhard, il tutto rivelatore della compromissoria adozione da parte dei circoli cattolici progressisti, specialmente dall’UNISINOS, delle tesi di Teilhard de Chardin. Teilhard presente tra le righe dell’Enciclica La rivista della UNISINOS osserva che il pensatore francese è molto presente in questa Enciclica e riporta che l’intervistata “rivela che il pensiero del mistico appare, non solo nelle citazioni dirette”. “È come se stesse tra le righe”, scrive la stessa Professoressa Deborah. E prosegue: “quando il Papa evidenzia la presenza di Dio negli elementi della natura, si ha l’impressione di ascoltare lo stesso Teilhard” e ancora “lo stesso titolo dell’Enciclica, che ci chiama ad una lode universale mediante la cura della casa comune, mi ricorda Teilhard de Chardin.” Il Cristo universale Scrive l’intervistata: “Il Cristo Universale di Teilhard non è un Cristo nuovo, ma lo stesso Cristo della Fede evangelica”. E ancora: “È l’uomo nato da donna, il bambino nato a Betlemme, Dio che con l’Incarnazione assunse il mondo materiale per elevarlo a sé. È il giovane che sfidò il potere in difesa dei più deboli, pagando con la propria vita il prezzo della sua audacia. È colui che con la Resurrezione ora abita e illumina tutto l’essere. È il Cristo che, essendo passato per il mondo, ora abita il cosmo, convocando tutti noi ad una conversione d’amore.” E la Professoressa Deborah prosegue: “Quando parla del dovere umano di collaborare col Creatore nell’opera della Creazione (LS 14, 124ss), il Papa richiama certamente Teilhard, che più volte ha parlato di questo dovere intendendolo come un dovere sacro. Quando ci rendiamo conto del legame che ci unisce a tutto quanto esiste e infine quando cresce in noi quello che il mistico francese definiva senso cosmico, arriviamo a percepire la nostra natura molecolare”. Scrive la Professoressa Deborah: “Teilhard assume l’evoluzione come sfondo della sua spiegazione del mondo. Come io penso, egli sintetizza il suo credo nel modo seguente: «Io credo che l’Universo sia una Evoluzione. Credo che l’Evoluzione si muova verso lo Spirito. Che lo Spirito si completa nel personale. Credo che il Personale supremo sia il Cristo Universale»”. Visto il carattere radicale di questi testi, non si può fare a meno di chiedersi se l’evoluzione, partendo dalla creazione e proseguendo per l’Incarnazione, non passi per lo stadio, come dice la Professoressa Deborah, del Cristo che “ora abita il cosmo”, e, per un processo di maturazione della “conversione d’amore”, non giunga, come si legge nell’Enciclica, alla “pienezza trascendente” di Dio, “onde il Cristo resuscitato tutto abbraccia ed illumina”, il Cristo Universale di Teilhard de Chardin (n° 83). Come si può vedere, tutto il linguaggio di Teilhard de Chardin e dei suoi seguaci è un insieme di metafore letterarie e confuse che mirano a mascherare le loro dottrine dal fondamento panteista. La chiamano mistica, ma la vera mistica cattolica è chiara, intelligibile, inserendosi nella logica e nella razionalità della Scolastica. Un panteismo cristiano? Scrive l’intervistata: “Questa singolare capacità di vedere Dio in tutte le cose, questo profondo accoglimento della spiritualità paolina di Dio tutto in tutti, alla fine ha prodotto che la mistica teilhardiana fosse erroneamente associata alle mistiche panteiste, dalle quali lo stesso Trilhard si dice sedotto.” Ancora l’intervistata: “Nel suo processo di evoluzione interiore, egli si sentì tentato dal panteismo e, uomo di armonia per eccellenza, lavorò arduamente per rifiutarlo e al tempo stesso per integrarlo nella sua visione del mondo. Nella sua autobiografia egli parla non del rischio di incorrere nel panteismo, ma di perdersi in «una forma inferiore (la forma banale e semplicistica) dello spirito panteista: il panteismo effusivo e dissolutista […] Per essere tutto e fondermi con tutto». Questo tipo di panteismo è rigettato dal mistico, il quale, captando Dio nel mondo, non identifica Dio e il mondo. Mentre il panteismo seduce con l’idea di una perfetta unione per cui le differenze sarebbe annullate, nella mistica teilhardiana le differenze sono valorizzate. Il Creatore, come concepito dal gesuita, abbraccia le creature, ma il suo abbraccio non assorbe in sé. La vera unione non fa perdere la personalità. È necessario unirsi ad un altro senza smettere di essere quello che si è. E in verità, spiega il religioso di Auvergne, è questa l’aspirazione di tutta la mistica: «[…] unirsi (cioè diventare l’altro) rimanendo se stesso», aspirazione che, nella concezione di Teilhard, solo il cristianesimo salva attraverso la persona di Cristo, l’umano-divino che senza smettere di essere Dio è uomo e senza smettere di essere uomo è Dio”. Teilhard avrebbe guadagnato voce e spazio a Roma A proposito del Monitum pubblicato dalla Santa Sede nel 1962 contro le opere di Teilhard, l’intervistata scrive che i suoi scritti “sono stati accolti e oggi guadagnano voce e spazio nello stesso ambiente che tentò di ammutolirlo, segno di tempi nuovi, di una Chiesa capace di lasciarsi vivificare dallo Spirito che soffia dove vuole. Già prima della Laudato si’, due pontefici avevano ripreso Teilhard: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI; ma nessuno dei due in un’enciclica e in forma tanto marcata. Anche se contiene un solo richiamo diretto al Padre Teilhard, posso dire che la Lettera [Enciclica] è tutta impregnata del suo modo di pensare.” NOTE 1 – Il panteismo: come dice lo stesso nome, è la dottrina secondo la quale tutto è Dio. Variano solo le costruzioni dottrinali delle diverse correnti panteiste. 2 – Seguiamo Il testo e la numerazione dei paragrafi della Lettera Enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, del 24 maggio 2015, Solennità di Pentecoste, come pubblicata sul sito della Santa Sede. In aggiunta ricorriamo ai testi pubblicati in Brasile dalle Editoras Paulinas e Loyola, São Paulo, 2015. I riferimenti ai testi dell’Enciclica sono fatti esclusivamente con l’indicazione dei paragrafi, per esempio: (nº 239). 3 - Apud A.M. y C.C., Teilhard de Chardin, Pierre - Opera omnia. Disponibile in http://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/teilhard_obr.htm 4 – È vero che molti mistici autentici, ed anche le Sacra Scritture, molte volte usano un linguaggio antropomorfico nel riferirsi alle creature inanimate o irrazionali; ma il contesto ecologico-panteizzante dell’Enciclica fa sì che tale ricorso metaforico diventi sospetto. 5 - San Paolo, Galati, 1,8. 6 - Considerações sobre o ‘Ordo Missae’ de Paulo VI, 1970, São Paulo; publicato in francese col titolo La Nouvelle Messe de Paul VI: Qu’en Penser? (Diffusion de la Pensée Française, Chiré-en-Montreuil, Vouillé, Francia, 1975). 7 - Ad Gal., 2, 14. 8 - De Fide, disp. I, sect. VI, n. 16. 9 - De Rom. Pont., lib. II, c. 29. 10 - Ad Gal., 2, 11. 11 - Gal., 2, 11. 12 - Epist. 19. 13 - Homil. 18 in Ezech. (torna
su)
settembre 2015 |