 |
 |
| Intervista all’Avvocato Francesco Patruno sul problema della rinuncia di Ratzinger/Benedetto XVI A cura di Gaetano Masciullo
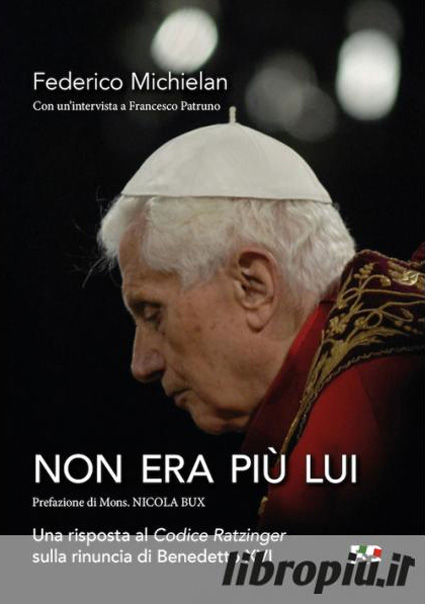 Avv. Francesco Patruno, lei
è avvocato e dottore in Scienze Canonistiche ed Ecclesiastiche
presso l’Università di Macerata, oltre che collaboratore presso
le cattedre di diritto ecclesiastico e canonico dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Da quel fatidico 11 febbraio 2013,
data dell’annuncio delle dimissioni del defunto papa Benedetto XVI, lei
ha studiato con grande acribia questo avvenimento dal punto di vista
del Codice di diritto canonico, un avvenimento che rappresenta un vero
unicum per i cattolici di oggi. L’opera del dott. Federico Michielan,
che qui abbiamo pubblicato, espone in maniera brillante la
problematicità delle dimissioni di Ratzinger, districandola con
la perizia propria di un canonista.
Approfittando della sua notevole preparazione, avv. Patruno, noi di Fede & Cultura abbiamo deciso di chiederle un’intervista per analizzare più in profondità alcune voci, alcune tesi, alcuni “complotti” (oggi vanno molto di moda!) che si sono diffusi dapprima in rete, poi anche sui quotidiani e perfino in molte parrocchie. Molti sacerdoti, forse un po’ a digiuno di teologia e diritto, si sono improvvisati profeti di questa nuova fanta-teologia complottistica. Secondo queste tesi, se tali possiamo definirle, Benedetto XVI non si sarebbe davvero dimesso, ma avrebbe messo in piedi una messinscena, una sorta di codice cifrato, per comunicare con i pochi cattolici in grado di recepirlo. Il messaggio di questo presunto messaggio criptato di Ratzinger sarebbe stato recepito in particolare da un giornalista, non da canonisti. Analizziamo dunque insieme queste affermazioni. 1. La prima domanda che vorrei rivolgerle riguarda la storia della Chiesa più in generale. Ci sono precedenti alla figura del papato emerito o è una assoluta novità? Una premessa generale: come
diceva un mio professore degli anni universitari, oggi per attirare
l’attenzione occorre puntare sul darko sul sexo sul pulp. Per cui, se
si volessero “vendere” certe idee in un mercato letterario o di
inchiesta giornalistica, al fine di evitare di vedersi confinati in una
ristretta nicchia di lettori, occorrerebbe puntare su almeno uno di
questi aspetti. Nel nostro caso, si è puntato sul
sensazionalismo, sul complotto e trame nascoste, su scontri
apocalittici tra bene e male e chissà quant’altro. Lo abbiamo
visto negli anni scorsi nell’ambito politico e sanitario: non poteva
mancare, ovviamente, quello ecclesiastico (460).
2. Il dottor Michielan
ricostruisce e spiega l’origine del concetto di “papa emerito”
all’interno del contesto culturale della Nouvelle Théologie del
secolo scorso (cfr. par. 4.4.1.; 2.4.1.; 3.4.2.), dove spiccavano nomi
come quelli di Rahner, Kung e dello stesso Ratzinger. Cosa ne pensa di
questa esaltazione di Ratzinger? La vicenda relativa alla “rinuncia” di papa Ratzinger ben si prestava a questo genere di narrativa fanta-teologico-canonico-complottista. Del resto, con il gesto compiuto dal compianto papa tedesco crollava un mondo, un punto di riferimento. Paradossalmente pure da parte laica. A differenza del Medioevo in cui c’erano diverse pietre miliari nella vita dei singoli e delle società (l’Imperatore, il Papa, la stessa Chiesa, e in ultima analisi Dio stesso), nel mondo attuale secolarizzato e privo di personalità carismatiche e attrattive nella politica, nella Chiesa, nella società, la figura del defunto Benedetto XVI, per quanto criticata durante il suo papato (461), costituiva nondimeno un pilastro morale autorevole, un lume a cui guardare, pure da parte di non cattolici e persino non credenti, grazie anche al suo indiscusso prestigio personale, alla sua preparazione teologica e alla sua indole pacata e dolce. Per questo non può destare meraviglia se la “rinuncia” benedettina non sia stata indifferente per molti, persino per i laici, intravedendovi addirittura, la rimozione del paolino katéchon (462) con l’approssimarsi dell’Anticristo o il realizzarsi del c.d. Terzo segreto di Fatima o di altre visioni (o presunte tali) di stampo apocalittico. C’è, poi, pure un aspetto poco investigato al giorno d’oggi. Alludo a un curioso testo risalente al 1951. In quell’anno fu pubblicato, con tanto di imprimatur, un libro di poco più di un centinaio di pagine, scritto da un gesuita, Mons. René Thibaut, docente onorario all’Università di Namur, dal titolo La mystérieuse prophétie des Papes. Il testo fu pubblicato dalla Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Namur. L’autore, attraverso un complesso sistema simbolico e diretto richiamo a schemi matematici, di difficile reperibilità, partendo dalla celebre profezia di Malachia di Armagh sui Romani Pontefici, giunse all’anno 2012 come terminale del ciclo pontificale malachiano pieno (463). Anche se non fossimo dei creduli – e non lo siamo – questo testo impressiona per il suo valore, diciamo, profetico se pensiamo che di una possibile “rinuncia” o addirittura eliminazione fisica di Benedetto XVI si parlò proprio a partire dai primi mesi del 2012 (464). Personalmente, al di là del testo del Thibaut, che rimane obiettivamente un unicum e un mistero, altrettanto devo precisare che proprio quel genere di letteratura, che ho ricordato prima, ha inquinato – mi si passi il termine – le sorgenti di una sana e obiettiva ricerca e dibattito scientifico, rivestendole di una vena sensazionalistica. Giornalisticamente parlando. Ricordo a questo proposito che proprio mons. Nicola Bux, anni orsono, in un’intervista rilasciata al giornalista Aldo Maria Valli, invitava, piuttosto che a soffermarsi sugli errori – veri o presunti – ascrivibili a Francesco (non spetta a me giudicare!), a esaminare e «studiare più accuratamente la questione relativa alla validità giuridica della rinuncia di Benedetto XVI, se cioè essa sia piena o parziale (“a metà”, come qualcuno ha detto) o dubbia, giacché l’idea di una sorta di papato collegiale mi sembra decisamente contro il dettato evangelico. Gesù non disse, infatti, tibi dabo claves rivolgendosi a Pietro e ad Andrea, ma lo disse solo a Pietro! Ecco perché dico che, forse, uno studio approfondito sulla rinuncia potrebbe essere più utile e proficuo, nonché aiutare a superare problemi che oggi ci sembrano insormontabili» (465). In fondo è ciò che gli storici e i canonisti svolgono da sempre. È assolutamente normale. A questo proposito, mi sento di suggerire un interessante contributo apparso quasi un decennio fa sulla rivista «Chiesa e storia» dell’Associazione italiana di professori di storia della Chiesa. In questo saggio di Antonio Menniti Ippolito si ripercorre un po’ la storia dei pontificati interrotti e di quelli cancellati. Segnatamente si ricordano gli studi del celebre Louis Duchesne e di altri storici della Chiesa, grazie ai quali si è giunti all’espunzione dall’Annuario Pontificio (ovverosia dalla cronotassi dei Pontefici) di alcune figure sino ad allora considerate come facenti parte dell’elenco dei vescovi di Roma, tanto che l’Autore ha parlato del papato come caratterizzato da «una continuità assai discontinua» (466). Tornerò in seguito su questo punto assai interessante della storia della Chiesa. Più che normale, dunque, che gli storici e i canonisti si interroghino in un dibattito scientifico sulla legittimità di un papa o sulla validità della sua rinuncia (467). Quel che danneggia la serietà della ricerca storico-giuridica è proprio la letteratura di stampo cospirazionista, che è nemica di una seria analisi documentale, la quale porta a far dire a documenti ciò che essi non dicono o a ricostruirne contenuti attingendo non già alle fonti oggettive, bensì facendosi guidare – se così posso dire – dal pregiudizio di dover, per ovvie ragioni di marketing, cercare conferme alla propria ricostruzione complottista, rifiutando così quelle evidenze più semplici e ovvie e inseguendo piuttosto soluzioni quantomeno ardite, per non dire fantasiose. Fatta questa doverosa premessa, veniamo al caso di Benedetto XVI, vicenda della quale mi sono occupato sin dal 2013. A seguito della “rinuncia” del defunto Papa, si è venuta a creare una situazione unica e singolare, per non dire inedita, nella Chiesa, mai verificatasi in precedenza: vale a dire la creazione anomica ed ex nihilo della figura – del tutto ignota alla canonistica e alla storia del papato – del papato emerito, sulla falsariga della figura del vescovo emerito. Bisogna dire, stando a quanto riferito da taluni, che Papa Benedetto XVI avrebbe preferito essere chiamato semplicemente Vater Benedikt, Padre Benedetto (468), ma poi avrebbe ceduto alle insistenze altrui a conservare il titolo di “papa”, affiancandolo a quello di “emerito”. Apparentemente, il Papa, in qualità di vescovo della diocesi di Roma, rinunciando o perdendo il suo ufficio, al pari di qualsiasi altro vescovo diocesano o ufficiale ecclesiastico, dovrebbe divenire “emerito”. Non si vede dunque perché il vescovo di Roma dovesse ricevere un trattamento diverso da quello di un arcivescovo di Milano o di qualsiasi altra diocesi. Deporrebbero in questo senso – sempre apparentemente – alcune disposizioni della codificazione canonica latina, che farebbero pensare come le stesse si applicherebbero anche al vescovo di Roma, non essendo previste dalle stesse delle eccezioni o delle norme derogatorie rispetto a quelle ordinarie (469). Un trattamento a sé, la codificazione del 1990 la riserva ai Patriarchi, i quali, a norma del Codice dei canoni delle Chiese orientali, non diventano «emeriti», ma conservano titoli e onori, soprattutto in ambito liturgico (470). Detto questo, dunque, sì, la figura del Papa emerito è sostanzialmente una novità nella storia della Chiesa, sebbene – a onore del vero – c’era stato, poco prima dell’atto compiuto da Benedetto XVI, un canonista polacco che aveva avanzato l’ipotesi che il Papa rinunciante al suo ufficio assumesse la veste del “papa emerito”. Questo canonista, consulente della conferenza episcopale polacca, in un’opera collettiva (un dizionario) di diritto canonico, pubblicata dall’Università di Navarra nel 2012, compilando la voce Renuncia del Romano Pontífice, si interrogava su quale fosse lo statuto del Pontefice rinunciante, concludendo che non ci fossero ragioni ostative nel considerarlo “papa emerito” (471), al pari di qualsiasi altro Ordinario diocesano. Ovviamente, l’autore non immaginava che quella sua indicazione di lì a pochi mesi avrebbe trovato attuazione concreta e reale! Di là della terminologia, comunque, il problema giuridico resta, non essendo stato risolto da Benedetto XVI e ancor meno da Francesco, che, stando a una sua recente intervista, avrebbe escluso la possibilità di una regolamentazione dello statuto giuridico del Papa regnante, nonostante ciò fosse richiesto a gran voce da autorevoli canonisti (472). Il terreno però è parecchio scivoloso, essendo implicati non solo profili giuridici, ma anche storici e soprattutto teologici. Questo in quanto l’ufficio papale non è un mero ufficio amministrativo, ma è un istituto di diritto divino, che presuppone una sorta di cooperazione dell’elemento umano con quello divino. Per cui vi è una difficoltà oggettiva a normare su un siffatto statuto. Certo, se s’intendesse l’ufficio papale in senso puramente umano e, diciamo, orizzontale, il papato potrebbe essere assimilato a qualsiasi altro ufficio, ma, in una prospettiva di fede, esso, invece, è connaturato, come detto, non solo dall’elemento umano, ma pure da quello divino. Mi ha chiesto se ci siano dei precedenti specifici alla figura del papa emerito. La mia risposta è negativa. Storicamente abbiamo avuto qualcosa che molto lontanamente si avvicinava al papato emerito, ma che certamente non è ad esso paragonabile. È significativo ricordare l’illustre precedente a cui Benedetto XVI si sarebbe ispirato, vale a dire quello di Pietro da Morrone, già Celestino V: in quel caso, Celestino chiese – una volta rinunciato al papato – di continuare a indossare i paramenti pontificali durante la celebrazione della Messa, cosa che gli fu respinta dal cardinale protodiacono Matteo Rosso Orsini, proprio per non ingenerare il dubbio che la rinuncia non fosse stata plena (473). Qualche similitudine, forse, potremmo rinvenirla con la vicenda dell’antipapa Amedeo VIII di Savoia, che assunse il nome di Felice V? Rinunciato al suo (anti)papato il 9 aprile 1449, il concilio di Losanna – che era il proseguo di quello di Basilea – ratificò il 16 aprile di quello stesso anno, con due decreti, la rinunzia di Felice V con tutte le clausole e condizioni, che erano state convenute col papa Niccolò V (474). Queste condizioni, che furono oggetto di serrate trattative tra le parti, prevedevano la creazione a cardinale di Amedeo, nonché l’attribuzione della sede suburbicaria di Sabina, la legazia apostolica nei territori transalpini (Piemonte, Monferrato, Saluzzo, Contea d’Asti, ecc.) nonché altri privilegi, quali l’attribuzione della dignità di primo prelato dopo il Papa, il privilegio del bacio dell’anello (anziché della pantofola) e la conservazione di alcuni ornamenti papali (475). A me sembra che questo caso storico non si adatti affatto a quello di Benedetto XVI, non foss’altro perché i titoli concessi all’ex antipapa erano comunque attribuzioni graziose del pontefice regnante Niccolò V, sebbene fossero state concordate con il rinunciante e anzi costituissero le condizioni a cui Felice V accettò di lasciare il Seggio petrino, su cui si era assiso in maniera piratesca, diciamo così. Nel caso di Benedetto XVI, oltre agli “ornamenti papali”, aveva conservato anche i relativi titoli, insegne e nome (476). Per giunta, tali “ornamenti” non furono concessi dal Successore, ma furono autoattribuiti a se stesso dal medesimo papa Ratzinger, il quale, precisava, avrebbe conservato un non chiarito «mandato spirituale», avendo abdicato a quello «legale». Forse un precedente potrebbe trovarsi risalendo all’ultima rinuncia prima di Benedetto XVI, cioè a quella di Gregorio XII? Questi, dopo aver abdicato a mezzo del suo procuratore Carlo I Malatesta, signore di Rimini, il 4 luglio 1415 (477), con due distinte bolle del 10 e del 17 luglio di quell’anno si riservava l’ufficio rispettivamente di Camerario (478) – potendo così accedere, in tale veste, al tesoro papale – e quello di cardinale (479). Pure in questo caso, la vicenda di Gregorio XII non può essere assunta a precedente del papato emerito di Benedetto XVI. Onde comprendere come non si fosse dinanzi ad alcun “papato emerito” nel caso di Gregorio XII, vanno inquadrati gli eventi della sua rinuncia. Il Papa Gregorio, che pur aveva tentato di tutto per mantenere il papato nelle sue mani (480), aveva conferito al Malatesta, nel marzo 1415, una procura irrevocabile con promessa di rato e valido a rinunciare all’ufficio papale quando gli sarebbe parso opportuno, delegando, al contempo, propri rappresentanti (il card. Giovanni Dominici e Giovanni patriarca di Costantinopoli) la potestà di (ri-)convocare a suo nome il concilio (481), che, in effetti, era già aperto sin dal novembre 1414 a Costanza su convocazione dell’antipapa Giovanni XXIII Cossa. In questa maniera, quel Concilio era legittimato quale vero Concilio ecumenico della Chiesa, a condizione che non vi assistesse Giovanni XXIII. La bolla di convocazione fu letta il 4 luglio dal card. Dominici, durante la XIV Sessione conciliare, le due obbedienze – quella pisana e quella romana – si riunirono (482) e il Malatesta lesse l’atto di rinuncia di Gregorio, che fu accettato dal sinodo (483). Ma il Papa non sapeva ancora dell’avvenuta lettura dell’atto abdicativo da parte del suo procuratore. Un decreto del Concilio ratificava nondimeno quanto compiuto da Gregorio nella sua obbedienza (484) e quanto avrebbe compiuto sino a quando non gli fosse pervenuta comunicazione dell’avvenuta rinuncia, che gli giunse in effetti solo quindici giorni dopo, il 19 luglio. Sino a quella data compì alcuni atti: con bolla del 9 luglio destituì il nipote, card. Antonio Correr, vescovo della diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina, dalla carica di camerlengo, sebbene non si conoscano le ragioni di tale atto (485), assumendo in proprio l’ufficio, senza privarlo della carica di vescovo di Porto; il 10 luglio emanava una bolla con cui si attribuiva la carica di Camerario e il 17, con una nuova bolla, si ricreava cardinale qualora fosse letta la sua rinuncia e accettata (486). Solo il 19, come abbiamo ricordato, gli giunse la notizia dell’avvenuta lettura dell’atto di rinuncia (487). Per cui, in un concistoro, il giorno seguente, si spogliava delle insegne papali e indossava le vesti cardinalizie, confermando tutto l’operato del Malatesta (488). La notizia di questo gesto giunse a Costanza il 3 agosto seguente. Il 7 ottobre di quell’anno, Angelo Correr, già Gregorio XII, scrisse al Concilio, da un lato, scusandosi del ritardo con cui gli avevano annunciato l’ambasciata da Costanza, dall’altro, confermando di aver attribuito e conferito al Concilio ogni potere necessario e che, perciò, intendeva sottomettersi a esso, e, dall’altro, ringraziando della dignità che il Concilio gli aveva voluto attribuire. Alla fine, perciò, il Correr considerava le bolle del 10 e del 17 superate da quanto aveva, in precedenza, stabilito il Concilio, ma che a lui non era ancora noto in quel momento. E si firmava col titolo di cardinale-vescovo, senza specificare il titolo (489). Può concludersi, quindi, che l’auto-attribuzione di Papa Gregorio XII per il tempo della sua rinuncia fosse stata ratificata e approvata dal Concilio, a cui era stato conferito ogni potere dallo stesso Gregorio, all’epoca papa legittimo. Si trattava, in fondo, di una concessione del Concilio nei riguardi dell’ex Pontefice. Nessun papato emerito, dunque. Il nuovo istituto di Papa emerito creato da Benedetto XVI costituiva davvero una novità. Altro è vedere se questo titolo fosse o no ammissibile nell’ordinamento canonico. Certo è che, da questo punto di vista, aveva perfettamente ragione mons. Georg Gänswein, già segretario di Benedetto XVI, a definire, in modo sibillino e forse riecheggiando lo stesso Ratzinger (490), «questa situazione nuova [dopo la “rinuncia” di Benedetto XVI] come una sorta di stato d’eccezione voluto dal Cielo» (491), qualificando, dunque, tale condizione, appunto, come Ausnahmepontifikat, pontificato d’eccezione (492). Mi sia permessa una piccola chiosa finale. L’amico Guido Ferro Canale commenta quest’espressione in questo modo: «“Aus-nahme” significa, letteralmente, “fuori-legge”. Uno stato di cose che non può essere regolato a priori e quindi, se si verifica, obbliga a sospendere l’intero ordinamento giuridico. Un “Ausnahmepontifikat”, dunque, sarebbe un pontificato che sospende, in qualche modo, le regole ordinarie di funzionamento dell’ufficio petrino o, come dice Gänswein, “rinnova” l’ufficio stesso. E, se l’analogia corre, questa sospensione sarebbe giustificata, o piuttosto imposta, da un’emergenza impossibile ad affrontarsi altrimenti» (493). Joseph Ratzinger è stato, a mio modesto avviso, molto idolatrato – forse troppo – dai gruppi conservatori della Chiesa cattolica (o “tradizionalisti”, come si suol dire), a causa della sua oggettivamente grandiosa produzione letteraria. Eppure, non dobbiamo dimenticare che la parabola di Ratzinger è stata molto particolare: da modernista, nonché amico intimo del teologo gesuita e modernista tedesco Karl Rahner, a defensor della Tradizione cattolica, fino a diventare il papa del motu proprio Summorum Pontificum, celebre per aver concesso ai sacerdoti la libertà di celebrare nella forma straordinaria del rito romano senza chiedere permesso al proprio vescovo. Molte delle idee teologiche sviluppate in gioventù non sono mai state davvero superate da Ratzinger. In realtà, il concetto di “papato emerito” risale al tempo dell’ultimo Concilio, e trova proprio in Rahner uno dei suoi ispiratori. Sì, in effetti, anche io
credo che tutte queste teorie cospirazioniste, che circolano circa la
validità o meno della sua “rinuncia”, si fondino su una generica
e pregiudizievole sopravvalutazione delle intenzioni di Benedetto
XVI.
A me sembra che, probabilmente – e questa è solo un’ipotesi – Papa Ratzinger, con la creazione ex nihilo di questa figura inedita – al di là delle notazioni storiche pur avanzate autorevolmente circa l’imitazione di Benedetto da Norcia e dei papi-monaci dell’XI sec., che «avevano concepito il papato al pari di un abbas universalis che deve guidare, nutrire e pascere il gregge affidatogli da Cristo» (494) – abbia voluto seguire, in fondo, le suggestioni proposte dal suo grande ed (ex) amico Karl Rahner (495). Questi, in effetti, sin dalla fine degli anni Sessanta (496), e poi ancora nel 1974 in un piccolo libello di una novantina di pagine (497), proponeva l’idea, rilanciata in Italia dalla Scuola teologica di Bologna di Alberigo e, più di recente, da altri, pur autorevoli, canonisti, che il papato fosse il grado supremo del sacramento dell’ordine (il quarto), per cui l’ordinazione relativa del Papa per la sede primaziale sarebbe un’ordinazione episcopale specifica infondente un carattere indelebile (498). Per conseguenza sarebbe rinunciabile la sede di Roma, ma non quella sorta di imprinting sacramentale, che si assumerebbe col papato. Che possa essere questa l’idea sottesa alla creazione di quest’inedita figura, lo sospettava persino il prof. Roberto De Mattei, il quale pur sempre difendendo la validità della rinuncia, scriveva in un suo saggio: «Se il Papa che rinuncia al pontificato mantiene il titolo di emerito, vuol dire che in qualche misura resta Papa. È chiaro infatti che nella definizione il sostantivo prevale sull’aggettivo. Ma perché è ancora Papa dopo l’abdicazione? L’unica spiegazione possibile è che l’elezione pontificia gli abbia impresso un carattere indelebile, che non si perde con la rinuncia. L’abdicazione presupporrebbe in questo caso la cessione dell’esercizio del potere, ma non la scomparsa del carattere pontificale. Questo carattere indelebile attribuito al papato può essere spiegato a sua volta solo da una visione ecclesiologica che subordini la dimensione giuridica del pontificato a quella sacramentale. È possibile che Benedetto XVI condivida questa posizione, […] ma l’eventualità che egli abbia fatta propria la tesi della sacramentalità del papato non significa che essa sia vera» (499). Ci ricordava ancora lo stesso Autore: «Il teologo Joseph Ratzinger […] pur non condividendo la concezione di Hans Küng di una Chiesa carismatica e de-istituzionalizzata, si è allontanato dalla tradizione quando ha visto nel primato di Pietro la pienezza del ministero apostolico, legando il carattere ministeriale a quello sacramentale» 500) Se tali influenze rahneriane siano conformi alla fede cattolica circa la natura giuridico-teologica del papato, così come si è venuta stratificando nel corso dei millenni, lo lasciamo valutare ad altri. Certo è che, comunque, un eletto al Sommo Pontificato, di fatto non riceva alcuna unzione né alcuna consacrazione. Sempre De Mattei ci rammentava, nel saggio innanzi citato: «Il Papa non è […] un supervescovo, né il punto di arrivo di una linea sacramentale che dal semplice prete, passando per il vescovo, ascende al sommo pontefice. L’episcopato costituisce la pienezza sacramentale dell’ordine e dunque al di sopra del vescovo non esiste alcun carattere superiore che possa venire impresso. Come vescovo il Papa è uguale a tutti gli altri vescovi. Ciò per cui il Papa sovrasta ogni altro vescovo è la missione divina che da Pietro si trasmette ad ogni suo successore, non per via ereditaria, ma attraverso l’elezione legittimamente svolta e liberamente accettata. […] Il primato del Papa non è sacramentale ma giuridico. Esso consiste nel potere pieno di pascere, reggere e governare tutta la Chiesa, ossia nella giurisdizione suprema, ordinaria, immediata, universale e indipendente da ogni altra autorità terrena» (501). In un altro, più recente contributo rispetto al primo, lo stesso Autore, pur considerando valida la rinuncia ratzingeriana, nondimeno aggiungeva: «[…] Benedetto XVI, dopo aver rinunciato al pontificato conserva il nome, mantiene la veste bianca, impartisce la Benedizione Apostolica, che spetta solo al Sommo Pontefice e rompe ancora una volta il silenzio a cui si era votato dimettendosi. In una parola si considera Papa, sia pure “emerito”. Questa situazione è la conseguenza di un grave errore teologico del cardinale Ratzinger. Conservando il titolo di Papa emerito, come avviene per i vescovi, egli sembra ritenere che l’ascesa al Pontificato imprima sull’eletto un carattere indelebile analogo a quello sacerdotale. In realtà i gradi sacramentali del sacerdozio sono solo tre: diaconato, presbiterato ed episcopato. Il pontificato appartiene ad un’altra gerarchia della Chiesa, quella di giurisdizione, o di governo, di cui costituisce l’apice. Quando viene eletto, il Papa riceve l’ufficio della suprema giurisdizione, non un sacramento dal carattere indelebile. Il sacerdozio non si perde neanche con la morte, perché sussiste “in aeternum”. Si può invece “perdere” il pontificato, non solo con la morte, ma anche in caso di volontaria rinuncia o di manifesta e notoria eresia. Se rinuncia ad essere pontefice, il Papa cessa di essere tale: non ha diritto a indossare la veste bianca né ad impartire la benedizione apostolica. Egli, dal punto di vista canonico, non è neanche più un cardinale, ma torna ad essere un semplice vescovo» (502). Forse un tempo, a onor del vero, si poteva essere indotti nell’erronea menzionata convinzione perché il papato era inaugurato con l’imposizione, da parte del cardinal protodiacono, in una suggestiva e toccante cerimonia, ricca di simbolismi, della tiara con la triplice corona, a significare le tre potestà (coelestium, terrestrium, et infernorum), alle parole: «Accipe Tiaram tribus coronis ornatam, et scias Te esse Patrem Principum et Regum, Rectorem Orbis, in terra Vicarium Salvatoris N. J. C. cui est honor et gloria in saecula saeculorum». Incoronazione, che poteva far pensare, effettivamente, a una sorta di consacrazione dell’eletto nella sua nuova veste papale. Ancora Paolo VI – l’ultimo pontefice a essere incoronato – prevedeva, del resto, al n. 92 della Cost. Ap. Romani Pontifici eligendo del 1975: «Il Pontefice sarà incoronato dal cardinale protodiacono e, entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto». È significativo ma né Giovanni Paolo I né Giovanni Paolo II furono incoronati, sebbene la norma vigente all’epoca – quella di Montini – prevedesse il rito di incoronazione. Semplicemente, in via di fatto, questa fu abbandonata (503) Tale prassi è stata in seguito codificata dallo stesso papa Wojtyla con la sua Cost. Ap. Universi Dominici gregis [d’ora innanzi per brevità UDG] che, al n. 92, ha previsto una più sobria celebrazione di Messa di inizio del pontificato: «Il Pontefice, dopo la solenne cerimonia di inaugurazione del pontificato ed entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto». Nell’Ordo Rituum pro Ministerii Petrini initio Romae Episcopi (approvato dallo stesso Benedetto XVI nel 2005), tuttavia, il neo-eletto al Sommo Pontificato riceve l’anello piscatorio e il pallio, rispettivamente dal decano del Collegio cardinalizio e dal cardinale protodiacono. Comunque si vogliano intendere questi gesti, siamo ben lontani, tuttavia, da un rito che possa far pensare a una consacrazione episcopale!!! In ogni caso, certo è che un’idea erronea sul papato (di cui lo stesso De Mattei ci dà conto), che abbia comportato un altrettanto nuova figura giuridica non contemplata né dal diritto divino e, tantomeno, dal diritto umano positivo, dovrebbe portare a nutrire dei dubbi circa la validità della rinuncia ridondando quest’errore sulla sostanza dell’atto, come prevedono, del resto, i cann. 126 della codificazione della Chiesa latina e 933 del codice dei canoni delle Chiese orientali (504). Per cui, sembra potersi escludere l’idea che potessero coesistere due papi contemporaneamente, uno regnante e uno emerito, venendo meno l’idea stessa di unità della Chiesa sotto un solo Pastore. Solo a uno Cristo ha detto: Ti chiamerai Pietro! Con la rinuncia, se valida, l’ufficio primaziale (di diritto divino) e quello di vescovo di Roma e capo del collegio episcopale (di diritto umano), riunificati nella medesima persona, cessano, essendo per loro natura, non scindibili. È significativo, ma Ratzinger, nella sua Declaratio, affermava: «dichiaro di rinunciare al ministero di vescovo di Roma, Successore di San Pietro», non dunque propriamente anche all’ufficio primaziale. Qui apriremmo, però, un mare magnum di altri interrogativi sulla già problematica “rinuncia” del papa tedesco. A questo proposito, segnalo solo un dettaglio. Nella lettera di rinuncia predisposta da Paolo VI, che pure solleva qualche interrogativo (come vedremo), papa Montini dichiarava, leggo testualmente: «di rinunciare al nostro sacro e canonico ufficio sia come vescovo di Roma sia come Capo della medesima santa Chiesa cattolica […]» (505). Paolo VI, che aveva anche una formazione giuridica avendo frequentato in gioventù, in Gregoriana, i corsi di diritto civile e diritto canonico, sapeva bene che si dovesse rinunciare sia alla sede romana sia all’ufficio primaziale di Capo della Chiesa cattolica. E qui mi fermo, lasciando ad altri il compito di approfondire quest’ulteriore, e sinora non ancora investigato, aspetto. 3. Secondo alcuni, Benedetto XVI avrebbe voluto inviare un messaggio di “sede impedita”. Cosa significa questa espressione? Ci sono stati momenti nella storia della Chiesa di “sede impedita”? E se sì, quali sono state le conseguenze? Uno dei cavalli di battaglia di queste tesi cospirazioniste è appunto l’affermazione della sede impedita. In buona sostanza, secondo queste teorie, Benedetto XVI sarebbe stato indotto a compiere la sua “rinuncia” perché impedito nel governare. A riprova di questo, si sostiene, vi sarebbero alcuni video nei quali si mostrerebbe il defunto Papa Ratzinger recarsi in Germania, in visita pastorale, nel 2011, e lì non venire salutato dai vescovi presenti, i quali ometterebbero persino di porgergli la mano per i saluti. O ancora si argomenta circa le macchinazioni della finanza, che avrebbero portato all’inizio del 2013 all’esclusione dal sistema swift, cioè il sistema di transazioni finanziarie globali, della banca vaticana dello IOR, e al conseguente blocco delle carte di credito e bancomat vaticani (506). Il sistema sarebbe stato ripristinato esattamente il giorno dopo la “rinuncia” (507). Per cui, Benedetto XVI sarebbe stato obbligato a “rinunciare” e sarebbe riuscito – come una sorta di Machiavelli ecclesiastico – a “sabotare” il piano di non chiariti – sinora – nemici interni ed esterni al Vaticano, che avrebbero voluto piazzare il cardinal Bergoglio sul soglio petrino. Francamente anche questa tesi non mi ha mai convinto. Ma cosa s’intende per Sede Apostolica impedita? Il can. 335 (analogo è il can. 47 del Codice dei canoni delle Chiese orientali) evoca una situazione di Sede Apostolica impedita: «Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze». Queste leggi speciali non sono state mai promulgate. A parte la costituzione UDG di Giovanni Paolo II. Proprio in ragione di questa lacuna normativa, c’è stato un gruppo di canonisti, che vede da parte italiana particolarmente attiva e sensibile sul tema la prof.ssa Geraldina Boni dell’Università di Bologna, che si sta adoperando da qualche tempo nella formulazione di una proposta di legge canonica, per colmare una lacuna dell’ordinamento della Chiesa, sia qualora la Sede Apostolica fosse impedita temporaneamente sia qualora l’impedimento fosse permanente e irreversibile. Tale esigenza, avvertita da questi studiosi, nascerebbe dalla necessità di risolvere alcune problematiche, anche di carattere pratico: da un lato, vi sarebbe una ragione legata ai mutamenti intervenuti nella scienza medica, che consente, anche a un soggetto in condizioni fisiche precarie e fortemente compromesse, di poter protrarre la sua esistenza anche per anni, in coma, in stato vegetativo e di minima coscienza; dall’altro, si vorrebbero offrire soluzioni giuridiche adeguate nel caso in cui un pontefice, per motivi di anzianità o di salute, non possa o ritenga di non poter svolgere più il proprio ministero. Ora, la sede sarebbe impedita – come recita il can. 412, relativo ai vescovi – si ha a precise condizioni: «se il vescovo diocesano è totalmente impedito di esercitare l’ufficio pastorale nella diocesi a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani». I casi contemplati dalla codificazione canonica, dunque, almeno con riguardo ai vescovi diocesani, concernono la prigionia, il confino, l’esilio o l’inabilità. E qui c’è già una bella differenza: volendosi applicare il menzionato canone nel caso di Benedetto si vedrà che siamo al di fuori dell’ambito applicativo della disposizione, poiché Papa Ratzinger non ci risulta che fosse prigioniero o al confino o in esilio o fosse inabile fisicamente o psicologicamente (non avendo, all’epoca, patologie talmente invalidanti da renderlo inabile) né, soprattutto, che gli fosse preclusa la possibilità di comunicare per lettera con i fedeli. Già dalla quieta lettura della disposizione in discorso, la tesi della sede impedita non è sostenibile. C’è poi da aggiungere che, in assenza di una legge speciale, sebbene la questione sia dibattuta, non potrebbe farsi riferimento in via analogica a quanto avviene ai vescovi diocesani. E questo proprio perché la figura del Papa non è quella di un semplice vescovo, essendo egli capo del Collegio episcopale, successore di Pietro e Capo visibile della Chiesa (508). La disciplina, per quanto riguarda i vescovi diocesani, prevede che, qualora il vescovo fosse impedito, salvo che la Santa Sede non provveda altrimenti, la cura della diocesi sia svolta da un amministratore (che può essere, se previsto, il vescovo coadiutore o ausiliare, un vicario generale o altro sacerdote a ciò designato) (cann. 413 ss.). Non mi pare che Papa Ratzinger, assuntamente impedito, avesse provveduto in tal senso – ammesso che questa disciplina sia applicabile al papato. Insomma, sebbene la codificazione del 1983 consideri astrattamente possibile l’impedimento della Sede Apostolica per infermità del Papa (nel can. 335), tuttavia l’assenza di una disciplina specifica rende non applicabile, a mio avviso, quanto previsto per i vescovi, stante le peculiarità del papato. Ci son stati dei casi di Sede Apostoliche impedite? La risposta è affermativa. Sin dai primi secoli, ci sono stati casi di sedi impedite. Il primo caso che mi viene in mente è quello di Papa Clemente I, che deve considerarsi il primo Pontefice rinunciatario della storia. Egli, infatti, sarebbe morto martire tra il 99 e il 100 d.C. nel Chersoneso, ma già nel 97 risultava eletto il successore, Evaristo. Per cui, verosimilmente Clemente dovrebbe aver rinunciato al papato all’epoca in cui fu condannato all’esilio dall’imperatore Traiano, non potendo governare la Chiesa dal suo luogo di esilio così remoto. In seguito, ci sono stati altri casi di sedi impedite. Tra gli altri, mi piace ricordare quello di Papa Pio VI Braschi all’epoca della Rivoluzione francese e dell’occupazione napoleonica. Il Papa fu condotto in esilio in Francia. Egli, sebbene infermo, lasciò Roma per sempre il 20 febbraio 1798 e provvide, durante il suo esilio, al governo della Chiesa con i prelati Spina e Caracciolo, venuti con lui da Roma, mentre aveva lasciato nell’Urbe come proprio delegato apostolico il suo fedele collaboratore monsignor Michele Di Pietro, vescovo titolare di Isauropoli (e futuro cardinale), comunicandogli le facoltà apostoliche per il governo della Chiesa e degli affari spirituali (509). Come si vede, il Papa, allorché impedito, ha sempre provveduto alla nomina di un suo delegato per il governo della Chiesa. Per cui Papa Ratzinger, se davvero fosse stato impedito, avrebbe al più potuto designare un proprio delegato, salvo il supporre – ma siamo nella fantascienza – che Francesco sia proprio un suo delegato… Riguardo poi alle cause che avrebbero generato la presunta sede impedita, queste sono state ampiamente smentite, o per lo meno demitizzate nella loro portata, dalla letteratura non cospirazionista (510). Con riguardo ai vescovi tedeschi, che avrebbero omesso di porgere la mano in segno di saluto a Benedetto XVI, si ignora da parte dei cospirazionisti che quei prelati facevano parte del seguito papale e, quindi, essendo giunti con lui in Germania, venivano semplicemente presentati con un gesto della mano del Papa al presidente tedesco Christian Wulff (511). Del resto, anche a voler concedere che i presunti fatti lamentati fossero fondati, poteva dirsi, al più, che Benedetto XVI fosse ostacolato in alcuni suoi atti; ma l’essere ostacolati non vuol dire impediti, essendo i presupposti dell’ipotetico impedimento, in senso canonistico (facendosi riferimento al can. 412), ben diversi dal semplice ostacolo, ostruzionismo. Il tema del diverso utilizzo dei due termini è senz’altro uno tra quelli più scivolosi e certamente quello di maggior successo e presa delle teorie cospirazioniste riguardo all’atto di “rinuncia” di Papa Benedetto XVI. Mi si permetta di compiere un antefatto. Si sostiene da parte di queste teorie che l’atto di “rinuncia” sarebbe invalido poiché Papa Ratzinger non avrebbe – volontariamente – rinunciato al munus, ma solo al ministerium, laddove il can. 332 § 2 della codificazione canonica richiederebbe espressamente che il Papa rinunci al munus. Benedetto XVI, infatti, così si esprimerebbe nella celebre Declaratio Non solum del 10-11 febbraio 2013: «Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse» (512). La traduzione italiana, rinvenibile sul sito del Vaticano, così rende il testo: «Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice». Benedetto XVI, come si vede, espressamente menzionava il ministerium, ma non il munus petrinum. Di qui, appunto, secondo queste teorie, l’invalidità dell’atto abdicativo, perché il Papa non avrebbe rinunciato all’officium, ma soltanto alla sua concreta amministrazione, all’esercizio ministeriale petrino (513). A onor del vero anche un teologo, diciamo “periferico” in quanto sostenitore di posizioni non sempre ortodosse, come Vito Mancuso, all’indomani dell’atto compiuto da Papa Ratzinger, distingueva tra «essere papa» (il munus) e «fare il papa» (il ministerium), chiosando che Giovanni Paolo II, alla fine della sua vita, «non poteva fare il Papa, ma lo era, e ciò bastava», mentre Benedetto, non avendo più le forze per “fare il papa” avrebbe inteso cessare pure di “essere papa” (514). Da parte questa incoerente conclusione del teologo (rispetto alle premesse da cui muoveva), è indubbio che l’utilizzo dei due termini abbia fatto sorgere il dubbio in più di un osservatore. Questo è in sintesi l’argomento in questione. Taluno, per la verità, non esita a ritenere l’atto compiuto da Benedetto, discostandosi dalla codificazione canonica, come «un precedente giuridico innovativo nella storia della Chiesa» (515) e per certi versi rivoluzionario, perché nell’ambito della potestà papale dovrebbe riconoscersi la facoltà, libera e insindacabile, di rinunciare a tutte le potestà senza rinunciare al munus (516). Il Papa, quindi, avrebbe operato un vero e proprio smembramento tra munus – a cui non avrebbe abdicato – e l’esercizio dell’incarico medesimo, a cui avrebbe rinunciato ingravescente aetate e che comprende l’azione e il magistero. Onestamente questa tesi non mi ha mai convinto. Sebbene sia vero che, nel linguaggio canonistico ed ecclesiastico in genere, i due termini, a stretto rigore, esprimano realtà differenti, tuttavia, va subito osservato che nella codificazione piano-benedettina del 1917 non si richiedeva, ai fini della validità della rinuncia, alcuna menzione del munus. Leggo nel can. 221 del 1917: «Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio». Traduco: «Se accade che il Romano Pontefice rinunci [al suo ufficio], per la validità di tale rinuncia non è necessaria né l’accettazione dei cardinali né di altri». Il codice del 1917, dunque, era molto più semplice, non richiedendo alcuna rinuncia al munus. Già questa circostanza dovrebbe far intendere la non essenzialità, nell’atto di rinuncia, dell’uso di questo lemma. C’è di più. Come notava quasi venti anni fa l’allora prof. Juan Ignacio Arrieta, insigne canonista, dopo il concilio Vaticano II, a causa delle problematiche createsi a proposito della funzione pubblica nella Chiesa riguardo alla nozione di ufficio, si è assistito a un – leggo testualmente – «fluttuante impiego di nozioni come “munus”, “ministero” ed “ufficio” sia in dottrina che nei testi ufficiali della Chiesa». Lo stesso Autore annotava che tali nozioni «non trovano univoco contenuto sia nei due codici di diritto canonico latino [quello di diritto canonico e quello dei canoni delle Chiese orientali, N.d.R.] che nei documenti del concilio Vaticano II, e che spesso risultano espressioni usate indistintamente in uno stesso contesto» (517). Mi pare assai significativo, del resto, quanto insegnava l’attuale card. Erdő, che è forse tra i canonisti che più hanno approfondito il tema in discorso. Spiegava quest’insigne autore in un suo interessante contributo: «Il ‘‘ministerium’’, il ‘‘munus’’ e l’“officium” sono in gran parte sinonimi. Come termini tecnici, a eccezione dell’“officium”, esse vengono raramente usate nel diritto canonico. Dopo la promulgazione del CIC 1917, tuttavia, appaiono alcune di queste parole nei testi normativi della Chiesa con significati che non figuravano ancora nel Codice Pio-Benedettino. Altre parole di questo gruppo, che avevano un valore tecnico già nel linguaggio del CIC 1917, hanno ottenuto in seguito altri significati tecnici, o persino una nuova definizione legale. In questi cambiamenti si esprimono, secondo gli autori, certe nuove questioni circa la potestà nella Chiesa, circa la possibilità di partecipare o cooperare nell’esercizio della medesima, circa la partecipazione dei fedeli alla triplice missione (anzi, ai “tria munera”) di Cristo, ecc. Tutte queste sono delle questioni teologiche e pratiche che riguardano tra l’altro la possibilità di affidare diverse funzioni pubbliche della Chiesa ai fedeli laici. Ma oltre a questi punti, dei quali, oggidì, si parla parecchio, sorgono anche altre domande che riguardano il modo di organizzare le funzioni pubbliche della Chiesa» (518). Nel suo lavoro, il card. Erdő commentava, poi, i diversi significati assunti dalle tre parole indicate sia nella codificazione del 1917 sia nei documenti del Vaticano II sia, infine, nel codice di diritto canonico del 1983 (519). Fatta questa breve considerazione, venendo al caso di Benedetto XVI, come osservava la prof.ssa Geraldina Boni dell’Università di Bologna, «il Pontefice che ha rinunciato conserva il munus ricevuto con la consacrazione episcopale la quale non può essere vanificata ed annientata. […] Egli può rinunciare all’“ufficio” di Papa: per questo nel can. 332 § 2 avrebbe forse dovuto comparire il vocabolo officium, e comunque così è reso nelle varie lingue nazionali; ed infatti il vescovo diocesano è invitato dal can. 401 a rinunciare all’officium» (520). Aggiungeva ancora l’Autrice che, pertanto, «nel can. 332 § 2, in quel “muneri suo renuntiet” – ove il suo sottintende la titolarità dell’ufficio, munus è utilizzato (ci si consenta un certo grado di ‘approssimazione’) non in senso ‘sacramentale’, ma ‘giuridico’, […] pressoché equipollente a officium […] la cui rinuncia innesca il processo di provvista dello stesso. E tuttavia, in quella sede, munus, […] oltre a non essere per nulla anfibologico, […] non solo reca su di sé la caratura di un’antica e veneranda tradizione, che non può essere obliterata, ma veicola ancora una volta quell’inestinguibile valenza ministeriale della potestas del Papa che va esercitata governando. […] In definitiva, alla luce di questa duplice accezione di munus, Ratzinger, con la sua Declaratio, potrebbe avere voluto solo rammentare, e non già ben’inteso determinare, come, deponendo il munus quale ufficio, egli non si spogliasse del munus sacramentale: ciò che d’altronde non sarebbe in alcun modo rientrato nella sua facoltà di disposizione, a riprova che quello del Pontefice non è un potere assolutistico o totalitario, fluendo anzitutto entro gli argini delimitati dallo ius divinum. […] Questa intersecazione e fungibilità di significati in vocaboli pregni di implicanze teologiche oltre che giuridiche rispecchia certe tensioni intrinseche e in qualche misura ineluttabili tra gli elementi strutturali essenziali della Chiesa, e riflette e si alimenta altresì di quella realitas complexa della Chiesa irriducibile a qualsiasi altra societas […]» (521). Insomma, riportando il parere di questi autorevoli canonisti – e sottolineo questa loro qualifica a differenza di altri che si avvalgono di altre figure professionali, che, per quanto autorevoli nel loro ambito, non hanno dimestichezza con il diritto canonico – ho voluto sottolineare come discutere se il Papa avesse dovuto menzionare il munus e non il ministerium, dal punto di vista canonistico, è una strada senza sbocco. A mio sommesso avviso, se proprio avessimo voluto esaminare l’atto di “rinuncia” di Papa Ratzinger, penso che sarebbe stato più utile soffermarsi sulle parole riferite dal Pontefice in occasione della sua ultima udienza generale del 27 febbraio 2013. Purtroppo, sinora – e qui devo riconoscere un limite all’odierna canonistica – si è soffermata esclusivamente sulla Declaratio, toccando solo marginalmente le parole proferite in quell’udienza, non attribuendo a esse alcun significato (anche) giuridico. Questo è un grave limite, perché in quella udienza, il Papa se non una vera e propria contro-Declaratio (se così vogliamo chiamarla) (522), quantomeno manifestava la sua mens, la sua volontà in ordine alla Declaratio del 10 febbraio precedente e letta il giorno seguente, fornendone una sorta di interpretatio authentica. Cosa diceva Benedetto XVI in quella circostanza? Leggo: «Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento precisamente ora, che uno riceve la vita proprio quando la dona. Prima ho detto che molte persone che amano il Signore amano anche il Successore di san Pietro e sono affezionate a lui; che il Papa ha veramente fratelli e sorelle, figli e figlie in tutto il mondo, e che si sente al sicuro nell’abbraccio della vostra comunione; perché non appartiene più a se stesso, appartiene a tutti e tutti appartengono a lui. Il “sempre” è anche un “per sempre” – non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio» (523). Anni dopo, commentando in una serie di conversazioni con il giornalista e biografo dello stesso Pontefice, Peter Seewald, Papa Ratzinger osservava che quando «un padre smette di fare il padre», perché i figli son cresciuti e divenuti autonomi; «non cessa di esserlo, ma lascia le responsabilità concrete. Continua a essere padre in un senso più profondo, più intimo». Per questo – aggiungeva – il Papa «se si dimette mantiene la responsabilità che ha assunto in un senso interiore, ma non nella funzione» (524). In primo luogo, commentando brevemente queste parole, vorrei far notare che, contrariamente a quanto affermato da qualche autore con vena poetica, secondo cui il Benedetto XVI non avrebbe parlato di papato attivo e passivo, volendosi riferire semplicemente al suo nuovo stile di vita, improntato alla preghiera e alla contemplazione (525), in realtà, Papa Ratzinger, nel discorso del 27 febbraio, parlava esplicitamente non del suo nuovo stile di vita, ma della (nuova) dimensione del ministero petrino, affermando senza mezzi termini: «la mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo». Si discorreva, quindi, chiaramente di esercizio attivo del ministero petrino e che la rinuncia aveva toccato solo quest’aspetto (cioè l’azione e il magistero), lasciando l’altro, quello “non attivo” e contemplativo. Si tratta di espressioni significativamente oscure nel loro significato. Che dire di queste espressioni? Da parte la circostanza che la paternità del Papa, salvo il ritenere che essa abbia natura sacramentale e quindi il papato sia, in ultima analisi, il gradino sommo del sacramento dell’ordine sacro, non si caratterizza per essere indelebile, irrevocabile e assimilabile, in una certa qual misura, perciò, alla paternità scaturente da un vincolo di sangue o di adozione. Proprio perché trattasi di un officium ecclesiastico, essa cessa una volta che quell’ufficio sia venuto meno, divenendo, dunque, quegli che era Papa anch’egli figlio del nuovo Pontefice e affidato, come tutte le altre pecore del gregge, alla sua cura. Perciò, il paragone compiuto da Benedetto XVI mi pare problematico; al contempo denotava quella che era la sua mens, la sua volontà nella “rinuncia”: cioè abdicare a quello che egli aveva chiamato “papato attivo” e conservare quello che sarebbe il “papato passivo”. Di qui anche le ambiguità circa l’esistenza di due papi (526) o di un papato condiviso o collegiale (527). È corretto questo ragionamento? Per la verità è il § 2 del can. 332 che richiede che la rinuncia, affinché sia valida, oltre che essere libera, sia pure “debitamente manifestata”, in latino rite manifestetur, appunto. A tal riguardo vanno svolte alcune puntualizzazioni. In primo luogo, va ricordato che il latino utilizzato nell’ambito della Chiesa è una lingua un po’ diversa da quella classica. Un esempio potrà chiarire. È corretto dire: Sanctus Deus miserere nobis o miserere nostri? Sono corrette entrambe: la prima è il latino ecclesiastico, il secondo quello classico. Per cui, bisogna tener conto di questa peculiarità del latino. Esso, come qualsiasi altra lingua, inoltre, ha subito nel corso dei secoli dei mutamenti sia nella grammatica sia nella sintassi. Non spetta a me, ora, dire se Benedetto XVI fosse talmente esperto in lingua latina, al punto che, durante il Concilio Vaticano II, dialogasse con gli altri partecipanti al Concilio solo in quell’idioma, però posso dire, per esperienza personale, che quando una lingua – sebbene conosciuta nei minimi suoi reconditi – non sia praticata quotidianamente, allorché ci si trovi a dover costruire un testo, si commettono facilmente errori sia di sintassi sia di grammatica. Io conosco, per es., abbastanza bene la lingua francese, ma, poiché non mi capita di parlarci o di scriverci quotidianamente, se dovessi adesso scrivere in francese, penso che commetterei degli errori di sintassi e/o di grammatica. Analogamente suppongo possa essere avvenuto a Benedetto XVI, dando per vera la nomea che fosse un raffinato latinista e, comunque, può supporsi che egli avesse voluto prestare più attenzione al contenuto che alla forma (528). Questa considerazione esclude altresì che gli errori nella dichiarazione possano dirsi volontari. Fatta questa puntualizzazione e tornando alla domanda, devo dire che se si esaminassero le fonti canonistiche, si troverebbero non pochi provvedimenti nei quali sia sancita la nullità di questo o quell’atto per difetto della lingua latina. Tuttavia, quelle nullità per “corruzione della lingua latina” troverebbero la loro giustificazione nel passato laddove si voleva così garantire l’autenticità e la provenienza del documento (529). Oggi questo problema dovrebbe essere superato da quando esistono gli Acta apostolicae Sedis, che a norma del can. 8 § 1, è la gazzetta ufficiale della Sede apostolica, nonché, dal 2015, il Dicastero per la comunicazione. E infatti non ritroviamo nella codificazione canonica alcuna disposizione che sancisca, sia in generale sia in particolare, una qualche forma di invalidità per difetto della lingua latina. Per cui, affermare che l’atto di rinuncia possa essere stato invalido a causa degli errori di latino, mi sembra davvero un azzardo, salvo provarsi che quegli errori possano aver generato questioni giuridico-interpretative sulla (reale) volontà manifestata dal resignante. Ma di questo non è stata mai fornita alcuna prova. Veniamo propriamente al rite manifestetur. In realtà, quest’espressione in alcun modo vuole esprimere l’idea che l’atto di rinuncia sia impeccabile dal punto di vista della lingua. Nella traduzione italiana quel “rite” è reso con “debitamente”, sebbene il prof. Gigliotti preferisca renderlo “secondo le opportune usanze” (530). Comunque la si traduca, quella locuzione latina utilizzata dal Codex vuole semplicemente affermare la libertà del Romano Pontefice di scegliere la modalità in cui far conoscere alla Chiesa la sua decisione di voler rinunciare. Lo potrebbe fare per iscritto oppure oralmente in un discorso, attraverso i media o a viva voce, davanti al collegio cardinalizio – come fece Celestino V e come ripetuto ancora da Benedetto XVI – o in presenza di qualsiasi altra persona o gruppi di fedeli (531). Al fine, tuttavia, di garantire la certezza del contenuto dell’atto e quella del diritto, la volontà di rinuncia dovrebbe essere espressa in modo tale che ve ne sia traccia chiara e inequivocabile, e sia sempre possibile provarla, in modo tale da escludere qualsiasi dubbio. Ovviamente, una rinuncia dubbia od incerta causerebbe gravi problemi alla Chiesa. Questa stessa motivazione rende ragionevole che il Papa stesso esprima personalmente la sua decisione, senza la mediazione di alcun plenipotenziario (532). A questo proposito, significativamente, a differenza della precedente codificazione del 1917, il codice del 1983 non ammette più expressis verbis la possibilità che la rinuncia agli altri uffici possa essere fatta da un procuratore e devo dire che la questione è controversa. Ora, proprio quest’ultima circostanza porrebbe seri problemi nel caso di una rinuncia c.d. anticipata o condizionata al verificarsi di un grave impedimento (per es., di salute), che richiederebbe, appunto, che l’atto sia eseguito da un procuratore o l’avverarsi dell’evento sia verificato da un terzo soggetto. Ma questo tema esula propriamente dal tema della nostra conversazione. Per cui, si può concludere che chi attribuisse a quegli errori di latino di Benedetto XVI un valore invalidante della dichiarazione, mi sembra che sia decisamente fuori strada. A mio avviso, questo paragone non regge, perché un Papa, così com’è stato per tanti predecessori, avrebbe dovuto accettare – dando per vero, per mero espediente, che si fosse in “sede impedita” – piuttosto il martirio, l’esilio, ecc., anziché disperdere e confondere il gregge a lui affidato. Il Papa, infatti, ha il compito di confermare i fratelli nella fede, non di confonderli! Mi sovvengono gli esempi degli ultimi due papi, davvero martiri, cioè Pio VI e Pio VII. Entrambi, come ho già ricordato, rispettivamente sotto la minaccia giacobina-rivoluzionaria e napoleonica, piuttosto che abdicare o rinunciare, preferirono subire l’esilio. Si trattava, all’epoca, di tempi molto difficili per il Papa e per la Chiesa. A riprova, mi piace ricordare quanto scrive uno storico, in riferimento a Papa Pio VI Braschi: «Talleyrand, il potente ministro degli esteri [della Francia rivoluzionaria, N.d.R.], stese una relazione per il Direttorio in cui prospettava, in caso di rifiuto alle dimissioni da parte di Pio VI, di imprigionarlo, facendo poi diffondere la notizia della sua morte, per poi permettergli di tornare dopo la nomina del suo successore. Si pensò, insomma, molto seriamente, di scatenare uno scisma: il clero cattolico europeo in qualche modo aperto a riforme e a una qualche collaborazione con il mondo moderno avrebbe cercato di riunirsi intorno al “nuovo” Papa, mentre il clero irriducibile avrebbe combattuto contro di lui in nome del Pontefice legittimo. Gli anticlericali francesi erano così convinti di dare un colpo mortale alla Chiesa cattolica, paragonabile a quello che l’aveva ferita a seguito della riforma protestante del XVI secolo. Queste discussioni furono fatte conoscere al Papa, ed egli agì di conseguenza: inviò nel più assoluto segreto lettere a tutti i cardinali raggiungibili, suggerendo loro di radunarsi, in vista della sua morte, nella ex-Repubblica di Venezia, sotto la protezione austriaca» (533). Papa Braschi, gravato dagli anni al punto di non poter quasi più camminare, affrontò il duro esilio, morendo a Valence, nel Delfinato, il 29 agosto 1799. Sulla sua cassa un beffardo giacobino scrisse: «Cittadino Giannangelo Braschi. In arte papa Pio VI e ultimo». Quindi, il discorso della donna sotto violenza non può valere nei riguardi di un Papa, poiché un Pontefice, come il Divin Maestro, avrebbe dovuto tenere più al gregge che alla propria vita. Mi piace ricordare, a questo riguardo, anche la celebre apparizione, sulla via Appia, del Quo Vadis Domine, come narratici dagli apocrifi Atti di Pietro: dinanzi a un Pietro, in fuga, a causa della persecuzione neroniana, dalla sede romana per timore del martirio, il Signore si fece avanti, rispondendogli che se lui fosse fuggito (e quindi può dirsi sostanzialmente avesse rinunciato alla sede…), Egli sarebbe tornato a Roma a farsi crocifiggere nuovamente (Eo Romam, iterum crucifigi). Pietro comprese e tornò su suoi passi. Sappiamo come andò a finire. Ecco come si comporta un Vicario di Cristo: non cerca escamotage per restare in piedi, sul trono, facendo presunti passi a lato. No, accetta piuttosto l’esilio o la suprema testimonianza del martirio, ben consapevole che i destini della Chiesa sono nelle mani di Cristo, che non può lasciare mai vedova la Sua Sposa. La verità è che tutta la questione della “rinuncia” di Benedetto XVI è affrontata da molti, diciamo così, guardandola con una prospettiva politica, orizzontale, aliena da un’ottica cristiana e, direi, cattolica, quasi non credendo che sia, appunto, Cristo a guidare la sua Chiesa e che il Papa è, o dovrebbe essere, immagine visibile di quel Pastore invisibile, che regge le sorti del mondo e della Sua Sposa. Questo è ciò che manca allorché si affronta questo tema. Alcuni affermano, per es., che con la sua “rinuncia” Benedetto XVI avrebbe consapevolmente spiazzato i suoi fantomatici e non meglio chiariti “nemici” e che avrebbe evitato, in tal modo, che venisse eletto validamente il card. Bergoglio al soglio pontificio. Si dimentica però che, se così fosse, Benedetto XVI avrebbe commesso, dinanzi a Dio e alla Chiesa, una grave colpa, poiché avrebbe sabotato l’elezione di un valido successore, impedendogli che gli fosse conferita dal Signore la grazia di stato, causando così la confusione e la dispersione del gregge. Insomma, questo presunto e consapevole “tiro mancino” di Benedetto XVI, che denoterebbe una buona dose di furbizia machiavellica, sarebbe, in realtà, un grave atto di accusa contro di lui, giacché dimostrerebbe che non avrebbe neppure fede nella convinzione che, una volta che un soggetto fosse eletto, la vita di prima sarebbe come dimenticata: Dio conferirebbe, in quel momento, la grazia necessaria al nuovo stato perché il soggetto possa compiere la sua missione. Famoso è il detto, a tal proposito, di Papa Pio II: «Aeneam reicite, Pium recipite!» (534) Non vogliamo, dunque, anche solo immaginare che Benedetto XVI, ora che è dinanzi a Dio, potesse aver voluto sbagliare consapevolmente la sua “rinuncia” per ragioni – diciamo – di politica clerical-ecclesiastica. È un’ipotesi che vogliamo scartare a priori, non ritenendolo capace di una tale astuzia, come ho detto, machiavellica, da politicante, capace, alla fine, di danneggiare la stessa Chiesa e confondere i fedeli. Alcuni autori – e concludo – hanno pensato che la “rinuncia” di Papa Ratzinger fosse un vero e proprio colpo di Stato. Il giornalista Marco Politi, per es., tempo fa, non usava giri di parole per definirla per tale. Leggo su un suo testo: «Le dimissioni di Ratzinger sono completamente diverse [da quelle di Celestino V, N.d.R.]. Non sono forzate. Non sono emotive e neanche l’effetto di un’eccessiva fragilità fisica. Sono il risultato di un ragionamento preciso. Benedetto XVI vuole fare tabula rasa delle posizioni cristallizzate in curia. Il suo ritiro costringe, a norma del diritto canonico, i massimi dirigenti del governo centrale della Chiesa a diventare dimissionari anch’essi. Nei fatti la decisione di abdicare equivale ad una sorta di colpo di stato, che in Vaticano azzera tutto» (535) Ovviamente, queste conclusioni non mi trovano d’accordo. Probabilmente ora che Benedetto XVI è deceduto, verremo finalmente a conoscere le vere ragioni che l’hanno spinto a “rinunciare”, compiendo un atto di tal fatta. Si tratta della famosa “Mafia di San Gallo”, sulla quale noi di Fede & Cultura abbiamo pubblicato due libri inchiesta, uno a firma di Julia Meloni e un altro a firma di Taylor Marshall (536). Ammettiamo per un attimo che l’elezione di Francesco sia davvero invalida per questa ragione. Ne deduciamo che anche Benedetto XVI sia stato scomunicato lataesententiae, almeno in base a ciò che possiamo evincere dall’inchiesta di Julia Meloni, dal momento che il cardinale Carlo Maria Martini si accordò con Ratzinger per dirottare i voti su di lui anziché su Bergoglio nel conclave del 2008. Come stanno davvero le cose? Dire come stiano le cose è un po’ difficile, perché sinora abbiamo solo ricostruzioni assai parziali dei conclavi del 2005 e del 2013. In ogni caso, personalmente non mi strapperei le vesti se in un conclave si siano affrontati gruppi di cardinali o, se vogliamo, veri e propri partiti di porporati, ciascuno con un proprio progetto elettorale – se vogliamo dir così – e con candidati di bandiera e/o candidati effettivi. Alla fine, i conclavi non hanno nulla di diverso, da questo punto di vista, di qualsiasi assise elettorale. Abbiamo assistito all’inizio del 2022 alla (ri-)elezione a Capo dello Stato di Sergio Mattarella. È ovvio che all’interno del Parlamento, in seduta comune, ci siano stati gruppi con candidati di bandiera, con progetti; gruppi che hanno cercato di imporre il proprio candidato agli altri. Diciamo che è una dinamica abbastanza comune in simili compagini. Vengo al conclave. Non sembra potersi mettere in dubbio che nel conclave del 2005 ci sia stato lo scontro tra due partiti. Quello progressista, denominato Gruppo di San Gallo – così chiamato perché i cardinali e prelati che ne facevano parte si riunivano presso l’abbazia di Sankt-Gallen, nell’omonima cittadina svizzera – che uno dei suoi maggiori esponenti, il cardinale belga Godfried Danneels, denominò, nel 2015, più o meno scherzosamente, come Mafia di San Gallo per sottolinearne la riservatezza degli incontri (537), e il cui candidato di bandiera era il card. Carlo Maria Martini; e quello conservatore, denominato Partito del sale della terra (Salt of Earth Party) e il cui candidato era appunto l’allora card. Ratzinger. Ce ne parlava tempo addietro lo stesso mons. Georg Gänswein, già segretario particolare di Benedetto XVI (538). In relazione questi due partiti non sono in grado di poter dire se alcuno di essi o taluni membri di questi fossero affini o affiliati alla Massoneria. A oggi non è dato saperlo. Forse in futuro si potrà conoscere. Ma alla fine questo non conta, poiché – in un’ottica cristiana – è più che ovvio che associazioni sovversive ed eretiche cerchino di infiltrarsi nella Chiesa, giacché dove è molto Bene lì si insinua anche il Male. Per cui, mi pare improprio etichettare il Gruppo di San Gallo come massonico-satanista et similia. Non foss’altro perché ci mancano prove su simili affiliazioni o sul compimento di riti strani o di matrice satanica così come ci sembrano davvero arditi i collegamenti tra alcuni discutibili personaggi e la Svizzera o la cittadina di Sankt-Gallen per il semplice fatto che siano transitati per quei luoghi (539). Al momento – non disponendo di prove al riguardo – possiamo solo dire che questo Gruppo rappresentava l’anima progressista e aperturista della Chiesa. Per cui, si può convergere o no sui temi promossi e discussi dal Gruppo, e personalmente non li condivido, ma, per onestà intellettuale, va detto che elevare questo addirittura a gruppo massonico-satanista è un’autentica falsificazione e deformazione della verità storica. Fatta questa puntualizzazione, dicevamo che è normale immaginare che in un’assise elettiva ci siano gruppi partitici, che si sforzino di far eleggere il proprio candidato mediante cordate. Si tratta di dinamiche ben note negli organismi elettorali. Riguardo al conclave del 2005, il partito conservatore, che aveva quale suo candidato di bandiera il card. Ratzinger, aveva la maggioranza del conclave, ma non quella sufficiente per farlo eleggere. Come si pervenne all’elezione? Beh, da quel che si sa, il Gruppo di San Gallo cercò di far cadere quella candidatura, non facendogli raggiungere nei primi scrutini la maggioranza necessaria per l’elezione (540). In questo modo, come solitamente avviene nei consessi elettivi, la candidatura sarebbe dovuta venir meno, in favore di qualche altro candidato di compromesso, che andasse bene ai due schieramenti. Il merito del Partito del Sale della terra fu quello di tenere duro e non rinunciare a quel candidato. Per cui, creandosi una situazione di stallo, fu cercato un compromesso tra i due schieramenti e questo fu trovato nel fatto che ci fosse una sorta di passaggio di testimone tra i due candidati principali di quel conclave, cioè Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio. Si stabilì verosimilmente che dapprima sarebbe stato eletto Ratzinger, in quanto più anziano del secondo, e poi, dopo un certo tempo, se questi non fosse morto prima, sarebbe subentrato un cardinale di area progressista, verosimilmente Bergoglio. Trovato l’accordo, in effetti, Ratzinger trovò immediatamente i voti necessari per l’elezione, tanto da essere eletto in tempi brevi. Del resto, se non si fosse trovato questo compromesso, non mi spiegherei come mai i cardinali progressisti avrebbero dovuto votare per il candidato conservatore Ratzinger, che era da loro non gradito (541). Certo, si potrebbero nutrire dubbi sul cardinale che abbia fatto filtrare quanto avvenuto nel conclave del 2005. Del resto, Benedetto XVI aveva sempre negato – direi comprensibilmente – l’esistenza di accordi elettorali (542). Ma, d’altronde, si sa: la segretezza del conclave, molte volte, è un segreto di Pulcinella, nel senso che prima o poi qualche gola profonda racconta quanto in esso sia avvenuto. È capitato anche con Francesco: forse ci si ricorderà dello scoop di Antonio Socci, il quale in un suo libro ricostruiva quanto avvenuto nel conclave del 2013 (543): raccontava quanto il giornalista aveva appreso da un cardinale anonimo che vi aveva partecipato e poi confermato da alcuni altri giornalisti vicini a Francesco come l’argentina Elisabetta Piqué corrispondente del quotidiano La Nación (e non solo) sul modo in cui avvenne l’elezione dell’allora card. Bergoglio. Tornando al conclave del 2005, ci sono altri diversi indizi che comprovano questa ricostruzione. È poco noto, ma si apprende da ambienti romani che, nel 2006, Papa Benedetto richiese un parere al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sull’atto di rinuncia. Ne fa cenno nella sua premessa Mons. Bux. Evidentemente già nel 2006 aveva pensato a un simile atto? C’è di più. C’è la testimonianza-testamento nel 2015 del sacerdote gesuita padre Silvano Fausti, poco prima della sua morte (era infatti malato gravemente). Questi era stato guida spirituale e confessore del card. Martini, e quindi persona a lui molto vicina. Egli, prima di morire, lasciò la sua testimonianza sul conclave del 2005 e sul modo in cui si pervenne alla rinuncia di Ratzinger nel 2013 (544). Come non si dubita della confessione del cardinal Danneels, così non abbiamo motivo di dubitare di padre Fausti, tanto più che la sua testimonianza era quella di una persona prossima alla morte e che era consapevole dell’incurabilità della sua malattia. Secondo padre Fausti, il cardinal Martini, incontrando per l’ultima volta Benedetto XVI a Milano nel maggio 2012 (Martini sarebbe morto l’agosto di quello stesso anno), gli avrebbe ricordato la sua promessa e da allora non ci sarebbe stato verso di far cambiare parere al Papa circa la sua “rinuncia”. Del resto, nel conclave del 2013, il card. Bergoglio non pensava che, a distanza di otto anni, i cardinali tenessero fede a quell’accordo del 2005, tanto è vero che aveva programmato anche il viaggio di ritorno in Argentina. E in effetti, in quel conclave ci furono candidature anche nello schieramento conservatore, come quelle dei cardinali Scherer e Scola, ma sicuramente alquanto deboli. Per di più, coloro che erano più affini allo schieramento conservatore giocavano – come dire – da “liberi battitori”, come, per es., il card. Dziwisz, già segretario personale di Giovanni Paolo II, il quale, come lasciava intendere la stampa di quei giorni fatidici, avrebbe richiesto al candidato la canonizzazione in tempi rapidi del papa polacco (545). Non a caso, nel 2014, la testata Korazym, parlò di promozione, da parte del porporato, di un «culto della personalità di Giovanni Paolo II» e della sua «pressione […] per una canonizzazione veloce [che] avrebbe spinto papa Francesco a decidere di canonizzarlo» (546). Perché i cardinali di area conservatrice avrebbero votato il card. Bergoglio? Sfumate le candidature conservatrici, evidentemente perché ritennero di tener fede a quell’accordo del 2005. Non a caso, qualche prelato – lo ricordo bene – poco prima che iniziasse il conclave del 2013 invitò a pregare perché non fosse eletto il cardinal Bergoglio. Aveva qualche prelato lo spirito profetico? Chiaramente no; evidentemente era a conoscenza dell’accordo che andava avanti sin dal 2005. Concludo con una chiosa: l’esistenza di siffatti accordi, laddove fossero provati, non invaliderebbero l’elezione del 2013, non esistendo alcuna disposizione canonica che ne sancisca la nullità. Al più i partecipanti agli stessi vedrebbero invalidato il loro patto e potrebbero incorrere nella censura di scomunica a norma dell’art. 81 UDG, ma l’elezione non sarebbe, a sua volta, invalidata (547). La scomunica, infatti, non priva del diritto all’elezione il cardinale; a fortiori se non dichiarata. D’altronde la norma penale di cui al citato art. 81 va intesa in senso stretto, dovendosi trattare di contratti che obbligano i partecipanti al patto a promettere o impegnarsi altrimenti a dare il proprio consenso o a negarlo a un candidato. Non si deve trattare quindi di meri assensi o consensi. Sull’istituto del papato emerito ho già in parte risposto in precedenza. Per poter comprendere di cosa si stia parlando, è opportuno che faccia una premessa. La figura del “vescovo emerito” ha le sue radici nel Concilio Vaticano II ed è frutto della codificazione del 1983. In precedenza, nei documenti della Santa Sede, si parlava semplicemente di “vescovi dimissionari” o “vescovi che avevano rinunciato all’ufficio”. La codificazione del 1917, al can. 422 § 1, istituiva un’analogia tra l’emeritato e il giubilato, considerando i due termini come sinonimi (sebbene si trattasse di istituti ben diversi), con riferimento specifico, però, ai canonici. La disposizione si collocava, infatti, nella disciplina del Capitolo dei Canonici. Si trattava di una normativa particolare, non riguardante i vescovi. Il riconoscimento del titolo era, comunque, inteso come una graziosa concessione della Sede Apostolica. Nella nuova codificazione, la nozione di “emerito” si ricava dal can. 185, che abbiamo innanzi richiamato. In base a questo canone, l’emeritato consiste solo in un titolo di onore che l’autorità competente a provvedere a un ufficio può concedere a chi lo perda per raggiunti limiti di età o per rinuncia accettata. Esso ha fondamento nell’esercizio lodevole di un ufficio, nei confronti del quale non permane altro legame che quello onorifico di portarne il titolo, ma con l’evidenziazione di non esserne più il titolare effettivo. Per quanto concerne i vescovi, è significativo che il titolo sia concesso solo a quelli diocesani. I vescovi coadiutori e quelli ausiliari, una volta rinuncianti, non acquisiscono il titolo, stando al can. 411, che non richiama il disposto del can. 402 § 1. A questi, tuttavia, l’emeritato può essere conferito per concessione dalla competente autorità, a norma del can. 185. In ogni caso gli emeriti, in relazione alla diocesi che hanno servito, non hanno alcuna potestà, né ufficio, né delega, a meno che non abbiano ricevuto un incarico in tal senso dal nuovo vescovo diocesano. Il vescovo emerito conserva nondimeno la sua identità episcopale (stante l’indelebilità del carattere episcopale), su cui si innesta la qualifica appunto di “emerito”. Il titolo di “emerito”, per quanto concerne i vescovi diocesani, è, perciò, una generale e generalizzata concessione del Papa, accordata, nella codificazione canonica, automaticamente, ex lege, al vescovo diocesano al termine del lodevole servizio in una diocesi e della missio canonica ricevuta dal Pontefice, salvo diversa disposizione. Negli altri casi, il titolo è attribuito su espressa e singola concessione. Alla luce di quanto ricordato emergono delle anomalie per il caso di Benedetto XVI. Non esiste, in effetti, alcun provvedimento da cui si evinca che Benedetto XVI o Francesco abbiano accordato al primo il titolo di “emerito”. Né tale titolo può dirsi acquisito automaticamente a seguito della supposta rinuncia a norma del can. 185, stante la novità della figura. Certamente, essa – a causa della sua eccezionalità (Mons. Gänswein, già segretario di Benedetto XVI, affermava, in qualche occasione, trattarsi – quello di Ratzinger – di un «passo di millenaria portata storica», che «fino ad oggi non c’era appunto mai stato» (548) – avrebbe dovuto essere oggetto di apposita concessione della competente autorità, cioè del successore sulla Cattedra di Roma, almeno per sedare le incertezze e i dubbi sollevati dalla canonistica soprattutto riguardo alla conservazione degli attributi papali per il Pontefice resignante (“Sua Santità” o “Santità”, “papa” emerito, ecc.). Ammesso, ovviamente, che un Papa potesse accordare un simile titolo. Un paio di giorni prima dell’operatività della “rinuncia”, il 26 febbraio, in effetti, la Sala Stampa vaticana, tramite Padre Federico Lombardi, precisava che Benedetto XVI si sarebbe chiamato «papa emerito o Romano Pontefice emerito». Sempre P. Lombardi, nel briefing con i giornalisti in Sala Stampa Vaticana, ricordava che il Papa avrebbe conservato il nome di «Sua Santità Benedetto XVI» e avrebbe indossato l’abito talare bianco semplice, senza la mantellina che copre le spalle (c.d. pellegrina). Aggiungeva che Benedetto XVI non avrebbe utilizzato più «[l]’Anello del pescatore», che sarebbe stato, quindi, annullato, come anche il sigillo di piombo del pontificato (549). La Santa Sede, per vero, avrebbe contattato alcuni canonisti (come, per es., il card. Coccopalmerio), i quali si sarebbero espressi, quasi operando una sorta di perequazione canonica con gli altri vescovi diocesani, nel senso di riservare al nuovo status, che avrebbe contraddistinto papa Ratzinger, quello di “vescovo emerito di Roma” (550). Questa terminologia, però, presentava non poche criticità, in quanto comportava una sorta di scissione tra l’ufficio primaziale del Papa e quello propriamente di vescovo della chiesa di Roma, che presiede le altre nella carità, uffici che sono riuniti, per loro natura, nell’unica persona del Romano Pontefice. Scissione che avrebbe comportato inevitabili implicazioni giuridico-teologiche. A ogni modo, una dichiarazione dell’allora Direttore della Sala stampa, non poteva certo dirsi sufficiente né assumere valore normativo né poteva sopire i dubbi che la stessa aveva implementato. C’è di più. A complicare le cose vi sono state alcune condotte dello stesso Papa “emerito” nonché alcune affermazioni di Francesco. Riguardo al primo aspetto, forse la più emblematica è la concessione della c.d. benedizione apostolica o papale ad alcuni fedeli. Ora, è ben vero che il Papa bolognese Benedetto XIV, con la costituzione Pia Maternel 1747, concesse, in maniera generale, la facoltà di impartire la benedizione apostolica a tutti i vescovi (non emeriti, evidentemente), assieme alla possibilità di suddelegare la medesima facoltà ai sacerdoti, tuttavia, è indubbio – riguardo ai vescovi (non emeriti!) – che essa incontra dei precisi limiti stabiliti dal Benedizionale (551). Significativo è che, in ogni caso, il rito della benedizione apostolica espliciti che essa è impartita «a nome del Romano Pontefice». Al contrario dei vescovi, un Papa non incontra alcuna limitazione né di tempo né di mezzi né di numero nell’impartire questa benedizione, potendola accordare anche con una semplice lettera e in numero illimitato. Nel caso di Benedetto XVI, egli, pur dopo la sua “rinuncia” e nonostante fosse “papa emerito”, ha continuato a impartire benedizioni apostoliche senza far menzione ad alcuna sua delega né a nome di altri, ma a suo proprio nome. Il caso più noto – ma ve ne sono pure altri – è stato quello della lettera di replica di Benedetto XVI al card. Brandmüller. In questa seconda missiva, datata 23 novembre 2017, il papa concludeva il testo accordando al porporato la sua, personale e propria apostolica benedizione («Mit meinem apostolischen Segen bin ich») (552). La stessa cosa compiva il Papa in una sua missiva al card. Robert Sarah del 20 settembre 2019, resa pubblica dallo stesso porporato sul suo profilo twitter dopo le polemiche sollevate dalla pubblicazione del suo testo, in edizione francese, sul sacerdozio, Des profondeurs de nos coeurs («… imparto [recte: impartisco, N.d.R.] la mia benedizione apostolica a Lei, ai Suoi collaboratori e alle persone a Lei care») (553). La concessione della benedizione apostolica costituisce indubbio esercizio del potere di «giurisdizione di benedire il popolo», come affermava alla fine del Settecento, in un testo, il dotto sacerdote bolognese Francesco Calzoni (554) Con riferimento al secondo profilo, Francesco, in qualche occasione, ha qualificato espressamente Benedetto XVI come Papa e non già come un ex Pontefice (555) Tornando al nostro tema, assai problematico è applicare il can. 185 al Pontefice per il quale, a differenza degli altri uffici ecclesiastici, non sono stabiliti limiti d’età e la cui rinuncia non richiede accettazione da chicchessia. Il presupposto per l’applicazione del can. 185 (e dello specifico can. 402 § 1), in effetti, è l’accettazione della rinuncia da parte della competente autorità, che, nel caso del papato, manca. Quello papale, inoltre, non è un comune ufficio, stante la sua peculiarità. A differenza dei vescovi diocesani, infatti, che ricevono la missio canonica dal Pontefice, il Papa riceve il suo ufficio da Cristo stesso. È il Signore che conferisce, con l’accettazione, i carismi necessari e fa del neoeletto al Sommo Pontificato il suo Vicario in terra. Di qui l’irriducibilità del munus petrinum nel ristretto ambito del can. 185 (e del can. 402 § 1). Tale dato sembra pacificamente acclarato dalla canonistica, non certo da ora (556). La canonistica, non a caso, di fronte all’applicazione dell’istituto dell’emeritato all’ufficio papale, si è mostrata decisamente contraria e fortemente critica sin dai primi commenti successivi alla rinuncia di Benedetto XVI (557), sebbene non siano mancate posizioni che abbiano ravvisato nel titolo che Papa Ratzinger si era attribuito una forma di cortesia (558). Come nota, sotto il profilo canonistico, il prof. Carlo Fantappiè, in un suo contributo, «o il Papa c’è, e allora esercita le sue piene funzioni di supremo pastore della Chiesa in actu, oppure non c’è, e allora siamo nel regime della Sede apostolica vacante. Non si può prevedere nella Chiesa né una sorta di consolato, sul modello romano, né una coesistenza di due papi, seppure l’uno in pieni poteri, l’altro senza poteri. Proprio la posizione unica e sostanziale che rappresenta nella Chiesa cattolica non permette di concepire, sotto qualsiasi titolo, un Papa che non sia nel pieno delle sue funzioni e dei suoi poteri. Non sembra quindi giuridicamente possibile qualificare tale un Papa che non eserciti in tutto e per tutto le funzioni annesse all’ufficio» (559). Per altri, «[i]l canone citato [il can. 185], comunque, certamente non si applica al Pontefice per il quale infatti non sono stabiliti limiti di età e la cui rinuncia non deve essere accettata» (560). Il che conferma, da un canto, l’assoluta novità della vicenda e, dall’altro, la difficoltà della canonistica, anche più accorta, di inquadrare la fattispecie secondo le categorie della dottrina teologico-canonica tradizionali. Certo, i vari autori cercano di “salvare” in qualche modo la scelta del papa-teologo, scacciando quasi a priori l’idea che la stessa possa essere presentare profili che possano inficiarne la validità, evocando ragioni di ordine spirituale, quasi mistiche, o di sensibilità personale. La prof.ssa Boni nondimeno conclude come «l’appellativo di papa emerito sia assai fiaccamente sostenibile dal punto di vista giuridico, anzi sia a nostro parere inappropriato» (561). Ciò dovrebbe confermare, molto più semplicemente, come la “rinuncia” appaia quantomeno, dal punto di vista giuridico, dubbia. Rimane perciò sul tavolo una questione, a nostro avviso di capitale importanza: potrebbe un Papa, con sua volontà sovrana e quale interprete del diritto divino, creare ex nihilo questa figura inedita di “papa emerito”? Potrebbe poi un futuro papa disciplinare lo status del Papa rinunciante attribuendogli il titolo di “papa emerito”, come pure ipotizzato da qualche autore? E’ nella disponibilità del supremo legislatore (umano sia pur supremo) tale possibilità? In altre parole, non si fa questione qui della libertà dell’atto di “rinuncia” del defunto Benedetto XVI, bensì dell’intenzione dell’atto e cioè se il papa Ratzinger volesse davvero dimettersi dall’ufficio papale (munus petrinus) o solo dal suo “esercizio attivo” (agendo et loquendo) (562). Potrebbe Dio aver reciso il legame, che unisce la persona di Papa Ratzinger all’ufficio papale, nonostante l’intenzione difettosa che è radicata in un errore dottrinale? Per rispondere a questi plurimi interrogativi, non possiamo non partire da una constatazione e cioè che Dio sia causa efficiente dei sacramenti così come del rendere un soggetto quale pontefice. Come insegna il Caietano (o Gaetano), nel suo opuscoletto, scritto nell’autunno del 1511 in appena un paio di mesi, De comparatione auctoritatis Papæ et Concilii, quando si tratta di dimissioni papali (come anche nel caso dell’accettazione), l’atto di chi si dimette (o di chi accetta l’elezione) non sarebbe una causa efficiente, neppure parzialmente, ma solo una causa dispositiva (563), esattamente come afferma la Lettera agli Ebrei (5, 4): «Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne». In altre parole, chi si dimette si disporrebbe a perdere l’ufficio papale (presentando le sue dimissioni), mentre Dio stesso sarebbe colui che provocherebbe la separazione dell’uomo dall’ufficio. Ora, mentre è necessaria un’intenzione adeguata per celebrare validamente un sacramento, è importante notare che un errore dottrinale del ministro non renderebbe, in generale, necessariamente nullo il sacramento a causa di un difetto dell’intenzione, anche quando l’errore dottrinale in questione riguardi l’effetto previsto del sacramento. Questo avviene di regola in tutti quei casi in cui la materia del sacramento non abbia a che fare con la volontà del ministro. In quei sacramenti nei quali, invece, il consenso del ministro o dei ministri sia materia dell’atto, il sacramento può essere inficiato da errore, vizio o dolo. L’esempio classico è il sacramento del matrimonio. In questo caso, un’intenzione difettosa dovuta a ignoranza circa l’essenza del matrimonio o a convinzioni erronee profondamente radicate, che portino a escludere il valore sacramentale dell’atto o che sia carente a causa di un vizio o di un dolo, rende nullo quel sacramento, impedendosi che quel vincolo sia contratto validamente (564). In modo analogo potrebbe ragionarsi per quanto riguarda la “rinuncia” di Benedetto XVI: rimane, in effetti, il dubbio se emerga davvero l’intenzione generale di rinunciare o disporsi a rinunciare, essendo questa carente in ragione di un errore relativo al voler permanere “papa per sempre”, come ebbe a dichiarare, in maniera esplicita, come ricordato, in occasione dell’ultima udienza generale il 27 febbraio 2013: «Il “sempre” è anche un “per sempre” – non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera» (565) Nel linguaggio, non sempre chiaro di Papa Ratzinger, emerge da queste parole la sua volontà e al contempo il suo errore circa, non tanto gli effetti dell’atto compiuto, quanto la natura stessa di esso. La creazione della figura inedita del papato emerito è sì un effetto di quella volontà, ma al contempo lascia chiaramente intravedere quale fosse il contenuto concreto dell’atto volitivo, analogamente a quanto avviene nell’ambito del matrimonio: vale a dire quello di non rinunciare in toto al papato, ma conservare uno o più aspetti, sia pur minimi, di questo (566), restando perciò «un peu pape» o un «pape caché» (567). Questo sarebbe un aspetto che meriterebbe un apposito approfondimento. Ho richiamato, in precedenza, la
legge promulgata da Giovanni Paolo II.
10. Ma sono esistite rinunce
condizionate a particolari eventi? Vorrei anzitutto precisare che né la codificazione canonica e neppure la Costituzione Apostolica, dedicata esplicitamente all’elezione del Sommo Pontefice (la UDG), dicono qualcosa circa lo status, la qualificazione e le prerogative del Papa che perda il proprio ministero per causa diversa dalla morte, come avviene nel caso della rinuncia volontaria. Come ho ricordato prima, si tratta di una lacuna legislativa, che il Legislatore canonico, a oggi, non ha inteso colmare. Per di più, tra gli aspetti da normare, vi sarebbe, secondo molti, quello dell’istituto del “Papa emerito” del tutto sconosciuto e tuttora ignorato dal diritto canonico al fine di regolare la convivenza tra il Papa regnante e quello emerito, senza che possano generarsi dissidi o imbarazzi (568). Per la verità, il già rammentato Gruppo di lavoro ha raccolto una serie di contributi canonistici su questi temi (569). Personalmente ho una serie di perplessità su una siffatta normativa. Almeno per quanto concerne la regolamentazione del sedicente istituto del “papato emerito”. Da parte la circostanza che una siffatta nuova disciplina non eluderebbe i dubbi sorti in merito alla “rinuncia” di Benedetto XVI (570), si deve osservare che regolamentare, in effetti, con una legislazione umana un siffatto istituto, a mio modo di vedere, verrebbe a toccare un ambito normativo riservato al Divino Redentore e che solo Lui potrebbe emendare. Nessun Papa, né tantomeno Benedetto XVI, insomma, potrebbero disciplinare lo status di “Papa emerito” né creare tale figura, giacché afferente al diritto divino, essendo sottratta alla disciplina ecclesiastica umana la regolazione degli effetti tanto dell’accettazione quanto della rinuncia (571). Cosa voglio dire? La codificazione canonica è molto scarna e asciutta riguardo agli effetti dell’accettazione ed, ovviamente, della rinuncia. Mi spiego. Il can. 332 § 1 del Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina, così come il can. 44 § 1 di quello dei canoni delle Chiese orientali, così come, infine, l’art. 88 UDG, lasciano intendere che, con l’accettazione, immediatamente l’eletto – se già vescovo – diventi, come recita la disposizione testualmente ora citata della Costituzione Ap., «vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale» (comma 1). La normativa è talmente categorica che non lascia spazi a discipline integrative, quali potrebbero essere, per es., la previsione di un termine, iniziale o finale, un termine cioè a partire dal quale l’accettazione possa avere o cessare di efficacia, o dell’apposizione di una qualche condizione. A mio avviso c’è una ragione per tale categoricità e allo stesso tempo per una previsione così scarna da parte del Legislatore canonico: il fatto è che si viene toccare un ambito che è sottratto al legislatore umano, appartenendo alla competenza esclusiva del Divino Legislatore. Il Signore, infatti, avrebbe lasciato ampia libertà all’uomo circa le modalità di designazione di un soggetto al papato (572). Ma una volta designato, gli effetti appartengono al diritto divino. Per cui non compete ad alcuna potestà umana disciplinare o limitare quello che il Divino Legislatore ha previsto per il Papa. Di qui l’irriducibilità dell’istituto dell’accettazione al supremo pontificato al novero degli atti amministrativi, non potendo – stante la natura peculiare del munus petrinum– essere ricondotto a tale categoria di atti. Analogamente, a mio avviso, deve ragionarsi in relazione alla rinuncia, in termini di contrarius actus rispetto all’accettazione. Come l’accettazione, infatti, conferisce al soggetto designato quella potestà e quei caratteri che abbiamo indicato, analogamente, la rinuncia opera in senso uguale e contrario, privando quel soggetto della potestà e di quei caratteri. Per cui, se è inimmaginabile l’apposizione di un termine o condizione all’accettazione del papato, analogamente lo dovrebbe essere anche per la rinuncia. Pure per esso, quindi, escluderei che possa ricondursi, come fatto invece da qualche autore, in una visione solo orizzontale, all’ambito puramente degli atti amministrativi. Se l’accettazione produce i suoi effetti “immediatamente” e incondizionatamente, non diversamente la rinuncia deve produrre i suoi effetti altrettanto “immediatamente” e incondizionatamente. Come per l’accettazione il Divin Redentore ha rimesso agli uomini ampia libertà di previsione delle forme di designazione, analogamente, per l’atto contrario, ha lasciato libertà di prevedere giuste modalità di rinuncia. Ciò che anche qui si è riservato concerne gli effetti, che sono indisponibili da parte del Legislatore umano. Una volta rinunciato all’ufficio e venuta meno quella volontà che il designato aveva all’inizio manifestato, perciò, “immediatamente” è ritirato dal soggetto il carisma papale e cessa, sempre “immediatamente”, di essere Capo della Chiesa, non potendo più compiere alcun atto di suprema giurisdizione. Come per l’accettazione non vi sarebbe spazio di rinviare gli effetti o riservarsi qualcosa, pena la sua invalidità o addirittura inesistenza giuridica, altrettanto per la rinuncia non sarebbe possibile rinviarne gli effetti o riservarsi qualcosa (573). Perciò, non credo che alla rinuncia sia applicabile per intero il disposto di cui al can. 189 (segnatamente il § 4) della codificazione della Chiesa latina e 970 (segnatamente il § 2) del codice dei canonici delle Chiese orientali, che presuppongono la possibilità per la rinuncia a un ufficio ecclesiastico di apposizione di un termine e, sino a quando questa rinuncia non abbia sortito effetto, di poterla ritirare (574). A questo riguardo è davvero singolare l’accostamento fatto da un Autore alle specie eucaristiche: «un papa, finché dura in lui l’assenso e la fede, è sempre papa; come egli rinunzia, o diventa eretico, ipso facto cessa di esser papa; in quella maniera che nel Sacramento vi è il Corpo di Gesù Cristo finché durano le specie del pane; ma perite le specie, cessa tosto ancora di esservi il Corpo dello stesso Cristo» (575). Per questo mi sembra molto prudente la presa di posizione di Francesco, che ho ricordato prima, durante la sua intervista al quotidiano spagnolo ABC, secondo cui avrebbe la sensazione che «lo Spirito Santo non ha interesse a che mi occupi di queste cose». Grazie per questa domanda che mi offre la possibilità di un’importante puntualizzazione. Negli ultimi tempi, si è molto parlato, con riguardo all’ipotesi di una possibile “rinuncia” di Francesco, che egli avrebbe già predisposto il testo della stessa e l’avrebbe consegnata al Segretario di Stato del tempo, cardinal Bertone, che, presumibilmente l’avrebbe passata al successore, cardinal Parolin. In questa, Francesco dichiarerebbe di rinunciare se colpito da una malattia invalidante che lo rendesse inabile all’ufficio. Come precedenti di quest’atto si sono richiamati, in modo particolare, gli atti di rinuncia predisposti dai Papi Pio VII, Pio XII e Paolo VI. Ora, senza entrare nei dettagli di questi atti, posso dire che – tranne il caso di Paolo VI – quelle di Pio VII e Pio XII sono estremamente simili. Secondo gli storici, questi due Papi avrebbero predisposto (e firmato) le loro rinunce in previsione di una loro deportazione da parte di potenze di occupazione (nel caso di Pio VII di quella napoleonica (576), nel caso di Pio XII, dopo l’8 settembre 1943, di quella nazista (577). In realtà, a mio avviso, in questi casi non ci troviamo di fronte a veri atti di rinuncia condizionati all’evento della deportazione, bensì ad atti di rinuncia, che sarebbero stati utilizzati – manifestandoli pubblicamente – al verificarsi di quegli eventi. Insomma, le rinunce avrebbero sempre efficacia immediata, ma sarebbero state pubblicate qualora l’evento si fosse manifestato. L’evento “deportazione”, in un certo qual modo, quindi, sarebbe un fattore esterno e non intrinseco all’atto. Diverso è il caso di Paolo VI, dove effettivamente il Papa condizionava l’efficacia dell’atto espressamente al caso di «infermità, che si presuma inguaribile, o di lunga durata, e che ci impedisca di esercitare sufficientemente le funzioni del nostro ministero apostolico; ovvero nel caso che altro grave e prolungato impedimento a ciò sia parimenti ostacolo». Che dire di questo atto? Esso fu consegnato dal Papa al suo Decano, card. Eugène Tisserant. Presumo, quindi, che colui che avrebbe dovuto accertare l’infermità inguaribile o di lunga durata o altro prolungato impedimento sarebbe stato appunto il Decano. A mio avviso, quest’atto di Paolo VI avrebbe creato non pochi problemi giuridici. Scriveva, in effetti, che dichiarava di rinunciare all’ufficio papale sia come vescovo di Roma sia come Capo della Chiesa cattolica «nelle mani del Signore Cardinale Decano del sacro Collegio Cardinalizio, lasciando a lui, congiuntamente almeno ai Signori Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana ed al Cardinale nostro Vicario per la città di Roma (sempre che siano normalmente convocabili; e in caso contrario ai Signori Cardinali Capi degli ordini del sacro Collegio), la facoltà di accettare e di rendere operanti queste nostre dimissioni, che solo il bene superiore della santa Chiesa ci suggerisce ed al quale bene noi scongiuriamo con tutto il cuore quanto meglio possibile di provvedere, auspice la nostra apostolica benedizione» (578). Dicevo il testo effettivamente avrebbe posto una serie di problematiche giuridiche. Da parte la questione, rimasta fumosa, della verifica delle condizioni previste per la rinuncia e dell’organo che avrebbe dovuto procedere a un simile accertamento, quel che mi lascia più perplesso è la previsione di un’accettazione, da parte del Collegio cardinalizio, di quest’atto di rinuncia, che avrebbe sollevato questioni sulla sua validità, atteso che un simile atto non dovrebbe essere accettato da alcun’autorità. Non solo. Ma come è stato acutamente notato da taluni canonisti, in siffatte circostanze (cioè in caso di malattia o amentia o dementia) lascerebbe aperta la questione sulla libertà del Papa di poter anche ritirare l’atto se il suo stato di salute gli avesse impedito di assumere decisioni prima che fosse divenuta operativa (579). Per fortuna, papa Montini, alla fine, desistette dal dare seguito a quest’atto e, quindi, la cosa è rimasta agli atti come un tentativo di Paolo VI esauritosi in quei fogli. Una piccola chiosa: si hanno notizie contraddittorie su Giovanni Paolo II e cioè se egli possa aver predisposto atti di rinuncia, ma non si hanno certezze al riguardo, stante anche le dichiarazioni contrarie a una abdicazione rese dal Papa polacco nel corso degli anni a diversi testimoni (580). Sì, in effetti viene citato spesso da alcuni il seguente detto di S. Tommaso: peccat quicumque eorum missam audit vel ab eis accipit sacramenta, cioè: «pecca chiunque ascolta la loro Messa [dai ministri eretici, scismatici o scomunicati, N.d.R.] o riceve da essi i Sacramenti» (581). Ma la frase è decontestualizzata. Se andiamo a leggere sulla Summa, comprendiamo che il Doctor Angelicus voleva dire esattamente il contrario di ciò che si crede superficialmente. Per comprenderlo pienamente è opportuno riportare per intero il contesto nel quale è inserito quel passo. L’Aquinate si sta occupando del tema se sia lecito ricevere la comunione da sacerdoti eretici, scomunicati, o peccatori, e ascoltare la loro Messa. In particolare, ecco cosa risponde: «I sacerdoti che siano eretici o scismatici o scomunicati o anche peccatori, sebbene, come si è detto sopra, abbiano il potere di consacrare l’Eucarestia, tuttavia lo esercitano illecitamente e peccano esercitandolo. Ora, chiunque comunica con un altro nel peccato, ne viene a condividere la colpa, cosicché S. Giovanni parlando dell’eretico afferma: “Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie”. Quindi non è lecito ricevere la comunione dai suddetti sacerdoti né ascoltare la loro Messa. Tra codeste categorie però c’è qualche differenza. Infatti gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati vengono privati dell’esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa. E quindi pecca chiunque ascolti la loro messa o riceva da essi i sacramenti. Invece non tutti i peccatori vengono privati dell’esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa. Sebbene dunque siano sospesi per sentenza divina di fronte alla propria coscienza, tuttavia non lo sono per sentenza ecclesiastica di fronte agli altri. Perciò fino alla sentenza della Chiesa è lecito ricevere la comunione da essi e ascoltare la loro Messa. S. Agostino così commenta in proposito l’espressione di S. Paolo, “Insieme a costui non dovete neppur mangiare”: “Così dicendo egli proibiva a tutti di giudicare gli altri per arbitrario sospetto, o per indebita usurpazione di giudizio; ma ordinava che si giudicasse in base alla legge di Dio, e secondo la disciplina della Chiesa, o mediante la confessione spontanea, oppure mediante l’accusa e la discussione”» (582). Quindi, il Dottor Angelico, in buona sostanza, ci sta dicendo che «fino a sentenza della Chiesa, è lecito ricevere da costoro [dei ministri eretici, scismatici o scomunicati] la comunione e ascoltarne la Messa». E questo perché egli non voleva che «un uomo fosse giudicato da un altro sulla base di un sospetto arbitrario oppure con un giudizio usurpato al di là della norma, ma piuttosto in base alla legge di Dio, secondo l’ordine della Chiesa, sia che, poi, abbia confessato o che, citato [in giudizio], sia risultato colpevole» (583). Chi, dunque, affermi che partecipare alle Messe una cum Francisco comporti un peccato per il fedele, in realtà pecca di indebita usurpazione di giudizio. Ciò ovviamente non toglie che qualcuno possa considerare, in foro interno, Papa Francesco un personaggio dibattuto, ma finché non ci sia la sententia Ecclesiae, nessuno – laico o semplice sacerdote – potrebbe sostituirsi alla Chiesa docente. E non mi pare che l’eresia, vera o presunta che sia, di Francesco o di qualsiasi altro vescovo o presbitero, sia stata mai accertata in una sentenza della Chiesa. Al più l’opinione che si possa avere su Francesco o su un vescovo o un sacerdote potrà valere come parere di un dottore privato, non potendosi usurpare il giudizio della Chiesa, costituendo ciò un indubbio peccato di superbia. Sino a quando non ci sarà una pronuncia definitiva della Chiesa, si può andare a Messa e ricevere i sacramenti dai preti ritenuti eretici, scismatici, ecc. Lo attesta S. Tommaso stesso nel passo che ho ricordato sopra per intero: «fino alla sentenza della Chiesa è lecito ricevere la comunione da essi e ascoltare la loro Messa». Veniamo al caso di Sant’Ermenegildo talora richiamato a sproposito, che l’Angelico, in realtà, propone per presentare la tesi contraria a quella che aveva prospettato e a cui cercava poi di dare la soluzione («IN CONTRARIO: Un canone stabilisce: “Nessuno ascolti la Messa di un sacerdote che risulti con certezza colpevole di concubinato”. E S. Gregorio racconta che “un perfido genitore mandò a un suo figlio un vescovo ariano, perché dalle sue sacrileghe mani ricevesse la comunione eucaristica; ma il figlio, devoto a Dio, respinse il vescovo ariano come si meritava”») (584). Da parte la circostanza che gli ariani erano stati condannati plurime volte a partire sin dal Concilio di Nicea del 325 d.C. e poi in innumerevoli altri concili, generali e regionali, e infine anche da numerosi vescovi cattolici (tra cui Eufemio o Eufanio di Toledo, che era il vescovo cattolico all’epoca di Ermenegildo e che fu esiliato dal padre del santo martire insieme a san Leandro di Siviglia, che era il vescovo che aveva convertito Ermenegildo), Tommaso, nel risolvere le difficoltà, ricordava – in modo particolare con riguardo ai sacerdoti concubinari (ma la cosa può estendersi anche ai ministri eretici o apostati) – che la proibizione di partecipare alla Messa del concubinario (ma anche eretico, apostata, ecc.) riguardava il caso in cui il «concubinario [fosse] riconosciuto come tale, o “per una sentenza” di regolare condanna, o “in seguito a una confessione resa in giudizio”» (585). L’Angelico, perciò, è molto attento a che i fedeli si sottomettano sempre al giudizio della Chiesa e non assumano iniziative proprie seguendo il proprio metro di giudizio. Va considerato per di più che, rispetto all’epoca dell’Aquinate, vi è stata un’evoluzione nella normativa canonica. Ammettiamo pure, in effetti, che Francesco non sia Papa o che addirittura non lo sia mai stato, in tal caso si dovrebbe concludere quantomeno facendo applicazione del can. 844, §§ 2 e 3 del codice di diritto canonico, disposizioni queste che sono coerenti con i decreti conciliari Unitatis redintegratio (§ 16) e Orientalium Ecclesiarum (§ 27). In base al § 2 del can. 844, soprattutto: «Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti». Per cui, salvo non si voglia negare la validità sacramentale dell’ordine sacro conferito ai sacerdoti della Catholica (e non mi sembra sia questo il caso), quand’anche si ritenesse che il clero della stessa fosse corrotto, eretico o scismatico, e chi più ne ha più ne metta, nondimeno si dovrebbe concludere che i membri di questo clero celebrano validamente e gli stessi cattolici possono ricevere validamente i sacramenti da essi. C’è poi un’evidente aporia nell’affermazione di alcuni secondo cui la Messa una cum sarebbe valida non oggettivamente, ma soggettivamente, cioè in base alla buona o cattiva fede di chi vi partecipi o di chi la celebri. Per cui, per quelli che ignorerebbero che Francesco non sarebbe Papa legittimo, la Messa e i sacramenti sarebbero validi; per chi, in contrario, fosse a conoscenza che Bergoglio non sarebbe Papa, la Messa e i sacramenti sarebbero invalidi. Questa concezione non è né più né meno che un’eresia neo-donatista, in quanto si subordina la validità o meno del sacramento alla buona o cattiva fede, alle condizioni soggettive, o, in ultima analisi, alla santità personale, di chi celebra e di chi partecipa alla Messa o al sacramento. Né può sostenersi che le Messe in unione con Francesco siano invalide, giacché, nella storia della Chiesa non sono mancati Santi in unione con… antipapi. Basti pensare, per fare un nome, al santo spagnolo Vincenzo Ferrer, che sosteneva l’antipapa avignonese contro il legittimo pontefice. E il Santo celebrava, quindi, la Messa in unione con un antipapa… È questione dibattuta a chi spetti dichiarare l’eresia o lo scisma di un Papa, anche perché, come insegna un antico adagio canonistico, Prima Sedes a nemine iudicatur, cioè la Prima Sede non è giudicata da nessuno, come statuisce il can. 1404. Certamente si potrebbe discutere su quale sia l’Autorità ecclesiastica che possa farlo, ma certamente ciò non spetta a semplici parroci o giornalisti che siano. Altro discorso sarebbe quello su chi spetti, in astratto, accertare che un soggetto sia antipapa. A mio avviso, questo sarebbe un compito che spetterebbe ai canonisti e agli storici: la Chiesa potrebbe soltanto prenderne atto, peraltro senza necessità di assumere un provvedimento apposito, ma semplicemente espungendoli dall’Annuario Pontificio. A tal riguardo, va osservato che l’ultima espunzione di antipapi dall’elenco dell’Annuario è avvenuta negli anni Quaranta del secolo scorso. E non c’è stato alcun provvedimento ad hoc né clamore, ma semplicemente queste personalità sono scomparse dall’Annuario, e questo nonostante per secoli siano stati considerati legittimi successori di Pietro e i loro ritratti facciano bella mostra nella serie dei ritratti dei Pontefici nella Basilica romana di San Paolo Fuori le Mura. Come si giunse a questa espunzione? Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento ci furono una serie di studi sulle figure di alcuni di questi (oramai ex) Pontefici da parte di alcuni storici della Chiesa, come il celebre Louis Duchesne. Questi studi conobbero delle interruzioni e delle riprese poiché si temeva che essi fossero espressione di quel modernismo storico e revisionista condannato da Papa Pio X (586). Sta di fatto, come detto, che, per secoli, queste figure furono considerate papi legittimi. Faccio alcuni esempi. Papa Martino V si considerava successore di Giovanni XXIII Cossa (antipapa), mentre considerava antipapa quello che invece era il papa legittimo, cioè Gregorio XII. Potrei richiamare l’esempio di Leone XIII, che considerava legittimo l’antipapa Alessandro V, tanto da finanziare il restauro della sua tomba a Bologna. O si pensi al papa Gregorio VII, che considerava legittimo il predecessore Gregorio VI, che fu deposto e ritenuto sostanzialmente antipapa dal sinodo di Sutri in quanto simoniaco e, quindi, nulla la sua elezione. E il bello è che tuttora Gregorio VI è considerato Papa legittimo. Un altro esempio simpatico è quello dell’antipapa Felice II, che solo dal 1904 fu considerato antipapa e poi ininterrottamente dal 1947. Ebbene, questo antipapa è celebrato, nel rito in forma extraordinaria, quale santo pontefice ed è commemorato al 29 luglio. Il Martirologio edito da Giovanni Paolo II non lo contempla più. Questi errori di valutazione circa la legittimità di un pontefice sono comprensibili se si considera che ciò che possa dire un Papa di un altro, reputandolo legittimo, non è questione di fede o di morale, ma solo storico-giuridica. Ergo, il Papa è sempre fallibile quando formula un siffatto giudizio o quando dovesse riconoscere altri come pontefici. Sì, ci sono stati santi che hanno ritenuto papi validi personaggi che poi sono stati annoverati tra gli antipapi dalla Chiesa. Un esempio per tutti: san Vincenzo Ferrer, autore del trattato De moderno schismate, scritto per difendere la legittimità canonica dell’elezione di un antipapa (Clemente VII), il quale è famoso, invece, per essersi opposto al papa legittimo (Urbano VI) e di aver avviato lo scisma della Chiesa d’Occidente. Quest’antipapa, peraltro, è anche famosissimo per aver giudicato, contestandola, l’autenticità della Sindone (all’epoca a Lirey). Poco varrebbe, dunque, invocare la buona fede del Santo valenciano e affermare che, essendo il soggetto in buona fede, la Messa – anche se da lui celebrata in unione con un antipapa – fosse valida. Caterina da Siena, che sosteneva, invece, il Papa legittimo (Urbano VI), usò parole molto dure tanto verso i cardinali che si elessero l’antipapa (tanto da chiamarli “demoni incarnati”, che avevano eletto non un dolce Cristo in terra, cioè un Papa, ma avevano fatto nascere l’anticristo) (587) sia verso coloro che lo appoggiavano. Si riferiva, dunque, anche al santo spagnolo Vincenzo Ferrer? Per la Santa senese, l’elezione di papa Urbano era pienamente legittima e che il vero motivo, che aveva indotto alcuni cardinali a eleggere l’arcivescovo di Ginevra, era da ricercarsi nell’intento di riforma della Chiesa espressa dal Papa e che doveva partire dal sacro Collegio. Ed è significativo che Urbano VI scomunicasse Clemente VII, qualificandolo addirittura come “anticristo”! Quindi, Vincenzo difendeva e celebrava la Messa in unione con quello che il Papa – legittimo – qualificava come “anticristo”!!! Per incidens, questo dell’anticristo è un leitmotiv, quasi un vezzo linguistico o un topos, che ricorre spesso in questi temi. Ha davvero ragione il giornalista e storico Mario Prignano: lo scisma divise santi, beati e re (588), ricordando come l’incertezza su chi fosse l’autentico vicario di Cristo metteva seriamente a rischio anche il giusto premio guadagnato con una vita devota e retta (589). 461 - Cfr. Paolo Rodari– Andrea Tornielli, Attacco a Ratzinger – Accuse e scandali, profezie e complotti contro Benedetto XVI, Casale Monferrato: Piemme (2010), passim; Massimo Introvigne, Attacco a Benedetto XVI. Il papa, la pedofilia e il documentario «Sex, crimes and the Vatican», Verona: Fede & Cultura (2007), passim 462 - Il riferimento a 2Tes 2, 6-7. Scrive l’Apostolo delle Genti nella sua seconda lettera alla comunità di Tessalonica: «E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene». Quell’espressione “chi finora lo trattiene” è resa in greco: μόνον ὁκατέχων ἄρτι ἕως. Il verbo per indicare l’azione del soggetto che impedirebbe il manifestarsi del mistero dell’iniquità è reso con κατέχων, che è un participio presente maschile ed esprime letteralmente il trattenere, il contenere, il frenare. Tra gli autori che hanno letto l’evento della “rinuncia” ratzingeriana come una sorta di rimozione di questo ostacolo vi è senz’altro il filosofo laico Massimo Cacciari, Il potere che frena, Milano: Adelphi Edizioni (2013). Non sono mancati autori che, sempre in questa prospettiva apocalittico-millenarista da “fine dei tempi” siano andati a riesumare persino alcuni testi apocrifi, tra quali alcune sedicenti profezie di San Francesco d’Assisi, che avrebbero intravisto un Papa non eletto canonicamente, che avrebbe perseguitato i figli di Francesco, ecc.: tra questi, v. Maurizio Blondet, Una profezia di San Francesco sulla tribolazione della Chiesa (28 ottobre 2014), in www.effedieffe.com. Su queste profezie francescane, o presunte tali, rinvio, tra i molti a Michele Lodone, La profezia di San Francesco. Autorità, autenticità e identità francescana tra XIV e XV secolo, in Rivista di storia del Cristianesimo, 2019, pp. 359 ss. 463 - Cfr. René Thibaut, La mystérieuse prophétie des Papes, Namur-Paris: Editions J. Vrin (1951), passim. L’Autore scriveva: «L’an 2012, on cessera d’appeler «romaine» l’Église catholique. Le jugement de Dieu qui se produira alors, loin de mettre un terme à l’histoire de l’Église, marquera le début d’une ère nouvelle. L’année 2012 fera époque, comme ont fait époque la ruine de Jérusalem en 70, celle de l’Empire au Ve siècle, celle de la Chrétienté médiévale au XVe» (ivi, p. 22). Cfr. Antonio Socci, Una sorprendete scoperta sull’antica “Profezia di Malachia” relativa ai papi: parla dei nostri anni. Facendo i nomi, blog Lo Straniero, 5 aprile 2018. 465 - Così mons. Nicola Bux, in intervista ad Aldo Maria Valli, Monsignor Nicola Bux: «L’unità si fa nella verità», nel blog Duc in altum (13 ottobre 2018). 466 - Antonio Menniti Ippolito, Pontificati interrotti e pontificati cancellati, in Chiesa e storia, 2014, fasc. 4, pp. 13 ss., partic. p. 27. 467 - Sul punto, non entro nella questione eminentemente teologica se l’accettazione universale di Francesco quale Papa in seguito alla sua elezione fornirebbe la certezza infallibile che l’ufficio papale fosse vacante prima della sua elezione, e quindi che l’abdicazione di Benedetto dal Pontificato fosse valida ed efficace, costituendo ciò quello che i teologi chiamano «fatto dogmatico» e che il rifiuto di fatto dovrebbe ritenersi un peccato mortale indiretto contro la fede. O addirittura diretto contro la fede, alla luce della definizione del Papa Martino V, con la bolla Inter cunctas, del febbraio 1418, indirizzata agli inquisitori e alla gerarchia ecclesiastica e contenente una serie di quesiti da porsi ai seguaci degli eretici John Wycliff e Jan Hus negli interrogatori, al fine di determinare se credessero o no alle verità cattoliche, tra le quali vi era la seguente: «Se crede che il papa, canonicamente eletto, per tutto il tempo in cui è in carica, una volta scelto il proprio nome, è il successore del beato Pietro e possiede la suprema autorità nella Chiesa di Dio» (Martino V, bolla Inter cunctas, 22 febbraio 1418, domanda n. 24, in Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann, Bologna: EDB (1996), 2° edizione bilingue, § 1264, pp. 574-575). Il “fatto dommatico” della pacifica e universale accettazione, a nostro avviso, non sembra toccare la questione della validità o no della “rinuncia” ratzingeriana, dal momento che esso attiene propriamente all’elezione pacificamente e universalmente accettata, non già all’atto compiuto dal “rinunciante”. Del resto, questo “fatto dommatico” non ha impedito che alcune figure di Pontefici, pacificamente e universalmente accettate per tali, fossero messe in discussione, giungendo a negarne la legittimità canonica sino a essere espunte dall’elenco ufficiale dei Papi. Se può essere utile, a tal proposito, mi preme ricordare quel che diceva un insigne moralista americano, parlando del peccato di scisma, concludeva: «[…] Nor is there any schism if one merely transgress a Papal law for the reason that use considers it too difficult, or if one refuses obedience inasmuch as one suspects the person of the Pope or the validity of his election, or if one resists him as the civil head of a state» (Ignatius J. Szal, The Communication of Catholics with Schismatics. A Historical Synopsis and a Commentary, Washington D.C: The Catholic University of America Press (1948), p. 2). Per cui, se sarebbe legittimo resistere o non prestare obbedienza se si nutrissero – ovviamente con ragioni fondate e non capotiche – sospetti sulla persona del Papa o sulla validità della sua elezione, a maggior ragione dovrebbe ammettersi la ricerca scientifica sull’atto di rinuncia di un Pontefice. E questo a prescindere dalla legittimità o no del suo eventuale successore. 468 - Lo riferisce lo stesso Benedetto XVI nella sua intervista al giornalista Jörg Bremer, “Ein Besuch bei Vater Benedikt”, in Frankfurter Allgemeine Zeitung (7 dicembre 2014). Cfr. Redazione, Ratzinger: «Avrei voluto essere chiamato solo padre Benedetto», in La Stampa (8 dicembre 2014). Entrambi gli articoli sono recuperabili online. 469 - Riproduciamo le disposizioni richiamate: Can. 185: «A colui, che perde l’ufficio per raggiunti limiti d’età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito»; Can. 402.1: «Il vescovo, la cui rinuncia all’ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di emerito della sua diocesi e, se lo desidera, può conservare l’abitazione nella stessa diocesi, a meno che in casi determinati, per speciali circostanze, la Sede Apostolica non provveda diversamente». In senso non dissimile vi sono il can. 965.4 e, per quanto concerne i vescovi eparchiali, il can. 211.1 del Codice dei canoni delle chiese orientali. 470 - Il Can. 62 del Codice dei canoni delle chiese orientali afferma: «Il Patriarca che ha rinunciato al suo ufficio conserva il suo titolo e gli onori soprattutto nelle celebrazioni liturgiche; ha pure diritto che gli venga assegnata col suo consenso una degna sede di abitazione e che gli si forniscano i mezzi, provenienti dai beni della Chiesa patriarcale, con cui possa provvedere a un decoroso sostentamento, corrispondente al proprio titolo, fermo restando il can. 60.2 circa la precedenza». 471 - Piotr Majer, Renuncia del Romano Pontifice, in Antonio Viana Tomé– Javier Otaduy Guerìn– Joaquín Sedano Rueda (a cura di), Diccionario general de derecho canònico, vol. VI, Cizur Menor (Navarra): Universidad de Navarra (2012), pp. 932-933: «¿Cuál sería la posición canónica del Romano Pontífice dimitido en la Iglesia? ¿Sería solamente un episcopus consecratus más? Parece que nada obsta que al «Papa emérito» puedan aplicarse, guardando las debidas proporciones, algunas de las indicaciones de carácter teológico del documento della Cong. Episc., Il vescovo emerito, del 2008, sobre todo en cuanto a la participación en la corresponsabilidad en la Iglesia». Cfr. ID., Rezygnacja papieża z urzędu, in Annales Canonici, 2013, pp. 39 ss. 472 - Si allude all’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ABC, El Papa Francisco: «He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico» (18 dicembre 2022), in cui Francesco, alla domanda se avesse in animo di regolare la materia del papato emerito, rispondeva negativamente: «Tengo la sensación de que el Espíritu Santo no tiene ningún interés en que yo me ocupe de estas cosas» (Ho la sensazione che lo Spirito Santo non ha interesse a che mi occupi di queste cose). 473 - Così ricorda Valerio Gigliotti, La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa, Firenze: Olschki Editore (2013), pp. 417 e 422. Cfr. Arsenio Frugoni, Celestiniana, Roma: Istituto storico italiano per il Medioevo (1954), pp. 94-99; Peter Herde, v. Celestino V, santo, in Enciclopedia dei papi, vol. II, Roma: Treccani (2000), p. 467; Mario Dal Bello, Quando un papa si dimette. La storia di Celestino V, Roma: Città Nuova (2019), p. 59. 474 - Cfr. Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XXXIX, Venezia: Tipografia Emiliana (1846), p. 291. 475 - Per es., il farsi portare il SS. Sacramento, l’uso dell’anello piscatorio, l’insegna della Croce sui piedi e l’ombrello papale (cfr. Concilio di Losanna, decr. Tam maxime, 16 maggio 1449, in Francesco Maria Ferrero di Lavriano, Istoria dell’augusta città di Torino, parte II, Torino: Fratelli Zappata (1712), pp. 372-373. Il testo del decreto è riportato anche in Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, t. IV, Torino: Jean Michel Briolo (1780), p. 333 e in Joseph Chmel, Geschichte Kaiser Friedrichs IV, als König (1440-1452), Bamberga: Perthes (1843), pp. 447 s., nt. 1). 476 - Nel caso di Felice V, egli non conservò il nome né l’appellativo di «Sua Santità», ma tornò a essere Amedeo VIII di Savoia. 477 - Carlo I Malatesta, signore di Rimini, quale procuratore di Gregorio XII al Concilio di Costanza, lesse a nome del papa l’atto di rinuncia, con il quale il Pontefice rinunciava al papato e a ogni diritto papale, titolo e possesso: «[…] resigno nomine praefati domini nostri papatum et omne jus papatus, titulum et possessionem, quod, quem et quam habet coram Domino nostro Jesu Christo, qui Ecclesiae suae sanctae est caput, et sponsus in hac sacrosancta Synodo, et universali concilio sanctam Romanam et universlame Ecclesiam repraesentante» (CesareBaronio – OdoricoRinaldi – Giacomo Laderchi, Annales ecclesiastici, a cura di Augustin Theiner, t. 27, 1397-1423, Parigi: Barri-Ducis (1874), pp. 398-399, nonché in Giovan Domenico Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXVII, Venezia: Antonio Zatta (1784), coll. 744-745). 478 - CesareBaronio – OdoricoRinaldi – GiacomoLaderchi, op cit., pp. 399-400. 479 - Ibidem, p. 399. 480 - Si racconta, infatti, che Gregorio avesse consultato un medico giudeo, di nome Elia, il quale si dava alla negromanzia, allo scopo di sapere se sarebbe arrivato a conservare il papato: così ricorda, Laurent Fonbaustier, La déposition du pape hérétique. Une origine du constitutionnalisme?, Parigi: Mare Martin (2016), p. 832. 481 - Il testo è in Giovan Domenico Mansi, op. cit., coll. 733-734. 482 - Cfr. Luigi Tosti, Storia del Concilio di Costanza, vol. II, Roma: Pasqualucci (1887), pp. 44-45. 483 - Ibidem, p. 48. 484 - Ibidem, p. 47. 485 - François-Charles Uginet, v. Correr Antonio, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXIX, Roma: Treccani (1983), pp. 485-488, ipotizza che questo provvedimento fosse causato dalla rivalità tra il Correr e il tesoriere Francesco Novelli. Lo stralcio della bolla è in Heinrich Finke, Acta Concilii Constanciensis, vol. III, Die drei Päpste und das Konzil, Schriften zur Papstwahl, Münster i. W., 1926, n. 151, p. 336, nt. 1. 486 - Nella bolla del 17 luglio, vi è una certa ambiguità: da un lato Gregorio XII si riannoverava nel collegio cardinalizio – sebbene senza specificare il titolo – precisando che ciò faceva in considerazione del fatto che gli fosse assegnato un congruo stato, dall’altro egli affermava di riprendere lo status anteriore alla sua accettazione al Pontificato, a cui non aveva giammai rinunciato con il papato. Questo poteva intendersi che sarebbe tornato a essere cardinale-prete del titolo di San Marco (cioè del titolo, che aveva prima dell’assunzione del papato)? 487 - L’annuncio al papa Gregorio dell’avvenuta rinuncia, compiuta dal Malatesta, è descritta in Heinrich Finke, op. cit., p. 337. 488 - Luigi Tosti, op. cit., p. 48. 489 - La questione del titolo attribuito al cardinale-vescovo Angelo Correr costituisce un problema storico, non essendo una faccenda chiara. Vi sono autori, infatti, che gli attribuiscono la sede vescovile della diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina (insieme al nipote card. Antonio Correr) (cfr. Luigi Tosti, op. ult. cit.); altri autori quella di Frascati e altri ancora quella di Palestrina. Sta di fatto che la cronotassi dei vescovi della diocesi di Porto-santa Rufina annovera solo Antonio Correr (v. Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi sive Summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum Serie, vol. I, Ab Anno 1198 usque ad annum 1431 perducta, Regensberg, 1913 p. 37), mentre la diocesi di Frascati (Tuscolo) annovera Angelo Correr (ivi, p. 39). 490 - Cfr. Aldo Maria Valli, Attenzione: parla Gaenswein. E si sente l’eco di Benedetto, nel blog Duc in altum (11 settembre 2018), che, sebbene si riferisca a un intervento di mons. Gänswein del 2018 relativo alla presentazione del libro di Rod Dreher L’opzione Benedetto presso la Camera dei deputati, nondimeno può ritenersi che questa constatazione possa valere per gli interventi del già segretario particolare svolti in questi ultimi anni. 491 - Georg Gänswein, Il papato rinnovato, in Id., Testimoniare la Verità, con Postfazione di A-W Asserate, Milano: Ares (2022), pp. 59 ss., partic. p. 60. 492 - Ibidem, p. 62. 493 - Guido Ferro Canale, La rinuncia di Benedetto XVI e l’ombra di Carl Schmitt, in Blog di Sandro Magister www.chiesa (26 luglio 2016). 494 - Carlo Fantappiè, Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze, in Chiesa e Storia. Rivista dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, 2014, fasc. n. 4, pp. 91-118, partic. p. 113, nt. 68. 495 - Con Karl Rahner, Joseph Ratzinger condivise in gioventù la fondazione e la direzione della rivista Concilium, da cui poi si dissociò, per ragioni accademiche, fondando, con il teologo von Balthasar, la rivista Communio. Cfr. Joseph Ratzinger, La mia vita. Autobiografia, Cinisello Balsamo: San Paolo (1997), rist. (2005), pp. 107 ss.; Andrea Tornielli, Benedetto XVI. La prima biografia aggiornata del nuovo papa, Milano: Il Giornale (2005), pp. 80 ss. 496 - Karl Rahner, Sull’episcopato, in Nuovi saggi, vol. I, Roma: Edizioni Paoline (1968), pp. 522 ss. 497 - Id., Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis, Freiburg im Breisgau: Herder (1974), passim 498 - Cfr. Gianfranco Ghirlanda, Cessazione dall’ufficio di Romano Pontefice, in Civ. Catt., 2013, I, pp. 459-60: «Nell’eventualità che il papa cessi dal suo ufficio non a causa di morte, non perderebbe mai tale potestà, in quanto conferita da un atto sacramentale che comporta un carattere indelebile». 499 - Roberto De Mattei, Uno e uno solo è il papa, in Blog Roberto De Mattei (15 settembre 2014), nonché in appendice a S. Magister, Regnante ed “emerito”. L’enigma dei due papi, Blog www.chiesa.espressonline.it (15 settembre 2014). 500 - Roberto De Mattei, op. ult. cit. 501 - Ibidem 502 - Id., Il vero pasticcio è la coabitazione dei due papi, in Blog Roberto De Mattei (15 gennaio 2020). 503 - Cfr. Ulrich Nersinger, L’ultima tiara, in L’Osservatore Romano (17 novembre 2019), p. 7, il quale ha osservato che: «Anche se il Pontefice [Paolo VI, N.d.R.] non vuole che dalla sua rinuncia alla propria tiara personale consegua l’abolizione dell’insegna, non si può negare che il passo da lui compiuto contribuirà in modo decisivo al fatto che tutti i suoi successori rinunceranno all’antico rito dell’incoronazione con la tiara. L’incoronazione del papa, tra l’altro, non aveva alcuna rilevanza giuridica. A chi la portava, la tiara non aggiungeva nulla che già non gli spettasse in virtù del suo ministero. Per questo la rinuncia a quella cerimonia non è stata particolarmente difficile per i successori di Paolo VI». 504 - La dottrina canonistica pacificamente ammette l’invalidità della rinuncia papale provocata da violenza fisica (can. 125 § 1), da errore sostanziale (can. 126) e da dolo sostanziale, tale cioè che causi un errore sostanziale: così Roman Walczak, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel codice di diritto canonico del 1983, Città del Vaticano: LEV (2015), p. 125. Si puntualizza, riguardo all’errore, che «el error substancial, al que se equipara la ignorancia substancial, y que consiste en el juicio equivocado sobre algún elemento esencial de la renuncia» (Antonio Ciudad Albertos, Renuncia de Benedicto XVI a la sede petrina. Aspectos canónicos, in Estudios eclesiásticos, 2013, p. 823). 505 - Il testo è riprodotto in Angela Ambrogetti, I Pontefici e la rinuncia al governo della Chiesa: la lettera di Paolo VI, in Acistampa(17 maggio 2018). A quanto risulta, Paolo VI avrebbe scritto due lettere, una contenente la rinuncia e l’altra di accompagnamento, indirizzate rispettivamente al cardinale decano del Collegio cardinalizio, il francese Eugène Tisserant e al cardinale Segretario di Stato, all’epoca card. Amleto Giovanni Cicognani. Queste sono state rese note dal card. Giovanni Battista Re nel 2017 (Red. Cath, Il cardinale Re: Paolo VI aveva pronte le lettere per la rinuncia, in Avvenire (25 agosto 2017)) e pubblicate da mons. Leonardo Sapienza, attuale Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, che nel suo libro La barca di Paolo, Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni (2018), passim. Le due lettere sarebbero state scritte, come risulta dalla data ivi apposta, nella domenica del buon Pastore, II dopo Pasqua, il 2 maggio 1965, nel secondo anno di Pontificato del papa, durante il Concilio Vaticano II, prima che si ammalasse. Cfr. Andrea Tornielli, La lettera inedita di Paolo VI: così ipotizzò le sue dimissioni, in La stampa (16 maggio 2018). 506 - Cfr. Fabio Tonacci, Vaticano, stop a carte e bancomat Sospesi i servizi di pagamento, in La Repubblica, 3 gennaio 2013. 507 - Cfr. Redazione, Ripristinati in Vaticano i pagamenti con bancomat e carta di credito, in Il Sole 24ore, 12 febbraio 2013. In quest’articolo si precisava, in ogni caso, che il blocco non aveva «riguardato disfunzioni o irregolarità nella rete vaticana agganciata ai circuiti internazionali di pagamento, ma singole operazioni effettuate presso un “bancomat” vaticano». 508 - Così, Roman Walczak, op. cit., p. 128. 509 - Così Marina Caffiero, v. Pio VI, in Enciclopedia dei papi, vol. III, Roma, 2000, pp. 492 ss., partic. p. 505. 510 - Leggo su Il Sole 24ore: «Il blocco dei bancomat in Vaticano scattato all’inizio del 2013 è scaturito da una segnalazione della procura di Roma, nell’ambito dell’inchiesta su presunte attività di riciclaggio legate ad operazioni avviate dallo Ior, la banca della Santa Sede. La notizia è trapelata ieri, pochi giorni dopo la decisione della Banca d’Italia di negare a Deutsche Bank Italia, l’unico istituto che da anni gestiva i Pos con il bancomat e il circuito mondiale delle carte di credito nel piccolo stato vaticano, l’autorizzazione a operare. Infatti – secondo quanto appreso – la negazione da parte di palazzo Koch a partire dal 6 dicembre scorso dell’autorizzazione è avvenuta per assenza dei presupposti giuridici. In particolare, per l’assenza, presso lo Stato della Città del Vaticano, di una legislazione bancaria e finanziaria e di un sistema di vigilanza prudenziale, ulteriori rispetto a quelli in materia di antiriciclaggio» (Carlo Marroni, Vaticano, i bancomat bloccati dalla Procura, in Il Sole 24ore, 8 gennaio 2013). 511 - Cfr. Redazione, I vescovi si rifiutano di stringere la mano a Benedetto XVI? È una videobufala, in Tempi, 5 aprile 2013. 512 - Benedetto XVI, Decl. Non solum, 10 febbraio 2013, in AAS [CV], 2013, pp. 239-240, partic. p. 239. 513 - Cfr., in ambito canonistico, Stefano Violi, La rinuncia di Benedetto XVI. Tra diritto, storia e coscienza, in Rivista Teologica di Lugano, n. 2, giugno 2013, pp. 203-214, partic. p. 214. 514 - Vito Mancuso, I due pontefici in Vaticano, in La Repubblica(12 febbraio 2013), p. 3. Cfr. Giuseppe Di Salvo, op. cit., pp. 142 ss. 515 - Stefano Violi, op. cit., p. 204. 516 - Ibidem, p. 214. 517 - Juan Ignacio Arrieta, Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico, in Ius ecclesiae, 1995, pp. 91-113, partic. pp. 92-93. L’Autore richiama, inoltre, alcuni studi, tra i quali quello del canonista belga Rik Torfs, Auctoritas-potestas-iurisdictio-facultas-officium-munus. Un’analisi dei termini, in Concilium, 1988, fasc. n. 3, pp. 93 ss. nonché soprattutto il contributo dell’odierno cardinale arcivescovo di Budapest Péter Erdő, Ministerium, munus et officium in Codice Iuris canonici, in Periodica de re canonica, 1989, pp. 411-436. Di quest’ultimo Autore, v. anche ‘Sacra ministeria’ e funzioni pubbliche nella Chiesa, in Folia Theologica, 1993, pp. 67-76. 518 - Péter Erdő, Uffici e funzioni pubbliche nella Chiesa, in Anuario Argentino de Derecho Canónico, 1996, pp. 47-105, partic. p. 47. 519 - Una tabella di sintesi dei significati, l’Autore la pubblica in appendice al suo contributo, ibidem, pp. 102-104. 520 - Geraldina Boni, Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto, Bologna: Bononia University Press (2015), p. 180. 521 - Ibidem, pp. 181-183. 522 - Parlo di contro-Declaratio o, se vogliamo, nuova Declaratio perché, al di là dell’intitolazione data all’atto, il can. 332 § 2 non prevede che la rinuncia sia compiuta in latino e dinanzi al Collegio dei cardinali, convocati in apposito Concistoro. Il canone in discorso richiede che essa, oltre a essere libera, sia rite manifestetur, che, come vedremo, consente al Papa ampia libertà di forma in cui compiere tale atto, potendola fare, perciò, persino in un’apposita udienza pubblica dei fedeli. Perciò, laddove si ravvisi alcuna contraddizione tra le due dichiarazioni di rinuncia – quella del 10-11 febbraio – e quella del 27 febbraio, può ben parlarsi, per la seconda, di una contro-Declaratio, che ridimensiona e interpreta la portata della prima, tanto più che la prima non era ancora divenuta efficace stante l’apposizione del termine iniziale apposto dal Papa alla Declaratio del 10-11 febbraio, che avrebbe esplicato i suoi effetti a partire dalle ore 20 del 28 febbraio seguente. Un autore parla riguardo a questa testimonianza di Benedetto XVI di «declaratio secunda», che costituirebbe «la vera novità del gesto di Ratzinger» (così Valerio Gigliotti, op. cit., p. 414; Id., Un soglio da cui non si scende…? Aspetti della renuntiatio papae la storia giuridica medievale, in Eph. iuris can., 2016, p. 65). 523 - BenedettoXVI, Udienza generale, Mercoledì 27 febbraio 2013 in L’Osservatore Romano (28 febbraio 2013), p. 1. 524 - Peter Seewald (a cura di) – Benedetto XVI, Ultime conversazioni, Milano: Garzanti (2016), pp. 38-39. 525 - Cfr. Steven O’Reilly, Valid? The Resigantion of Pope Benedict XVI. The case against the Benepapists, Atlanta-Woodstock: Hartwell Publishing Company (2022), pp. 78 ss. 526 - Emblematico, a questo riguardo, è un articolo del celebre scrittore cattolico Vittorio Messori, Ratzinger non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due papi, in Corriere della sera (28 maggio 2014), p. 23. 527 - A quest’ultimo riguardo, vorrei segnalare una singolarità. Nella relazione tenuta da mons. Georg Gänswein, in occasione della presentazione del libro di don R. Regoli, Oltre la crisi, presso la Pontificia Università Gregoriana, in data 20 maggio 2016, il Segretario di Benedetto XVI così si esprimeva: «Dall’elezione del suo successore Francesco il 13 marzo 2013 non vi sono dunque due papi, ma de facto un ministero allargato – con un membro attivo e un membro contemplativo. Per questo Benedetto XVI non ha rinunciato né al suo nome, né alla talare bianca. Per questo l’appellativo corretto con il quale rivolgerglisi ancora oggi è “Santità”; e per questo, inoltre, egli non si è ritirato in un monastero isolato, ma all’interno del Vaticano – come se avesse fatto solo un passo di lato per fare spazio al suo successore e a una nuova tappa nella storia del papato che egli, con quel passo, ha arricchito con la “centrale” della sua preghiera e della sua compassione posta nei Giardini vaticani». Questo testo è possibile reperirlo in Benedetto XVI, la fine del vecchio, l’inizio del nuovo: L’analisi di Georg Gänswein, in Acistampa (21 maggio 2016). Questo passaggio della relazione, però, scompare nel testo, che raccoglie gli interventi del prelato, che abbiamo segnalato in precedenza. Ricompare un fugace accenno al c.d. papato allargato in chiusura del contributo Il papato rinnovato, cit., p. 70: «[…] Come prima di lui Peter Seewald e altri, anche Roberto Regoli – in qualità di sacerdote, professore e studioso – si immette così in quel ministero petrino allargato intorno ai successori dell’apostolo Pietro, e per questo oggi di cuore lo ringraziamo». Come dire… n il papato allargato esce dalla porta per rientrarvi dalla finestra. Questo ministero di Pietro allargato lo confermava anche Benedetto XVI nelle sue Ultime conversazioni con Peter Seewald come ci assicura Lorenzo Bertocchi, Ratzinger: «Io, un conservatore riformatore Ho interpretato in chiave moderna la fede», in La nuova bussola quotidiana (9 settembre 2016). 528 - Cfr. Peter Seewald (a cura di) – Benedetto XVI, op. cit., pp. 139 s. Benedetto dichiarava che aveva prestato particolare attenzione al contenuto teologico e canonico dell’atto: «[…] Doveva però essere preciso e prestare attenzione ai dettagli, al fine di prevenire controversie in riferimento al diritto canonico» (ivi, p. 139). Sebbene, poi, il risultato presenti poi delle criticità. 529- Cfr. Estefania Acosta, Benedetto XVI: papa «Emerito»?, s.l. (2021), pp. 80 ss. 530 - Così Valerio Gigliotti, La tiara deposta, cit., p. 397, nt. 35. Spiega il prof. Gigliotti che l’avverbio latino rite sia espressione polisemica, che spazierebbe da un richiamo a una ritualità codificata, quasi liturgica, alla mera opportunità per giungere al giudizio di valore. L’Autore spiega di aver reso quell’espressione con “secondo le opportune usanze” proprio per sottolineare il valore della consuetudine che, nel caso della pronuncia di una declaratio di rinuncia, assume. 531- Cfr. Gianfranco Ghirlanda, op. cit., p. 447, secondo cui – richiamandosi al can. 189 § 1 del Codice – sarebbe «sufficiente che la rinuncia sia fatta pubblicamente, almeno davanti a due testimoni, per iscritto o oralmente». 532 - Sul punto, v. Antonio Ciudad Albertos, Renuncia de Benedicto XVI a la sede petrina: aspectos canónicos, in Asociación Española de Canonistas (a cura di), Problemáticas y respuestas. realidad actual y derecho canónico. Actas de las XXXIII Jornadas de Actualidad Canónica, organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 3-5 de abril de 2013, Madrid: Editorial Dykinson (2014), pp. 141 ss. partic. pp. 149-150. 533 - Così Luca Crippa, Napoleone e i suoi due papi. La Chiesa alle prese con il primo “Anticristo” della storia moderna, Cinisello Balsamo: San Paolo (2021), pp. 152-153. Secondo gli storici, esistevano ben due progetti volti a sostituire papa Braschi con un antipapa: «Era intenzione dei Francesi, d’accordo con alcuni giacobini romani, di costringere il Braschi a rinunziare al papato e di procedere poi all’elezione democratica del nuovo “patriarca d’Occidente” da parte del clero inferiore e del popolo di Roma, secondo l’antica consuetudine della Chiesa dei primi secoli. La persona prescelta come nuovo vescovo di Roma sarebbe stata monsignor Emanuele De Gregorio, luogotenente civile del cardinale vicario, personaggio che era ritenuto gradito al popolo romano e ben accetto agli stessi Francesi. Il piano, che sarebbe fallito perché il De Gregorio, venutone a conoscenza, fuggì a Siena dal Pontefice che fu così informato di tutta la macchinazione, avrebbe condotto all’elezione di un antipapa e ad uno scisma nella Chiesa e soprattutto, attraverso l’elezione popolare del vescovo di Roma, alla riduzione delle attribuzioni di questo, rese eguali a quelle degli altri vescovi. Anima del progetto […] sarebbe stato l’abate C. Della Valle, responsabile della politica ecclesiastica della Repubblica Romana fino all’aprile del 1798 e sostenitore di una riforma della Chiesa in senso evangelico-giacobino che egli tentò di avviare anche progettando una romana costituzione civile del clero e sottoponendo le nomine dei parroci al controllo del potere civile. Un analogo progetto emerge da un rapporto di Talleyrand al Direttorio redatto al tempo del breve soggiorno del Papa a Briançon, durante la deportazione in Francia: in esso l’ex vescovo di Autun proponeva di nascondere P. e di far spargere la voce della sua morte, per farlo poi ricomparire quando fosse stato eletto il successore. In tal modo si sarebbe determinato “un schisme salutaire aux principes républicains”, con due o anche più papi contrapposti. […] Entrambi i progetti, al di là della loro presunta fantasiosità o irrealizzabilità, tuttavia rivelavano l’acuta consapevolezza delle rilevanti conseguenze suscitate dalla morte, reale o presunta, di P., e sono indicativi sia di quanto l’idea dello scisma religioso come arma politica, tesa a distruggere il centro dell’unità della Chiesa, fosse diffusa tra i Francesi, sia delle reali aspirazioni alla riforma ecclesiastica di molti filorivoluzionari italiani» (così Marina Caffiero, op. cit., p. 506). Cfr. sul punto, Vittorio E. Giuntella, Di un progetto di eleggere a Roma un antipapa durante l’esilio di Pio VI, in Rassegna Storica del Risorgimento, 1955, pp. 68-71; Maria Gemma Paviolo (a cura di), I Testamenti dei cardinali. Emanuele de Gregorio (1758-1839), s.l. (2017), pp. 18-20. 534 - Va ricordato che Enea Silvio Piccolomini, prima di assurgere al soglio pontificio col nome di Pio II, aveva professato, in una serie di trattati, le idee conciliariste, affrontando la grande questione ecclesiastica del tempo, la posizione e l’autorità dei concilii. Il ciclo inizia con la sua difesa incondizionata della teoria conciliare nei Dialoghi composti a Basilea (1440). Divenuto papa, il 26 aprile 1463, con la bolla di ritrattazione In minoribus agentes, indirizzata all’Università di Colonia, che era stata la destinataria dei suoi scritti in difesa della superiorità del concilio su Eugenio IV, proclamò il suo definitivo ripudio dell’eresia conciliarista sostenuta in precedenza, affermando di aver sbagliato come san Paolo in gioventù prima della conversione. La bolla culminava nell’esclamazione che abbiamo riportato in testo. Cfr. JohnN.D. Kelly, Vite dei papi, Casale Monferrato: Piemme (2005), p. 418. Gli scritti di ritrattazione delle dottrine conciliariste sono raccolti in Carlo Fea, Pius II P.M. a calumniis vindicatus, Roma: Francesco Bourlie (1823). 535 - Marco Politi, Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione, Bari: Laterza (2014), p. 34. 536 - Cfr. Julia Meloni, La Mafia di San Gallo, Verona: Fede & Cultura (2022); Taylor Marshall, Gli infiltrati. Il complotto per distruggere la Chiesa dall’interno, Verona: Fede & Cultura (2022). 537 - Cfr. Cardinal Godfried Danneels, Publically Admits to Being Part of the ‘Sankt-Gallen Mafia’ Club Opposed to Pope Benedict XVI, in National Catholic Register, 24 settembre 2015. 538 - In particolare, ne ha parlato durante la conferenza di presentazione di un volume nel maggio 2016 all’Università Gregoriana: George Gänswein, op. cit., partic. pp. 62 s. 539 - Secondo taluno, la regione di San Gallo sarebbe stata «associata al satanismo rituale ed al comunismo» (Taylor Marshall, op. cit., pp. 179 ss.). Per quest’autore, in Svizzera si sarebbe rifugiato Vladimir Lenin durante il suo esilio, dove conobbe Fritz Platten, originario di San Gallo, così anche l’esoterista Aleister Crowley e persino l’ex cardinal Mc Carrick, predatore sessuale seriale, privato da Francesco del cardinalato e ridotto allo stato laicale, avrebbe soggiornato a San Gallo tra il 1949 e il 1950 e sarebbe tornato periodicamente in quella cittadina. In più la cittadina svizzera ospiterebbe il Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, o CCEE). Per cui, si conclude sostanzialmente che «San Gallo sia servita come centro di infiltrazione per reclutare giovani uomini destinati al sacerdozio» e che il giovane orfano Theodore McCarrick avesse fornito a un non chiarito gruppo di potere «un agente perfetto per infiltrarsi nella Chiesa cattolica americana con la pedofilia, la magia sessuale e il comunismo» (ivi, p. 187). 540 - Il resoconto migliore dell’andamento delle votazioni nel conclave del 2005, lo abbiamo grazie alle annotazioni di un anonimo porporato, mai smentite, che furono pubblicate nel 2009 dalla rivista di geopolitica Limes: Lucio Brunelli, Così eleggemmo papa Ratzinger, in Limes, 31 agosto 2009. Cfr. anche Marco Ansaldo, Un altro papa. Ratzinger, le dimissioni e lo scontro con Bergoglio, Milano: Rizzoli (2020), pp. 43 ss.; Taylor Marshall, op. cit., pp. 188-190. 541 - Cfr. Julia Meloni, op. cit., p. 27. L’Autrice si domanda, in effetti, se non ci fosse stato alcun accordo, come mai il card. Martini avrebbe dato istruzioni ai suoi di appoggiare Ratzinger? E perché il card. Bergoglio, durante una pausa pranzo, avrebbe indicato ai suoi sostenitori il nome di Ratzinger? 542 - Cfr. Aldo Maria Valli, Benedetto XVI. Il pontificato interrotto, Milano: Mondadori (2013), p. 30. 543 - V. Antonio Socci, Non è Francesco, Milano: Mondadori (2014), partic. pp. 108 ss. 544 - Cfr. «Quando Martini disse a Ratzinger: la Curia non cambia, devi lasciare», in Corriere della sera (16 luglio 2015); Gelsomino Del Guercio, Quel cardinale «strisciante» che voleva far cadere Ratzinger e Martini, in Aleteia (18 luglio 2015); Andrea Tornielli, Martini, la rinuncia di Benedetto e il conclave 2005, in La Stampa (18 luglio 2015). 545 - Cfr. Francesco Antonio Grana, Nuovo papa, cordata europea per Scola: grandi manovre per il pontefice ciellino, in Il fatto quotidiano (7 marzo 2013). 546 - Andrea Gagliarducci, Giovanni Paolo II: i suoi inediti pubblicati in Polonia, in Korazym (28 gennaio 2014). 547 - Ecco il testo: «I cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d’ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l’elezione» 548 - George Gänswein, op. cit., pp. 66-68. 549 - Il testo non è reperibile in rete. Tuttavia, è riportato in Valerio Gigliotti, op. cit., pp. 416-417. Cfr. Mimmo Muolo, Benedetto XVI sarà papa emerito, in Avvenire (27 febbraio 2013), p. 19. 550 - Questo titolo era proposto, tra gli altri, da Gianfranco Ghirlanda, op. cit., p. 448. In senso analogo, cfr. Salvatore Mazza, Valdrini: «Da Ratzinger un tesoro di saggezza», in Avvenire (14 febbraio 2013): per il prof. Patrick Valdrini, Ratzinger avrebbe avuto «lo statuto di vescovo emerito di Roma, membro del Collegio dei vescovi, e che la primazia della Chiesa universale sarà affidata solo al suo successore sulla sede vescovile». Escludeva invece la dignità di cardinale. A onor del vero, c’è stato anche qualche canonista che aveva suggerito di congiungere al titolo di “papa emerito” pure quello di cardinale. Singolare ci sembra, in questo senso, la proposta del canonista Edward Peters, secondo cui il papa resignante si sarebbe dovuto chiamare «His Holiness, Joseph Ratzinger, Papa Emeritus and Cardinal of the H. R. C.» (così Edward Peters, Papa Emeritus, in In the Light of the Law A Canon Lawyer’s Blog, 11 febbraio 2013). In realtà, è significativo che dopo la sua “rinuncia”, Benedetto XVI non sia stato riannoverato nel Collegio dei cardinali, neppure tra quelli ultraottantenni, e ciò in quanto il cardinale, eletto al supremo pontificato, rinuncia al titolo cardinalizio. Ce lo conferma anche Carlo Fantappiè, nella sua intervista di Umberto Folena, Quando Pietro depone le chiavi, in Avvenire (21 febbraio 2013), p. 4. 551 - Cfr. Edward McNamara, Indulgenza in punto di morte, in Zenit (18 ottobre 2013). 552 - Le due lettere al card. Walter Brandmüller sono state pubblicate, in originale, per la prima volta, dal quotidiano tedesco Bild (cfr. Nikolaus Harbusch, Die geheimen Botschaften der Briefe von Papst Benedikt, in Bild, 21 settembre 2018). In precedenza, il contenuto era stato pubblicato dal New York Times (Jason Horowitz, In Private Letters, Benedict Rebukes Critics of Pope Francis, in The New York Times (20 settembre 2018). 553 - La lettera in questione è pubblicata sul profilo Twitter del card. Sarah. 554 - Francesco Calzoni, Esposizione in forma di catechismo dei dogmi, precetti e sacramenti della cristiana cattolica religione, t. IV, parte I, Bologna: Longhi (1791), p. 461. 555 - Ricordiamo, per es., il Saluto di Francesco nella Festa di accoglienza dei giovani, in occasione del viaggio apostolico a Rio De Janeiro in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, 25 luglio 2013, in cui Francesco così si esprime: «[…] E voi, giovani, avete risposto in tanti all’invito del papa Benedetto XVI, che vi ha convocato per celebrarla. Lo ringraziamo con tutto il cuore! A lui che ci ha convocati oggi, qui, inviamo un saluto e un forte applauso». 556 - Cfr. Gianpaolo Montini, «Il vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare rinuncia». Considerazioni sul canone 401 § 1, in Autori Vari, Il vescovo e la sua Chiesa. Quaderni teologici del Seminario di Brescia, Brescia: Morcelliana (1996), pp. 215 ss., partic. p. 218, il quale affermava, in maniera chiara, non essere soggetto alla normativa di cui al can. 401 in primis «il Romano Pontefice». Cfr. ivi, pp. 236 ss. 557 - Cfr. Manuel Jesus Arroba Conde, Un “papa emerito” non può esistere. Intervista, in Zenit (13 febbraio 2013). Singolarmente dura è la critica rivolta all’istituto dall’autorevole Mons. G. Sciacca, segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, il cui parere non può essere trascurato: cfr. Andrea Tornielli, Sciacca: “Non può esistere un papato condiviso”. Intervista a Mons. G. Sciacca, in La Stampa (16 agosto 2016). Quest’ultimo A. spiega: «L’espressione di “papa emerito” o “Pontefice emerito” sembrerebbe configurare una sorta di potestà pontificia distinta da un suo ulteriore tipo di esercizio. Un esercizio non individuato, mai definito in alcun documento dottrinale, e di impossibile comprensione, che sarebbe stato oggetto di rinuncia. Argomentando in questo modo, parte della potestà pontificia rimarrebbe all’emerito, anche se, si dice, interdetta nell’esercizio. Ma l’interdizione dall’esercizio di ciò che per sua natura è essenzialmente libero nell’esercizio (potestas) è un nonsenso. Appare perciò evidente l’irrazionalità di questa tesi e i possibili errori interpretativi che ne derivano». 558 - In questo senso si segnala la posizione del card. Gerhard Ludwig Müller, Prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede (Gian Guido Vecchi, Il cardinale Müller: «Distruggere un principio è un pericolo per tutta la Chiesa», in Corriere della Sera, (14 gennaio 2020), p. 19). 559 - Carlo Fantappiè, Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze, in Chiesa e Storia. Rivista dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, 2014, fasc. n. 4, pp. 91-118, partic. p. 109. 560 - Geraldina Boni, Due papi a Roma?, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2 novembre 2015, p. 51. 561- Ibidem, p. 59. 562 - Cfr. sul punto Stefano Violi, La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza, in Riv. Teol. Lugano, 2013, pp. 203 ss., ma anche Vittorio Messori, Ratzinger non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due papi, in Corriere della Sera (28.5.2014), p. 23. 563 - Tommaso de Vio (card. Gaetano), De comparatione auctoritatis Papæ et Concilii cum apologia eiusdem tractatus, cap. XXI, nn. 305-306, in JacquesV.M. Pollet (a cura di), Scripta theologica, I, Roma 1936, pp. 135-136. Si ricorda che l’opuscolo fu scritto in occasione del Concilio scismatico di Pisa, indetto quell’anno da alcuni cardinali vicini al re di Francia, Luigi XII, contro papa Giulio II. Il card. De Vio, dunque, intese prendere le difese del Papa, contestando le tesi gallicane (cfr. Jacques V.M. Pollet, Proemio, ivi, pp. 3-4). 564 - Cfr. can. 1101. 565 - Benedetto XVI, Udienza generale, 27 febbraio 2013, cit. 566 - Un caso particolare è rappresentato dall’antipapa Giovanni XXIII Cossa, che, rinunciato al pontificato – sia pur illegittimo – e ricreato cardinale dal papa Martino V, quando morì fu sepolto nel Battistero di S. Giovanni Battista, in Firenze, in una monumentale tomba realizzata da Michelozzo e in cui l’effigie del Cossa, in bronzo dorato, era opera del Donatello. La particolarità era che in questo monumento, sotto il sarcofago, quasi a sorreggerlo, campeggiavano tre stemmi: uno della Chiesa di Roma con il triregno e le chiavi petrine, e due di Baldassarre Cossa, il primo come Papa e l’altro come cardinale diacono, cioè la dignità che ricopriva quando, nel 1410, fu eletto al Soglio petrino (non come cardinale vescovo, cioè la dignità che gli fu conferita da Martino V dopo la deposizione). Gli stemmi, come anche l’epigrafe «Joannes quondam papa XXIII», cioè «Giovanni XXIII un tempo papa», dicevano che chi vi era sepolto era vissuto cardinale e morto da pontefice, sia pure ex. Ovviamente, quando la cosa giunse agli orecchi del papa regnante, Martino V, questi andò su tutte le furie, perché ciò delegittimava il Concilio che aveva deposto il Cossa e il papa Martino V che gli aveva conferito il galero cardinalizio. Per questo chiese che fosse cancellata quell’iscrizione, ma i fiorentini non vi acconsentirono. Cfr. Mario Prignano, Giovanni XXIII. L’antipapa che salvò la Chiesa, Brescia: Morcelliana (2019), pp. 458 ss. 567 - Così Jean-Philippe Goudot, Benoît XVI: quels modèles pour une renonciation?, in Nouvelle revue théologique, 2014, p. 58. 568 - Ricordavo queste esigenze, commentando uno studio della prof.ssa Boni, in un mio intervento, Sede impedita e rinuncia del papa: proposte per una normativa, sul blog Duc in altum di Aldo Maria Valli (25 agosto 2021). Il lavoro a cui si faceva riferimento era quello di Geraldina Boni, Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2021, fasc. n. 14. 569 - Esiste anche un sito ufficiale che raccoglie questi contributi, denominato Gruppo di ricerca – Sede romana totalmente impedita e status giuridico del vescovo di Roma che ha rinunciato, all’url https://www.progettocanonicosederomana.com/. 570 - La normativa, qualora adottata, potrebbe regolamentare al più le future rinunce (cfr. can. 9 Codice di Diritto Canonico: «Le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominatamente in esse delle cose passate»), cioè quelle che potrebbero verificarsi successivamente alla promulgazione dell’eventuale legge canonica proposta, ma non potrebbe “sanare” – ammesso che fosse possibile – la rinuncia di Benedetto XVI e tutto ciò che ne è scaturito nonché sciogliere i nodi e le incertezze relative a quell’atto compiuto l’11 febbraio 2013, e ciò per la semplice ragione che Benedetto XVI quando ha compiuto quell’atto l’ha fatto non potendo tenere conto di una futura disciplina. 571 - Alcuni autori affermano che, nulla disponendo le codificazioni del 1917 e del 1983, abbiano lasciato la porta aperta per future regolamentazioni: «Das Recht setzt fest, wie der Rücktritt zu erfolgen hat, was danach kommt, ist offen» (Felix Neumann, Der “emeritierte Papst”: Eine Tradition wird gemacht, in katholisch.de, 11 agosto 2017). 572 - Puntualizzava La Civiltà Cattolica all’indomani della promulgazione della Cost. Ap. del 1996 di Giovanni Paolo II: «la potestà del Pontefice è divina, ma il modo di elezione è umano, come umana e storica è l’istituzione del conclave» (Giovanni Marchesi, Le nuove norme per l’elezione del papa, in Civ. Catt., 1996, II, quad. 3501, p. 284). Nella lunga storia della Chiesa, in effetti, non sono mancati Pontefici espressamente designati e posti sul soglio di Pietro per volontà imperiale, soprattutto nei secoli turbolenti a ridosso dell’anno 1000, ma di cui nessuno dubita della legittimità. Si pensi per es. a Clemente II, Damaso II e Leone IX su indicazione dell’imperatore Enrico III. 573 - Molti autori canonistici ravvisano nel termine apposto da Benedetto XVI alla sua Declaratio a partire dalla quale la “rinuncia” sarebbe stata efficace (ore 20 del 28 febbraio 2013) «un puro e semplice differimento dell’efficacia di un atto ormai perfetto, non bisognoso di ulteriori atti, a un momento preciso e certo», giacché tale «posposizione dell’efficacia dell’atto al termine iniziale è ritenuto un tempo a servizio della preparazione della situazione di sede vacante e dell’ultimazione delle misure di governo in corso» (Fernando Puig, La rinuncia di Benedetto XVI all’ufficio primaziale come atto giuridico, in Ius ecclesiae, 2013, p. 806). Una difficoltà che potrebbe essere avanzata alla tesi che abbiamo prospettata è l’assenza di disposizioni canoniche invalidanti un’accettazione o una rinuncia qualora venga apposto un termine o una condizione (cfr. can. 10). A nostro avviso, la questione non sarebbe differente da quella che si verifica nell’ambito del sacramento del matrimonio: anche lì non esiste alcuna norma irritante che vieti espressamente l’apposizione di un termine iniziale o finale. Qualora vi fosse apposto, il matrimonio sarebbe nullo perché si verrebbe a toccare la natura stessa del vincolo nuziale, per sua natura indissolubile. Un’eccezione esiste riguardo alla condizione, introdotta nella codificazione del 1983, che può essere apposta al matrimonio, purché passata o presene e non futura, con determinate accortezze previste dalla legge canonica (can 1102). In buona sostanza, a nostro avviso, l’apposizione di un termine o condizione a un atto di accettazione o rinuncia ne snaturerebbe l’indole, con la conseguenza che essi dovrebbero ritenersi, se non invalidi, almeno inesistenti giuridicamente. 574 - Il progetto di legge canonica redatto dal Gruppo di ricerca – Sede romana totalmente impedita e status giuridico del vescovo di Roma che ha rinunciato, denominato Progetto di Costituzione Apostolica sulla situazione canonica del vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, prevede all’art. 1 § 4: «Se l’atto della rinuncia non è immediatamente efficace, deve indicare, preferibilmente con precisione, il termine dal quale avrà effetto, che non deve essere eccessivamente posticipato; a partire da questo momento, la rinuncia non può più essere revocata». Il progetto in parola è reperibile all’url https://www.progettocanonicosederomana.com/progetti. 575 - Antonio Montanari, Dizionario istruttivo per la vita civile, t. I, lett. A, B e C, Verona: Moroni (1776), p. 370, nt. 55. 576 - La notizia che il Papa Pio VII avrebbe predisposto un atto di rinuncia in occasione di Napoleone nel 1805, durante il suo soggiorno a Parigi, per reagire alle dicerie che volevano che l’Imperatore volesse trattenere quale prigioniero in Francia, ce la fornisce il biografo del pontefice, Artaud de Montor, per il quale il Papa avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione: «Si sparse la voce che noi potremmo essere ritenuti in Francia: ebbene! Ci si tolga pure la libertà: tutto abbiamo preveduto. Prima di partire da Roma abbiamo sottoscritta una regolare abdicazione, che deve aver valore, quand’anche fossimo gettati in una prigione; il cardinale Pignatelli n’è il depositario in Palermo, e quando si saranno manifestati i designi che si meditano, vi resterà nelle mani solo un miserabile monaco, il quale chiamerassi Barnaba Chiaramonti» (Artaud de Montor, Storia dei Sommi Romani Pontefici, vol. III, Pt. 2°, Torino: La Società editrice (1855), pp. 864-865). Alcuni storici, come il card. W. Brandmüller, dubitano dell’attendibilità della notizia riferita dal De Montor, perché Papa Chiaramonti in seguito fu realmente tratto prigioniero del Bonaparte sia a Savona sia a Fontaineblueau (Walter Brandmüller, Renuntiatio Papae. Alcune riflessioni storico-canonistiche, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale (18 luglio 2016), p. 4). 577 - Ibidem. Sembra abbastanza chiarito dagli storici che papa Pacelli avesse dato, poi, ai cardinali dispensa di riunirsi in conclave nella città neutrale di Lisbona: così ricorda Alberto Melloni, Il conclave, Bologna: Il Mulino (2001), pp. 102-103; Roberto Rusconi, Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette, Brescia: Morcelliana (2013), p. 109. 578 - Il testo è in Angela Ambrogetti, op. cit. 579 - Cfr. in generale, Antonio Ciudad Albertos, Renuncia de Benedicto XVI, cit., p. 151. 580 - Significativo ed emblematico mi sembra quanto riferito dal giornalista Luigi Accattoli: «“Lei mi deve curare e io devo guarire perché non c’è posto nella Chiesa per un papa emerito”: parlò così Giovanni Paolo II nell’aprile 1994 al chirurgo Gianfranco Fineschi che l’operò all’anca. Con una battuta quel Papa pragmatico aveva efficacemente riassunto l’intera dottrina dei canonisti sulle dimissioni del “vescovo di Roma”: a fare problema non sono queste – previste da sempre nelle leggi della Chiesa – ma la loro proiezione sul successore e suoi successori» (Luigi Accattoli, Quando Wojtyla diceva: non c’è posto per un papa emerito, in Corriere della Sera (14 febbraio 2013), p. 8). Riferisce un autore anonimo: «[…] il cardinale Franz Koenig dichiarò all’agenzia stampa tedesca DPA nel novembre 1996: “Il papa sa, e l’ha detto, che l’elezione di un nuovo pontefice mentre il vecchio è ancora in vita rappresenterebbe un problema. Un papa in pensione, un altro in Vaticano: la gente si domanderebbe chi dei due conta”». E aggiunge: «Il 16 maggio 2002 fu lo stesso Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, a non escludere, in caso di peggioramento della sua salute, un ritiro anzitempo di Giovanni Paolo II, in una dichiarazione al “Münchner Kirchenzeitung”, il settimanale dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga: “Se il papa vedesse di non poter assolutamente farcela più, allora sicuramente si dimetterebbe”» (Anonimo, Dimissioni del papa. La teoria e la pratica, in Blog di Sandro Magister www.chiesa(16 marzo 2012)). Secondo il postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del Papa polacco, mons. Oder, Giovanni Paolo II, seguendo l’esempio e sulla falsariga dell’atto di Paolo VI, avrebbe predisposto, a sua volta, un atto di rinuncia, datato 15 febbraio 1989, prevedendo la sua abdicazione in caso di infermità che si presumesse inguaribile e di lunga durata. Egli, peraltro, sempre secondo questa ricostruzione, avrebbe predisposto un testo, nel 1994, da leggere presumibilmente al Collegio cardinalizio riunito: Saverio Gaeta – Slawomir Oder, Perché è Santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione, Milano: BUR (2010), p. 130. 581 - Tommaso d’Aquino, Summa theologiae III, q. 82, a. 9., co. 582 - Ibidem 583 - Ibidem 584 - Id., Summa theologiae III, q. 82 a. 9 s. c. 585 - Id., Summa theologiae III, q. 82 a. 9 ad 3. 586 - Cfr. Antonio Menniti Ippolito, op. cit., pp. 22 ss. 587 - Segnalo alcune lettere di Caterina Benincasa (da Siena), Lettera CCCVI, A Urbano VI, in Id., Le lettere di S. Caterina da Siena, a cura di P. Misciattelli, Torino: Einaudi (2000), pp. 965 ss., partic. p. 966 s.; Lettera CCCX, A tre cardinali italiani, ivi, pp. 980 ss., partic. p. 984; Lettera CCCXVII, Alla Reina di Napoli, ivi, pp. 1022 ss., partic. pp. 1023 s.; CCCLXIV, A Urbano VI, ivi, pp. 1205 ss., partic. p. 1208. 588 - Mario Prignano, Urbano VI. Il papa che non doveva essere eletto, con Prefazione di Giovanni Maria Vian, Genova-Milano: Marietti 1820 (2011), pp. 173 ss. 589 - Ibidem, p. 174. |