 |
 |
| “Instrumentum laboris” 2024 Articolo della Fraternità San Pio X 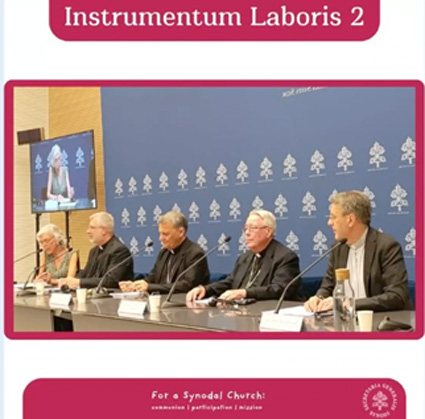 L’Instrumentum laboris (IL)
per la seconda sessione del XVI Sinodo dei vescovi sulla
sinodalità, che dovrà svolgersi nel prossimo ottobre
2024, è stato pubblicato il 9 luglio 2024. Composto da una
cinquantina di pagine, è intitolato: «Come essere una Chiesa sinodale in
missione?».
Gli organizzatori avevano annunciato che la seconda sessione sarebbe stata incentrata sul tema della sinodalità, eliminando quindi le questioni specifiche divergenti: come il diaconato femminile o l’omosessualità; hanno mantenuto la parola. In realtà il Papa aveva detto che per Fiducia supplicans non c’era bisogno di un Sinodo per prendere una decisione su quelle questioni. Peraltro, malgrado il fatto il fatto che Francesco ha ripetuto la sua opposizione, il diaconato femminile è sempre iscritto nel programma di uno dei dieci gruppi di studio, indipendenti dal Sinodo, che devono presentare la loro relazione al Papa nel giugno 2025. Ora, dopo i testi calamitosi della prima fase del Sinodo, il presente documento ha un tenore diverso. Non è più costellato di citazioni tratte dalle assemblee sinodali: ve ne sono meno di una dozzina e in gran parte corti. Il documento presenta una solida struttura. Infine, anche se tutto non è veramente chiaro, l’approccio intellettuale è più solido. E per questo c’è un motivo: questo IL è chiaramente ricalcato dal testo della Commissione Teologica Internazionale del 2018: «La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa». Una ripresa della Commissione Teologica Internazionale (CTI) D’altronde, il testo non nasconde le sue fonti: la CTI è citata solo cinque volte, ma la sua dottrina è largamente ripresa. La prima sessione aveva chiarito poco o nulla: la sinodalità era rimasta una nozione vaga. Adesso, lo studio fatto dalla CTI è la matrice di questo nuovo IL. Se il punto d’arrivo era noto, perché perdere tanto tempo a cercarlo in maniera indaguata? A meno che, con il disastro incombente, non si sia dovuto ricorrere ad un metodo sicuro per salvare il processo! Ma vi è un’altra spiegazione: il testo della CTI presenta la sinodalità secondo Francesco, ed è proprio questa visione del Papa che viene presentata qui. La sinodalità secondo l’IL 2024 Il testo dà il significato «comune» della sinodalità: «I termini sinodalità e sinodale, sono tratti dall’antica e perenne pratica ecclesiale dei sinodi» e il testo aggiunge che questi termini «sono stati meglio compresi e vissuti grazie all’esperienza di questi ultimi anni». IE prosegue: fondamentalmente, «la sinodalità è una espressione della natura stessa della Chiesa» (p. 4) che «si fonda in una visione dinamica del Popolo di Dio» (p. 14). Essa indica «lo stile particolare che determina la vita e la missione della Chiesa» (CTI n° 70), (p. 15). L’analisi della CTI è più precisa. La sinodalità «significa il modus vivendi et operandi specifico della Chiesa che manifesta e realizza concretamente il suo essere comunione nel fatto di camminare insieme, di riunirsi in assemblea, e che tutti i suoi membri prendono parte attiva nella sua missione evangelizzatrice» (CTI n° 6) (p. 16). Ma, precisa la CTI, «il concetto do sinodalità non è alternativo a quello di comunione». Infine, la CTI precisa l’articolazione della sinodalità: «La sinodalità deve esprimersi nel modo ordinario di vivere e di operare nella Chiesa. Questo modus vivendi et operandi si realizza attraverso l’ascolto comunitario della Parola e della celebrazione dell’Eucaristia, la fraternità della comunione e della responsabilità condivisa, e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio ai diversi livelli e nelle distinzioni dei diversi ministeri e ruoli, alla vita e alla missione della Chiesa» (ibidem) (p. 16). Questo punto è esplicitato più avanti: «La sinodalità si attua attraverso le reti delle persone, delle comunità, degli organismi ed un insieme di processi che permettono uno scambio efficace di doni fra le Chiese in un dialogo evangelizzatore con il mondo» (pp. 31-32). Una Chiesa sinodale… Nella concezione portata da Concilio e dal pensiero personale di Papa Francesco, il termine sinodale assume una nuova formalità. Si tratta di inglobare nel processo tutti i membri della Chiesa – e non solo – attraverso delle relazioni già esistenti e di altre da sviluppare o modificare: è quello che si esprime con l’espressione «marciare insieme», che compare quattro volte. Così, l’IL spiega che una Chiesa sinodale «è una Chiesa relazionale, nella quale le dinamiche interpersonali costituiscono la trama della vita di una comunità in missione, in contesti di crescente complessità» (pp. 34-35), il che rimane un po’ astruso. Ma la CTI chiarirà le cose. «Nella Chiesa sinodale, l’intera comunità, nella libertà e diversità dei suoi membri, è convocata per pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e consigliare, al fine di prendere delle decisioni pastorali più conformi alla volontà di Dio» (CTI n° 68) (p. 41). In altre parole, ciò che è stato fatto spontaneamente dalla fede animata dalla carità, dalla carità fraterna, dal fervore delle società religiose e dallo slancio missionario che da sempre ha caratterizzato la Chiesa, deve essere sottoposto ad una organizzazione – il termine è nel testo – in cui «un insieme di mezzi con cui i discepoli di Gesù tessono dei legami ordinari» (p. 23). Questa mobilitazione generale potrebbe avere qualcosa di grane e di bello, ma è un palliativo per la mancanza di spirito cristiano, per la perdita della fede, per l’abbandono dell’ascesi, per la perdita della morale e per la tiepidezza che è sempre esistita in un numero più o meno grande di persone. Non è questa «mobilitazione» che metterà a posto le cose, ma il ritorno alla vera vita cristiana. … riunita nello Spirito. Secondo Francesco, un secondo elemento importante per la sinodalità è l’azione dello Spirito Santo, che è concepito come la forza che fa avanzare o evolvere la Chiesa. Non c’è bisogno di ricordare l’importanza data alla «conversazione nello Spirito», metodo specifico del Sinodo, che qui è regolarmente richiamato. La CTI spiega che la sinodalità indica «lo stile particolare che determina la vita e la missione della Chiesa» (CTI n° 70), uno stile che parte dall’ascolto come primo atto della Chiesa: (…) ascolto della Parola di Dio, ascolto dello Spirito Santo, ascolto reciproco». Questi ascolti sono collegati: «La pratica della conversazione nello Spirito ha permesso di sperimentare la profonda interconnessione tra l’ascolto della Parola di Dio e l’ascolto dei fratelli e sorelle, Questa dinamica apre progressivamente alla percezione della voce dello Spirito». Ciò significa che il Popolo di Dio riceve una comunicazione divina che può illuminare la Chiesa. E più avanti: «Grazie alla guida dello Spirito, il Popolo di Dio, in quanto partecipe della funzione profetica di Cristo (…)» partecipa al discernimento del disegno di Dio di oggi. Questa «impegno ecclesiale di discernimento è radicato nel sensus fidei, animato dallo Spirito Santo, che può essere descritto come quel «fiuto» o quella capacità istintiva del Popolo di Dio, sotto la guida dei pastori». Questa descrizione della sinodalità è quella che si trova nel testo citato prima della CTI, testo che traspone in precise categorie teologiche la sinodalità di Francesco, in particolare quella che egli aveva descritto nel suo discorso del 17 ottobre 2015, pronunciato per il 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi da parte di Paolo VI.  Il cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale del Sinodo sulla sinodalità I Sinodi della storia della Chiesa Le assemblee sinodali – chiamate concilii o sinodi – non sono mancate nella storia della Chiesa: sia a livello locale o diocesano, sia a livello regionale o nazionale, sia al livello di tutta la Chiesa: i concilii ecumenici. Questi ultimi sono un mezzo per il Papa per esercitare il suo governo. In tutte queste riunioni erano presenti solo gli ecclesiastici. Da dopo il Vaticano II, per un verso, il concilio ecumenico è considerato in maniera erronea come soggetto del potere supremo. La novità erronea non distingue il “soggetto del potere”, che è unico ed è il Papa, e “l’esercizio del potere” che è duplice: solo il Papa o insieme con i vescovi. Per altro verso, col “concilio” pastorale olandese, cominciato durante il Concilio, i laici partecipano all’assemblea, in ragione della metà. Altri «sinodi» hanno seguito questo esempio, come il sinodo di Würzburg, in Baviera, Germania. Questo ingresso dei laici provocò una puntualizzazione di Roma e una precisazione nel Codice di Diritto Canonico del 1983, che dava come accettabile la presenza dei laici solo in ragione di meno della metà. Il Popolo di Dio viene munito dei poteri della gerarchia La recente concezione della sinodalità ha un’incidenza sulla struttura stessa della Chiesa. Sono rappresentativi di questo cambiamento tre elementi costantemente ricorrenti. Queste tre idee sono presenti nel testo della CTI, che, al seguito di Papa Francesco, descrive la Chiesa come una piramide rovesciata. Tali idee sono riprese nell’IL e sono tre elementi coordinati. Innanzi tutto, l’importanza data al sensus fidei. Poi, l’appiattimento della struttura gerarchica della Chiesa, che si manifesta nella negazione «del modo piramidale dell’esercizio dell’autorità», per passare ad un “modo sinodale», sottolineato dal concetto di «corresponsabilità». Infine, il Battesimo come fondamento del sacerdozio comune, che mette su un piano ugualitario tutti i membri della Chiesa. Queste tre idee sono presenti nel testo della CTI, che, al seguito di Papa Francesco, descrive la Chiesa come una piramide rovesciata. Tali idee sono riprese nell’IL e sono tre elementi coordinati. Dal momento che la Chiesa sinodale include «tutto il Popolo di Dio», queste tre idee danno un rilievo impressionante all’immagine della piramide rovesciata, visto che fanno partecipare i laici ai tre poteri della gerarchia, in un modo che sovverte la costituzione divina della Chiesa. Potere di insegnamento Al n° 58, l’IL spiega che «questo compito ecclesiale di discernimento è radicato nel sensus fidei, animato dallo Spirito Santo, che può essere descritto come un “fiuto” o quella capacità istintiva del Popolo di Dio, sotto la guida dei pastori (cfr. LG 12)». Il testo di Lumen Gentium 12 mostra che il Popolo di Dio non si sbaglia «anche se non trova le parole per esprimere la sua fede». In altre parole, l’infallibilità di questo sensus fidei nel Popolo di Dio non è dovuta all’insegnamento della gerarchia: quindi partecipa al suo potere. Nella dottrina tradizionale, il sensus fidei si presenta come derivante dalla dottrina predicata dalla Chiesa docente – i vescovi. Potere di giurisdizione Al n° 13, l’IL spiega che «il principio di corresponsabilità deve guidare la collaborazione tra tutti i battezzati». Questo principio è completato da diversi dispositivi, come quello della «responsabilità» o della trasparenza, «per favorire l’esercizio della corresponsabilità al servizio della missione comune» Potere di Ordine Il n° 37 ricorda che «nessun ministro può considerarsi come un individuo isolato (…), egli deve piuttosto considerarsi come uno che partecipa ai doni [poteri] di Cristo (…) con il Popolo di Dio che partecipa a questi stessi doni di Cristo nel sacerdozio comune fondato sul Battesimo». Il principio è dunque il sacerdozio comune, col ministero ordinato che appare come un complemento o un derivato. Conseguenze concrete proposte dal Sinodo Promozione dei ministeri laici Nel testo essi sono chiamati anche «ministeri battesimali»; si propone di accrescere i loro poteri: e si parla di ministri straordinari del battesimo, dell’assistenza ai matrimoni, e anche della «promozione di altre forme di ministerialità laica, anche al di fuori dell’ambito liturgico»: per esempio un «ministero dell’ascolto e dell’accompagnamento». Nuova valutazione del ministero ordinato «Una nuova valutazione del ministero ordinato nel contesto della Chiesa sinodale missionaria è una esigenza di coerenza» che «implicherà un nuovo modo di pensare e di organizzare l’azione pastorale che integri la partecipazione di tutti i battezzati». Negazione della preminenza del vescovo Il testo spiega che la nozione di episcopato «non giustifica il fatto che il ministero episcopale tenda ad essere “monarchico”». Questo punto è direttamente in opposizione con tutta la tradizione della Chiesa, e anche con lo stesso Vaticano II. Diminuzione della responsabilità della gerarchia Anche se il testo afferma che «in una Chiesa sinodale, la competenza decisionale del vescovo, del collegio dei vescovi e del Pontefice romano è inalienabile, perché radicata nella struttura gerarchica della Chiesa»; tuttavia «essa non è incondizionata: l’orientamento che emerge dal processo consultivo (…) non può essere ignorato». E per essere chiari, più avanti è detto: «l’opposizione tra consultazione e deliberazione si rivela inadeguata: nella Chiesa, la deliberazione deve implicare l’aiuto di tutti, senza tuttavia privare l’autorità pastorale della sua responsabilità decisionale; di conseguenza, la formula canonica che parla di “voto unicamente consultivo” dovrà essere modificata. Tanto vale dire che il Consiglio sinodale tedesco è già stato ratificato … Poiché non vi è alternativa tra «consultivo» e «non consultivo». Se bisogna modificare questa formula, tanto vale dire che la struttura consultiva – che comprende tutto il Popolo di Dio – ottiene uno statuto decisionale: che è esattamente quello che vogliono i Tedeschi. Autorità dottrinale delle Conferenze Episcopali «Sulla base di ciò che è emerso nel corso del processo sinodale, si propone di riconoscere le Conferenze Episcopali come entità ecclesiali dotate di autorità dottrinale, un modo per assumere le diversità socioculturali in seno ad una Chiesa multiforme che valorizza le espressioni liturgiche, disciplinari, teologiche e spirituali adattate ai diversi contesti». Anche se più avanti è precisato che si tratterebbe di questioni «che non toccano l’unità della dottrina, della disciplina e della comunione della Chiesa, che agisce sempre con questa corresponsabilità»; è necessario ricordare che la verità o è universale o non lo è. Quindi essa non può essere definita in modo diverso nei luoghi diversi. Questo significherebbe la balcanizzazione della Chiesa, la distruzione della sua unità. Slancio ecumenico Questa trasformazione sinodale è vista anche come un motore per l’ecumenismo: «la sinodalità costituisce un prerequisito per progredire lungo il cammino ecumenico verso l’unità visibile di tutti i cristiani». Tutte queste proposte mostrano un abbassamento della gerarchia cattolica e dei suoi poteri ed una corrispondente elevazione del laicato, entrambe distruggono profondamente la costituzione divina della Chiesa. La sinodalità è in procinto di rovesciare la gerarchia istituita per diritto divino. |