 |
 |
| La terza fase del Sinodo sulla sinodalità è avviata 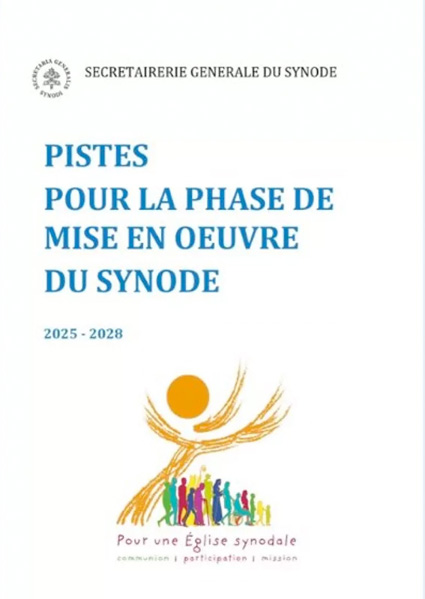 Il 7 luglio 2025, la Segreteria del Sinodo ha pubblicato i «Percorsi per la fase di attuazione del Sinodo 2025-2028», per avviare ufficialmente la terza fase del processo sinodale: l’attuazione dei risultati acquisiti, registrati nel Documento Finale votato nel corso della seconda Assemblea Sinodale nell’ottobre 2024. Le tappe della terza fase Da giugno 2025 a dicembre 2026, percorsi di attuazione nelle Chiese locali e nei loro raggruppamenti. 2027 Primo semestre: Assemblee di valutazione nelle diocesi e nelle Eparchie. Secondo semestre: Assemblee di valutazione nelle Conferenze Episcopali nazionali e internazionali, nelle strutture gerarchiche orientali e in altri raggruppamenti della Chiesa. 2028 Primo semestre: Assemblee di valutazioni continentali. Ottobre: celebrazione dell’Assemblea ecclesiale in Vaticano. Il contenuto del testo di avviamento Il testo dei Percorsi non è un testo di lavoro, ma un «quadro di riferimento condiviso» che descrive la fase di attuazione, i suoi obiettivi, i soggetti implicati e la metodologia da impiegare. Da notare che nelle 17 pagine del testo, il termine «sinodale» è presente 109 volte… mentre l’espressione «Chiesa sinodale» è presente 15 volte. L’attuazione consiste nello «sperimentare le pratiche e le strutture rinnovate che rendono la vita della Chiesa sempre più sinodale». Essa dovrà integrarsi nel contesto della comunità parrocchiale, per «avere un impatto percettibile sulla vita della Chiesa e sul funzionamento delle strutture e delle istituzioni». I soggetti implicati sono innanzi tutto i vescovi e il clero diocesano; i gruppi sinodali e gli organismi di partecipazione; i raggruppamenti della Chiesa come le Conferenze Episcopali e i Sinodi delle Chiese sui juris; infine, la Segreteria Generale del Sinodo. Ma qual è in definitiva lo scopo di questa fase? E’ indicato più volte che col «rinnovamento», termine che ricorre 10 volte, bisogna rinnovare «gli organismi partecipativi», «le strutture e i processi decisionali», «le pratiche e le strutture in una prospettiva sinodale», «le categorie di pensiero e di cultura», «i processi decisionali» o ancora «l’azione pastorale». Il metodo da impiegare è quello del discernimento ecclesiale, «metodo proprio della Chiesa sinodale», al fine di «crescere in un nuovo modo di essere Chiesa». Tutto questo si intreccia in una profusione di riunioni, di assemblee, di processi, ma tutti orientati «verso un orientamento missionario» per evitare il «rischio di un ripiegamento autoreferenziale». Un nuovo modo di essere Chiesa I Percorsi descrivono il metodo sinodale che «rappresenta una esperienza spirituale ed ecclesiale che implica il crescere in un nuovo modo di essere Chiesa». Quando il testo chiede di evitare il «ripiegamento autoreferenziale», gli ideatori e gli organizzatori di questa nuova Chiesa sinodale sono talmente accecati che non si rendono conto fino a che punto hanno concepito un meccanismo centrato su loro stessi. Per cercare di far comprendere questo punto è necessario ricorrere ad una distinzione di San Tommaso d’Acquino (II-II, 39, 2, ad 2m, articolo sullo schisma nel Trattato della Carità). San Tommaso distingue il bene comune di una società, che è il suo fine e che gli è intrinseco; e il fine ultimo di questa società, la sua causa finale, che gli è estrinseco. E fa l’esempio dell’esercito: «Come il bene della moltitudine è maggiore del bene di un membro di tale moltitudine, così è minore del bene estrinseco a cui questa moltitudine è ordinata: così il bene dell’ordine dell’esercito è minore del bene del capo (gli obiettivi del capo in quanto tale)», cioè la vittoria. Parimenti, l’organizzazione della Chiesa – in tutto ciò che è di ordine ecclesiastico e non divino – è inferiore alla gloria di Dio da procurare e al servizio della verità divina che procura la salvezza delle anime. Il meccanismo messo in moto dal Sinodo sulla sinodalità vuole mettere la Chiesa in ordine di marcia, di battaglia, essendo la legge suprema l’evangelizzazione. Questo significa errare sui due beni della Chiesa. Innanzi tutto sul bene interiore: la santificazione dei membri che, per ciò stesso, evangelizzano coloro che li circondano, senza doversi riunire continuamente per cambiare tutti i processi. Poi, il bene esteriore della Chiesa, quasi dimenticato dalla nuova Chiesa sinodale, anche se è ancora menzionato come «la missione di annunciare il Regno di Dio». Di contro «lo slancio ecumenico» è «una esigenza», al pari del dialogo interreligioso che include «l’impegno per la giustizia sociale e per l’ecologia integrale». Nella corsa in avanti che deriva dal disastro conciliare e dal rifiuto di riconoscerlo, la Chiesa sinodale usa come fosse uno slogan il termine «sinodale», che significa «camminare insieme», ma per esso non fissa alcun termine, alcun fine, poiché bisogna sempre avanzare, bisogna sempre trasformare. Il che è l’essenza stessa di un processo rivoluzionario. Il ruolo di Papa Leone XIV Nel corso del pre-conclave, il cardinale Joseph Zen denunciò con forza il Sinodo sulla sinodalità: «Gli elettori del prossimo Papa devono essere coscienti che egli avrà la responsabilità di proseguire questo processo sinodale o di fermarlo definitivamente. Ne va della vita o della morte della Chiesa fondata da Gesù». Non è stato ascoltato. Papa Leone XIV sta proseguendo il Sinodo, approvando questa terza fase e approvando i Percorsi. Andato di persona alla Segreteria del Sinodo, ha affermato, parlando dell’eredità di Papa Francesco: «la sinodalità è uno stile, un’attitudine che ci aiuta ad essere Chiesa, favorendo autentiche esperienze di partecipazione e di comunione». |