 |
 |
| Gli intellettuali della Rivoluzione francese di Padre João Batista de A. Prado Ferraz Costa Pubblicato sul sito sito della Cappella di Santa Maria delle
Vittorie
Anapolis - Brasile di cui il Padre João Batista è parroco 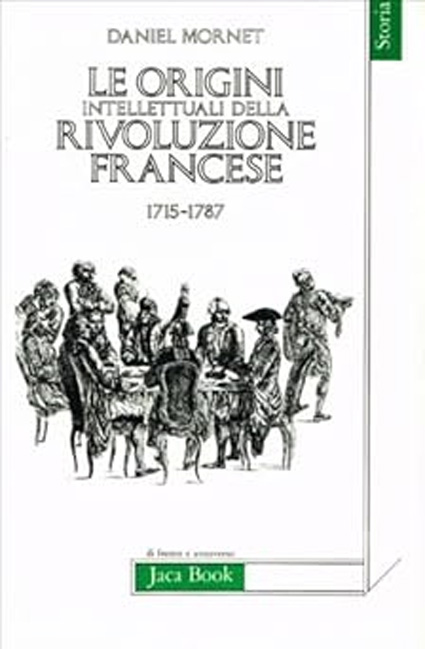 Copertina della versione italiana del libro citato Il libro Gli intellettuali della Rivoluzione francese di Daniel Mornet, ed. Caravelas, San Paolo 2024, è un prezioso contributo per la comprensione delle radici ideologiche e delle cause di questo cataclisma del XVIII secolo. Questo mi ha indotto a recensirlo per i fedeli della Cappella di Santa Maria delle Vittorie. Prima di presentare le idee dei principali filosofi dei “Lumi”, l’Autore analizza il lungo processo di secolarizzazione della società francese. Dice che già nel XVII secolo era comune incontrare in diversi ambiti della società francese uomini che non si consideravano più stranieri e pellegrini sulla terra in cerca del Paradiso. Fino ad allora, l’idea prevalente era che l’uomo non dovesse avere altro pensiero che guadagnare la vita eterna, da conseguire tanto meglio quanto più fosse umile, sottomesso e rassegnato (p. 23). E c’era un’autorità vigile e implacabile che puniva con le pene più severe tutti coloro che sembravano resistere all’autorità politica o religiosa. Sebbene non esistesse una inquisizione come in Spagna, gli scrittori empi o poco rispettosi venivano impiccati o imprigionati a vita; le lingue dei bestemmiatori venivano bruciate con un ferro rovente; per il solo sospetto di parlare male del Re e del suo governo si poteva perdere la vita o, come minimo, la libertà (p. 24). Nel XVII secolo, le cose iniziarono a cambiare nella società francese. Emersero donne filosofe dell’alta società, desiderose di studiare Cartesio e di ragionare come lui. Era evidente anche una significativa influenza dei filosofi inglesi. Vi fu anche una profusione di opere di narrativa, romanzi licenziosi e opere teatrali, che propagavano il gusto per oscenità eleganti o volgari. Di conseguenza, l’incredulità crebbe. L’Autore afferma che, se non certi dogmi, almeno certi articoli fondamentali della morale cattolica erano apertamente osteggiati, come l’indissolubilità del matrimonio, i voti monastici, certi privilegi e le consuetudini del clero. E sottolinea che, in linea di principio, nulla poteva essere detto contro i dogmi e la fede che non fosse punibile con la forca o la galera. Daniel Mornet sostiene che il razionalismo attaccava le tradizioni religiose promuovendo l’empietà, al punto che la filosofia scettica e deista penetrò perfino nella Chiesa. Molti sacerdoti erano lasciati preda della Enciclopedia, composta dall’empio Diderot. L’Autore racconta il caso di un vescovo nel cui palazzo erano ignorati i precetti della Chiesa sui digiuni e l’astinenza dalla carne. Tuttavia, a mio parere, se ricordiamo la figura di San Vincenzo de’ Paoli (1581-1660), che sviluppò una gigantesca opera di assistenza sociale e di promozione umana con l’appoggio del Re Luigi XIII, della Regina Anna d’Austria, del cardinale Richelieu, della duchessa d’Aiguillon e di molti altri nobili, bisogna dire che in Francia c’era ancora molta pietà, nonostante una buona parte della società francese si fosse raffreddata nella pratica religiosa. Secondo l’Autore, a partire dagli ultimi vent’anni del regno di Luigi XIV (1695-1715), non si verificò in Francia un malessere morale generale, bensì politico. Si avvertiva un fardello crudele: palesi abusi della giustizia (in seguito si sarebbe levato il clamore per la riforma delle leggi penali e dei tribunali), l’insolenza dei privilegiati, l’umiliazione delle guerre, le province devastate dagli eserciti e, soprattutto, il peso di imposte mal distribuite e brutalmente riscosse; freddo e fame tormentavano orde di poveri, persino alle porte di Versailles (p. 29). Fu questo il periodo dei riformatori, come Fénelon e Saint-Simon. L’Autore sottolinea che nessuno di loro era repubblicano, nessuno di loro pensò nemmeno di mettere in discussione il principio dell’autorità assoluta del Re, ma cercarono modi per consigliare il Re e difendere il paese dai pericoli del dispotismo (p. 30). Nel frattempo, cominciarono di diffondersi nuove idee. E si diffuse l’idea che la politica non fosse un campo in cui bisognava credere e obbedire; si poteva, e si doveva, discutere del governo degli Stati. (Tra l’altro, questo è un diritto della democrazia moderna, nata dalla Rivoluzione, che pretende falsamente di garantire attraverso l’assurdo sistema della partitocrazia e del suffragio universale individualista ed egualitario, che minano la costituzione organica della società). L’Autore colloca in questo periodo le prime manifestazioni di critica al cristianesimo dogmatico e “intollerante”. Passa poi alla difesa di una religione naturale che non richiede miracoli. Diverse opere compaiono a sostegno di una “religione naturale”, rivelata dalla coscienza a tutti gli uomini riflessivi e che non richiede miracoli, testi oscuri, teologi, università, prigioni o carnefici per essere dimostrata e imposta (p. 34). Sappiamo bene che tutto questo è un sofisma, perché se la religione non deve essere imposta a nessuno, deve essere protetta dagli attacchi di criminali empi, e quasi tutti i codici penali criminalizzano il reato di vilipendio del sentimento religioso. Comincia a emergere anche il desiderio di una nuova morale, una morale laica priva di qualsiasi ascetismo religioso. Lo scrittore Pierre Bayle tenta di dimostrare che è possibile per gli atei essere virtuosi. L’Autore riferisce che, di fatto, si stava intensificando lo sforzo per organizzare una morale efficace al di fuori di qualsiasi dogma, e persino di qualsiasi morale religiosa. Autori come Diderot, d’Holbach e altri ribadiranno costantemente che il piacere, la ricerca della felicità e l’obbedienza alle passioni sono un diritto e il fondamento stesso della morale (p. 119). Si inizia quindi a discutere di morale umanitaria, squalificando la carità in quanto svilente per la dignità umana ed esaltando la “beneficenza”. L’Autore afferma che il primo articolo di questa morale laica è la libertà di pensiero e la tolleranza. Inutile dire che una tale concezione di moralità egoistica ed edonistica, priva di qualsiasi fondamento teologico, mina l’adempimento dei doveri e non fa che alimentare uno spirito di rivendicazione, il discorso demagogico del nostro tempo sui diritti umani, ovvero i diritti dei criminali, che si pretende siano vittime delle ingiuste strutture della società. È anche chiaro che tutta la retorica dei filosofi illuministi in difesa della tolleranza non trovò riscontro nei loro fatti, poiché i rivoluzionari avrebbero scatenato una terribile persecuzione contro la Chiesa. Nello stesso periodo, si verificò un significativo movimento di intellettuali libertini, frequentatori dei celebri salotti parigini, i salotti dei bon vivants dell’alta nobiltà epicurea. Fu in questo ambiente che brillò la celebre mecenate Ninon de Lanclos, considerata la donna più bella del suo tempo, nota come “Nostra Signora dell’Amore” per la sua vita dissoluta, avendo avuto figli con diversi uomini. Eppure, il suo salotto era frequentato da personaggi considerati immacolati, come la scrittrice Madame de Sévigné. L’Autore afferma che la filosofia di questi intellettuali era quella di godersi la vita senza preoccuparsi della morte. Tra loro non c’erano solo deisti, ma anche un numero significativo di atei dichiarati. Divenne relativamente comune per intellettuali e membri dell’alta società morire rifiutando gli ultimi sacramenti della Chiesa. Daniel Mornet fornisce informazioni molto interessanti sui “maestri occulti” che contribuirono alla formazione di Voltaire e Montesquieu – maestri occulti noti solo a un piccolo numero di persone, ma che, attraverso la potenza, o almeno l’audacia, del loro pensiero, contribuirono a trasformare i “dubbiosi” in “negazionisti” e gli oppositori discreti in avversari insolenti (p. 38). Afferma che le loro opere furono stampate clandestinamente. Si trattava, in effetti, di una filosofia occulta. Alcuni di questi filosofi erano deisti, altri atei, e non si occupavano di politica. Si preoccupavano di costruire un arsenale di argomenti contro la religione, attaccando quelle che chiamavano le assurdità, le contraddizioni e la rozzezza della Bibbia, l’assurdità delle profezie e la non plausibilità dei miracoli. Le opere di questi autori furono ripubblicate da Voltaire e Diderot. L’Autore riferisce che i filosofi illuministi lavoravano nell’ombra, in segreto. Il più famoso di loro è Voltaire, letto con piacere anche dai membri del clero e da coloro che erano considerati pii, che lo consideravano un maestro dello spirito e del buono stile letterario (p. 40). Voltaire considerava tutte le religioni equivalenti, purché basate sulla morale naturale (sembra che i cattolici della Chiesa del Vaticano II, i cattolici della Pachamama, siano suoi allievi!). Voltaire criticava i teologi occupati in assurdità, i monaci pigri, i preti duri con gli altri e indulgenti con se stessi, tutti coloro che esigevano una fede cieca, condannando lo spirito a una schiavitù umiliante. Odiava i teologi che trasformavano la religione e la morale in un labirinto “un inestricabile dedalo di intrighi”. Voltaire voleva che ci occupassimo prima di tutto delle cose terrene, poiché era convinto che queste dipendano da noi e non dal cielo. Egli reagì con forza contro il “provvidenzialismo” (è esattamente il contrario di ciò che insegna il Signore: “Cercate prima il regno di Dio…” Mt 6, 33). L’Autore afferma che Voltaire non aveva le idee chiare su ciò che pensava. Gli riconosce, tuttavia, di aver avuto il merito di difendere l’innocenza oppressa durante i famosi casi del protestante Pierre Calas, ingiustamente accusato di aver ucciso il figlio che voleva convertirsi al cattolicesimo e che fu fatto a pezzi, e della famiglia Sirven, condannata in contumacia per aver annegato la figlia, convertitasi al cattolicesimo. Secondo Mornet, Voltaire aborriva il dispotismo, ma questo non significa che fosse un democratico, poiché detestava l’idea di essere governato dal popolo, dalla “plebe”. E quanto all’insegnamento di come instaurare una monarchia che fosse al tempo stesso assoluta e liberale, Voltaire riconosceva, almeno con il suo silenzio, che il problema era al di là delle sue possibilità (p. 97). Infine, l’Autore afferma che l’attacco più feroce lanciato da Voltaire non fu contro gli uomini, ma contro il Cristianesimo, contro “L’infâme”. E aggiunge un dato prezioso: gli avversari cattolici di Voltaire dimostrarono incontestabilmente che, almeno su alcuni punti, nell’ambito della storia e dell’esegesi, egli era male informato o non si preoccupava di informarsi (p. 108). Voltaire morì consacrato come una figura popolare, “Re Voltaire”, e immensamente ricco. Riguardo a Montesquieu, Mornet dimostra che l’autore de Lo Spirito delle Leggi era un ateo ipocrita. Nella sua opera Le Lettere Persiane, “Montesquieu si difende prudentemente dall’essere un miscredente: sono i Persiani a parlare, e i pagani non possono e non devono dire altro che sciocchezze sulla nostra religione. Ma nessuno si sbagliava. Era davvero Montesquieu a parlare attraverso di loro, prendendo in giro l’autorità del Papa, i miracoli, l’importanza esagerata data ai riti, insinuando che, in fondo, tutte le religioni si assomigliano” (p. 44). Riguardo alle sue idee politiche, Mornet afferma che Montesquieu nutriva un odio violento per il dispotismo, per tutti gli abusi di potere, per l’Inquisizione, l’intolleranza religiosa e la schiavitù. Ma era un monarchico parlamentare e un aristocratico; non aspirava a nient’altro che a una monarchia prudentemente temperata da “corpi intermedi” e “leggi fondamentali”. Montesquieu, secondo l’Autore, contava sulla forza più flessibile dei costumi e delle tradizioni, confidava nello spirito d’onore che permeava sia il monarca sia l’aristocrazia, e le cui leggi fondamentali non erano, in un certo senso, che un’espressione di questo (p. 82). Il fatto è che le critiche di Voltaire e Montesquieu cominciano a ottenere il sostegno del pubblico. Con la compiacenza e la complicità delle autorità e dei nobili, le opere rivoluzionarie venivano vendute tra le persone istruite. I libri proibiti venivano venduti, più o meno, molto più frequentemente di quelli autorizzati. L’Autore afferma che, intorno al 1770, leggi, ordini, editti, ispezioni e visite non erano altro che ridicoli spaventapasseri e formalità superficiali. Voltaire, sebbene sudasse di paura al minimo allarme, nel giro di pochi anni si sentì pienamente permeato di audacia e insolenza (p. 141). Le dispute teologiche tra gesuiti e giansenisti perdono ogni interesse per l’opinione pubblica e finiscono per essere considerate espressione di fanatismo religioso. Secondo Mornet, fino alla metà del XVIII secolo, i letterati prestarono scarsa attenzione alla politica, concentrandosi invece sulle questioni economiche. Afferma che i parlamentari – i parlamenti dell’Ancien Régime erano corti d’appello provinciali, con funzioni che andavano oltre la giustizia, come la registrazione e la convalida delle leggi reali – che avevano mantenuto un prudente silenzio sotto il regno di Luigi XIV, iniziarono ad affermare a gran voce che l’autorità e il controllo dei parlamenti erano un diritto storico e una salvaguardia della nazione. Afferma che esisteva ancora una rigida censura contro i cosiddetti filosofi “illuministi”, e che non tutti i lettori comprendevano appieno la portata delle loro idee. Tuttavia, sembra che la sorveglianza fosse alquanto lassista e intermittente, e che le tipografie clandestine e i venditori ambulanti fossero più abili della polizia, o addirittura che la polizia, a volte, ne fosse complice (p. 61). Con la diffusione di nuove idee nella società, si diffuse anche la corruzione dei costumi e l’irreligiosità. L’Autore racconta che nel 1721 il gesuita Croisset si lamentò del fatto che la Quaresima non fosse più osservata e, nel 1730, la semplice menzione di un miracolo provocò ilarità tra i mondani. Nel frattempo, nelle province persistevano usanze austere. Mornet racconta che la devozione della venerabile Margherita Maria Alacoque al Sacro Cuore di Gesù fu oggetto di innumerevoli battute, non solo da parte di Voltaire, ma anche di persone che non erano miscredenti. Gli avversari del cristianesimo iniziarono a sostenere che ogni religione fosse nata da una complicità tra tiranni e sacerdoti per sfruttare la credulità degli uomini; i sacerdoti ci fanno credere che la tirannia sia divina, e i tiranni sterminano i nemici dei sacerdoti (p. 117). Questa è, come è chiaro a qualsiasi cattolico con una conoscenza di base della Sacra Scrittura, una menzogna. Ciò che la Chiesa insegna è che ogni potere emana da Dio per garantire il buon ordine sociale e la giustizia. Questo è ciò che insegna San Pietro nella sua prima lettera: “Siate sottomessi, dunque, ad ogni istituzione umana per amore di Dio: sia al re come al sovrano, sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e lodare i buoni» (1 Pt 2,11-19). Insomma, secondo Mornet, lo stato d’animo medio in Francia intorno al 1747 può essere riassunto come segue “in materia religiosa la maggior parte degli studiosi erano deisti o atei, ed esprimevano le loro opinioni solo in scritti molto clandestini o con estrema prudenza, in generale la borghesia era molto pia”. Riguardo alla grande impresa editoriale del secolo dei “lumi” in Francia, la famosa Enciclopedia, Mornet afferma che era necessario assicurarsi la benevolenza delle autorità, poiché le sue voci sarebbero state riviste da censori che erano teologi ortodossi. Erano questi teologi ortodossi a scrivere tutto ciò che poteva toccare direttamente la fede. Afferma che Diderot moltiplicò le espressioni di rispetto e persino di umile sottomissione; tuttavia, fece in modo che il lettore percepisse l’ironia dietro quel rispetto e dichiarasse guerra, proclamando di desiderare la pace (p. 87). Ma ciò che emerge veramente dalla lettura dell'Enciclopedia è che la Bibbia, i libri canonici, la Quaresima e i dogmi sarebbero state opere umane, non divine. Quanto alla politica, l’ideale che l’Enciclopedia difende è il despota illuminato: “Felice lo Stato quando il suo re è un filosofo o quando un filosofo è il suo re!” (p. 90). Riguardo all’antropologia, il direttore dell’Enciclopedia, Denis Diderot, difende l’assurdità della “buona natura” dell’uomo: «Solo uno spirito maligno di religione ci fa credere in una “natura brutta e corrotta”; la natura è buona, o almeno non cattiva. Basta seguire il proprio istinto; è stato un errore considerare la parola amor proprio “in senso negativo”; “non è passato molto tempo da quando un piccolo numero di uomini” ha cominciato a reagire e a dimostrarci che abbiamo il diritto di cercare la nostra felicità» (p. 101). E riguardo all’etica, Mornet afferma che Diderot è stato uno dei più eloquenti e ascoltati maestri di morale laica e umanitaria, nonostante questa morale fosse in contraddizione con il suo sistema, poiché, per lui, non esisteva libertà, né vizio, né virtù, ma cause fatali seguite da effetti inevitabili (ibid.). A proposito di Rousseau, Mornet osserva che era in contraddizione con i principii degli altri filosofi illuministi. Spiega Mornet: “Per Voltaire, d’Alembert, d’Holbach, Diderot e tutti gli enciclopedisti, lo scopo della vita era su questa terra; era rendere gli uomini più felici; e questo progresso nella felicità poteva essere raggiunto solo attraverso il progresso dell’intelligenza (...). Per Rousseau, è del tutto possibile che il progresso materiale sia stato raggiunto attraverso il progresso intellettuale; ma questa è una condanna, non un elogio, dell’intelligenza. Perché tutto il progresso della civiltà, fin dai suoi inizi, dalle origini stesse di questa civiltà, è stato un inizio e un aumento della miseria. L’uomo era felice solo nello stato di natura, cioè quando, vivendo in gruppi molto piccoli, uniti dall’istinto della famiglia, indipendenti e nomadi, pensava solo a vivere semplicemente, senza avidità, senza odio, senza irrequietezza, contento di bere, mangiare, dormire e amare i propri cari”. Si tratta, in effetti, di un sogno ad occhi aperti, privo di qualsiasi fondamento nella storia del mondo, poiché il buon senso ci dice che l’uomo è sempre stato soggetto alla legge del lavoro e dello sforzo, come leggiamo nel racconto biblico: Dio maledice la terra e condanna Adamo a guadagnarsi il pane lavorando la terra, dopo la sua disobbedienza (Gen. 3:19). Mornet afferma che Rousseau stesso affermava che la sua teoria non era altro che teoria. Infatti, in pratica, non si può distruggere la civiltà e tornare alla barbarie. È possibile solo orientare la civiltà in una certa direzione; e questa direzione, questo ideale, è chiaramente esposto nell’Emilio e, soprattutto, nella Nuova Eloisa (p. 103). Mornet dice che l’opera di Rousseau causò un tremore decisivo alla vigilia della Rivoluzione. Grazie a tale opera la gente si convinse che gli uomini non fossero malvagi per natura, ma solo corrotti e miserabili. L’Autore ricorda che nonostante la sua mania di persecuzione, Rousseau fu coperto di gloria, al punto che la Regina e i suoi principi andarono a visitare la sua tomba. Mornet ci informa che, dal 1770 in poi, ci fu libertà di scrivere di politica, purché lo si facesse in certi modi. Prima, alla maniera cartesiana, con una concezione razionalista del diritto naturale; poi, sotto l’influenza di Montesquieu, iniziò una diffidenza verso il ragionamento astratto, ovvero si diede più importanza ai fatti che ai lumi della ragione, alla realtà storica che alla logica. Fu in questo periodo che emersero una nobiltà e un clero liberali in materia di religione e politica: i preti “patriottici” e “cittadini”. Mornet afferma che, a partire dal 1748, iniziò una battaglia tra i “nuovi filosofi” e i difensori della fede cristiana. Ci furono polemiche sulla stampa, dove Locke fu denunciato come il padre del materialismo moderno. Allo stesso tempo, si notò un nuovo spirito educativo, che creò un terreno favorevole allo sviluppo di idee rivoluzionarie. I nuovi teorici dell’educazione, come Locke e Rousseau – afferma l’autore – anche quando erano in disaccordo su obiettivi e mezzi lontani, esigevano un insegnamento e un’educazione realistici. Fino ad allora, le scuole non avevano altra ambizione che quella di trasmettere ai loro studenti qualità generali di gusto; insegnavano loro a scegliere, organizzare ed esprimere con chiarezza, eleganza ed eloquenza idee generali applicabili a tutti i tempi e a tutti i paesi (p. 179). Così, in questa nuova prospettiva, l’insegnamento del latino iniziò a essere messo in discussione, se non addirittura disprezzato. I sacerdoti della Congregazione dell’Oratorio si allinearono a nuove idee pedagogiche; vollero sostituire lo “studio delle parole” con lo studio della realtà, di tutto ciò che prepara alla vita. C’era una lotta contro la filosofia scolastica, un’apologia delle virtù secolari del cittadino e del patriota. Ciò che iniziò, in verità – bisogna dirlo – è un’educazione senza Dio, un’educazione che non prepara più il discepolo a raggiungere il suo fine ultimo, la salvezza dell’anima. Mornet afferma anche che si verificò un declino nelle Università. Riferisce che, nonostante i timidissimi tentativi di introdurre l’insegnamento delle lettere e delle scienze nelle Università, in realtà vi si studiava poco, a parte teologia, diritto e medicina. E quasi ovunque, questi insegnamenti erano in completo declino; le università erano disprezzate. L’Università di Parigi non ebbe più valore delle altre, e per tutte le persone istruite, quando non avevano più bisogno di un diploma, è come se essa non esistesse (pp. 290-291). Nacquero poi le società letterarie, dove venivano propagate nuove idee. L’Autore afferma che vi fu una resistenza da parte della tradizione religiosa e politica, il che spiega perché, dopo la Rivoluzione, ci furono il Concordato, la Restaurazione, il Secondo Impero e una ricca borghesia che continuò a riempire le chiese, rimanendo fedele alla fede dei propri antenati. Che lo spirito filosofico conquistò solo una parte dell’opinione pubblica è evidente (p. 211). In effetti, l’Autore afferma che la filosofia illuminista incontrò ostacoli ben oltre la censura ufficiale, la Bastiglia o Vincennes. Non seguì il suo corso come un fiume calmo (...) In realtà, avanzò attraverso un territorio ostile che impose una resistenza ben più formidabile da parte di tradizioni potenti e persistenti. L’Autore afferma che ci furono uomini pii e di talento che si dedicarono alla difesa della Chiesa e della tradizione. E anche tra la nobiltà e l’alto clero, c'erano grandi difensori della fede: “L’alta nobiltà, profondamente influenzata dal gusto del lusso e del piacere, dal bisogno di denaro, spesso ostentava o praticava lo scetticismo. Ma anche tra loro, quanti furono fedeli alla fede dei loro padri!” (p. 217). Mornet afferma che l’alto clero combatté senza pietà e senza sosta contro qualsiasi minaccia alla fede. Allo stesso modo, la stragrande maggioranza della popolazione continuò a praticare la propria religione. Riguardo alla resistenza della tradizione politica, l’Autore afferma che, fino al 1788, non c’erano più di una dozzina di scrittori veramente repubblicani e rivoluzionari, e anche allora si trattava di figure piuttosto oscure. D’altra parte, ce n’erano molti che invocavano o suggerivano riforme profonde. Ma ce n’erano molti di più che non volevano cambiare nulla di essenziale, che elogiavano il passato e il presente, e quando proponevano riforme, erano solo quelle che, se possibile, non avrebbero turbato nessuno. (...) Per ognuno che mostrava un po’ di indipendenza, ce n’erano tre che protestavano sinceramente il loro rispetto e il loro desiderio di essere, soprattutto, buoni servitori del monarca (pp. 222-223). Mornet afferma anche che fu certamente una parte della borghesia che desidererà gli Stati Generali, che esigerà una riforma dello Stato, ma non una rivoluzione, perché è profondamente ostile a tutto ciò che altera la vita e i costumi dei loro antenati (p. 226). Queste parole dell’Autore confermano ancora una volta che lo spirito rivoluzionario è caratteristico di una minoranza di degenerati che hanno seri problemi personali di natura morale ed emotiva e che perciò vogliono distruggere l’opera di coloro che, con tanta pietà, impegno e altruismo, hanno cercato attraverso le generazioni di realizzare il piano di Dio sulla creazione dell’uomo: costruire una società basata sulla legge naturale e sulla tradizione attorno alla sacra istituzione della famiglia e sotto la benedizione della Chiesa. Un capitolo dell’opera di Mornet che merita attenzione è quello sull’influenza della Massoneria sulla Rivoluzione. L’Autore afferma che la Massoneria era poco controllata e le punizioni erano clementi, il che indica che questa società segreta annoverava personaggi potenti al suo interno. L’Autore afferma che è abbastanza certo che né la nobiltà vedesse la Massoneria come un’impresa democratica, né il clero come una minaccia di irreligione. La nobiltà era entusiasta della Massoneria. Il Duca di Chartres (Philippe Egalité) era Gran Maestro della Massoneria, ed è molto probabile che Luigi XVI fosse un massone, afferma Mornet. Esisteva quindi una Massoneria aristocratica che si riparava all’ombra del trono, una Massoneria quasi ufficiale. Mornet afferma inoltre che il procuratore del Re a Châtellerault scrisse al procuratore generale di essere lui stesso a capo della loggia della città, il che, secondo lui, dimostrava chiaramente che lì non si discuteva nulla contro lo Stato, la religione o i buoni costumi. Ma c’era anche chi temeva che la Massoneria potesse un giorno essere dannosa per la religione. La Sorbona condannò la Massoneria nel 1763, una condanna oscura in un’epoca in cui a nessuno importava più delle decisioni della Sorbona (p. 367). La confusione di idee riguardo alla Massoneria era così grande che l’arcivescovo di Tours derise il vescovo che credeva che “Massoneria ed empietà fossero la stessa cosa”. Tanto che, secondo l’Autore, a Bordeaux esistevano una loggia massonica chiamata “Loggia dello Spirito Santo” e una loggia dei “discepoli di San Vincenzo de’ Paoli”. Mornet si chiede quindi: “Cosa si faceva in questi luoghi, dal momento che al loro interno non si cospirava, né si meditava su piani politici o addirittura filosofici? Abbiamo persino informazioni dettagliate attraverso numerosi studi di archivi provinciali (...). Inizialmente, erano frequentate per svago. Le opportunità di svago erano rare o inesistenti nelle piccole città e persino nelle grandi città del XVIII secolo” (p. 374). Degno di nota è quanto afferma l’Autore sull’interesse suscitato dalla Massoneria attraverso i suoi rituali misteriosi e melodrammatici. Secondo Mornet, si credeva che i Massoni avessero avuto origine a Sodoma. Ciò che trovo discutibile è l’affermazione dell’Autore secondo cui non vi sono prove che la Massoneria avesse legami con la setta rivoluzionaria degli Illuminati di Baviera, attraverso Cagliostro, Mirabeau e il tedesco Bode, o che sviluppasse attività sovversive. Per lui, la Massoneria era rispettosa della religione e, ancor di più, dei principi monarchici e delle autorità costituite. “Sappiamo dallo stesso Joseph de Maistre”, afferma Mornet, “che lui e i suoi amici sognavano di creare uno stato maggiore segreto all’interno della Massoneria, che avrebbe trasformato i Massoni in una sorta di esercito pontificio al servizio di una teocrazia universale”. Mornet afferma inoltre che l'intera controversia anti-massonica cattolica del XIX secolo è dovuta alla famosa opera di Padre Barruel, Memorie per servire la storia del giacobinismo, che, secondo l’Autore, è un’opera piena di affermazioni gratuite prive di qualsiasi prova. In realtà, esiste una letteratura di grande valore sulla Massoneria che dimostra e documenta l’azione sovversiva di questa setta contro l’ordine sociale cristiano. Basti citare le opere erudite di Monsignor Henri Delassus, La cospirazione anticristiana, e Le forze segrete della rivoluzione del conte Léon de Poncins, così come Per il regno di Jean Ousset; tutte queste opere forniscono abbondanti prove. Monsignor Delassus fornisce anche preziose informazioni sull’esoterismo satanico della Massoneria. Molto interessante è Il capitolo sulla Rivoluzione americana e la sua influenza sulla Rivoluzione francese. L’Autore afferma che, allo scoppio della Rivoluzione nel 1789, coloro che agirono con maggiore forza erano profondamente permeati dagli insegnamenti dell’esperienza americana. Sottolinea inoltre il ruolo di Benjamin Franklin, affermando che “per l’opinione pubblica francese non esisteva un filosofo che corrispondesse esattamente alle sue aspettative; attendeva un uomo capace di raggiungere la saggezza e la felicità laiche attraverso le virtù associate alla ragione e alla sensibilità. Quest’uomo era Benjamin Franklin: era ‘sensato’, aveva un ideale, una religione; non una religione fanatica e dogmatica, ma una religione del cuore, la fede in Dio e la dignità della vita morale” (pp. 396-397). Mornet racconta che Benjamin Franklin portò il nipote a farsi benedire da Voltaire sul letto di morte, e quando Voltaire pronunciò le parole “Dio, libertà” sulla testa del bambino, sembrò che il meglio del pensiero e dell’anima francese si unisse all’anima americana (p. 397). A questo punto, non possiamo non notare la saggezza di Leone XIII nel condannare l’errore dell’americanismo. Gli Stati Uniti, pur non avendo raggiunto gli eccessi dello spirito rivoluzionario del 1789, sancirono nella loro Costituzione l’errore del liberalismo e del laicismo. Mornet afferma che la Dichiarazione d’Indipendenza americana fu censurata in Francia: “L’autorità assoluta del Re di Francia non avrebbe dovuto subire l’applauso della rivolta dei suoi sudditi contro il loro legittimo sovrano, anche se fosse stata razionale, soprattutto se fosse stata razionale. E il governo non si faceva illusioni sulla portata della dichiarazione. Non ne permise la pubblicazione” (p. 399). Tuttavia, persino il censore reale, Padre Genty, elogiò la dichiarazione: «L’indipendenza degli anglo-americani è l’evento più propizio per accelerare la rivoluzione che deve portare felicità alla terra. È nel seno di questa Repubblica nascente che sono depositati i veri tesori che arricchiranno il mondo» (p. 400). Nel capitolo sulla diffusione delle idee filosofiche tra il popolo, Mornet afferma che è vero che, per la maggior parte, il popolo accettò, seguì e in seguito accelerò la Rivoluzione, ma non ne concepì né la dottrina né l’idea stessa; e coloro che ne avevano l’idea vi giunsero per ragioni politiche, per sfuggire alla povertà, e non perché avessero riflettuto sulla dottrina dei filosofi (p. 421). C’è tutta una controversia intorno all’educazione popolare e alla rivoluzione: se la rivoluzione sia stata la prima a educare ed elevare il popolo, mentre la monarchia lo ha lasciato immerso nell’ignoranza e nell’oscurantismo. Il fatto è che i filosofi non erano sostenitori dell’educazione delle classi inferiori. Voltaire, ad esempio, era convinto che la maggioranza della gente dovesse imparare solo a “coltivare, perché una sola penna basta per duecento o trecento mani”. Mi sembra essenziale che ci siano mendicanti e ignoranti. Quanto diversi dai grandi santi educatori, i missionari gesuiti che si dedicarono all’evangelizzazione e all’insegnamento agli indigeni a leggere e scrivere! Quanto diversi da san Giuseppe Calasanzio, san Pietro Fourrier, san Giovanni Battista de La Salle, sant’Angela Merici e tanti altri che si dedicarono all’educazione dei bambini poveri! Infine, per quanto riguarda le cause della Rivoluzione, l’Autore fa riferimento al degrado morale della nobiltà e ai vari ammutinamenti che la precedettero. Sostiene che furono cause sociali e politiche a garantire alle idee rivoluzionarie il sostegno del popolo, che non aveva ancora cessato di sperimentare la rivolta e aspettava solo un segno di debolezza del potere per lanciarsi violentemente in essa (p. 451). Ma pochi prevedevano i pericoli che minacciavano l’ordine sociale. Riguardo allo spirito rivoluzionario, Mornet fa un’importante osservazione che vale la pena riprodurre: “Così, prima della Rivoluzione, si è formato lo spirito rivoluzionario più temibile perché è il più falso: la convinzione che si possa distruggere e ricostruire una società come si distrugge e ricostruisce un sistema di idee in una tesi della Sorbona o in una discussione da salotto: ‘Mai i fatti; “Solo astrazioni, serie di frasi sulla natura, la ragione, il popolo, i tiranni, la libertà, una specie di palloncini gonfiati che rimbalzano inutilmente nello spazio” (pp. 467-468). Inutile dire che una tale ideologia, unita all’odio per Dio e la religione, spiega la sanguinosa violenza della Rivoluzione. Se i fatti contraddicono gli obiettivi della Rivoluzione, tanto peggio per i fatti: che vengano eliminati. I contadini rispettano, anzi venerano, i loro signori; che vengano tutti eliminati perché la Rivoluzione non può arrestare la sua marcia. * * *
Dopo aver terminato la lettura dell’opera, diventa chiaro
che le cause ultime della Rivoluzione furono la perdita della fede e
delle altre virtù cristiane, senza le quali non è
possibile un ordine sociale giusto e pacifico. Infatti, quando gli uomini perdono la speranza nella vita eterna e si lasciano dominare dall’egoismo, dall’orgoglio, dalla sensualità, dall’avidità di beni terreni, dall’intemperanza, dall’avarizia e dall’invidia, non può esserci pace nella società. Ogni gerarchia sociale diventa odiosa; l’umiltà e l’obbedienza sono indegne di un uomo libero. E le ingiustizie più palesi iniziano a mettere le classi sociali l’una contro l’altra, alimentando l’odio e il desiderio di vendetta. Iniziano a creare un terreno fertile per lo spirito rivoluzionario. Il bellissimo libro di memorie Vandea 1793 - Una famiglia di banditi, di Marie de Sainte Hermine, Ed. Permanência, 2021, che ritrae il rapporto armonioso tra una famiglia nobile e i contadini che vivevano sulle loro terre, una vita sociale realmente basata sulle virtù cristiane, dimostra la mia tesi. Dimostra che i rivoluzionari, in realtà, non si ribellarono alle ingiustizie e agli abusi, ma piuttosto odiarono i valori e i costumi cristiani dell’antica Francia. Invito ogni lettore di questa recensione a leggere "Gli intellettuali della Rivoluzione" per informarsi pienamente sul significato del cataclisma del 1789, per convincersi della natura satanica di questa rivoluzione e per aiutare i cattolici, oggi contaminati dallo spirito rivoluzionario e illusi dalla democrazia moderna nata dai falsi ideali del 1789, a lottare per il Regno Sociale di Gesù Cristo, l’unico regime politico che consente all’uomo di vivere felicemente e fiduciosamente in questa valle di lacrime verso la Casa del Padre. Anápolis, 13 maggio
de 2025
Festa di San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore Memoria della prima apparizione di Nostra Signora del Rosario a Fatima |