 |
 |
| Dilexi te: la prima esortazione di Leone XIV 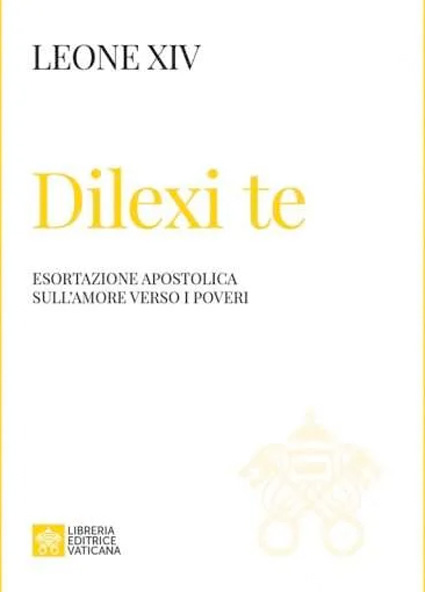 La prima esortazione apostolica di Leone XIV, Dilexi te (“Ti ho amato”), firmata il 4 ottobre 2025 e resa pubblica il 9 ottobre, merita la nostra attenzione più di alcune interviste del Papa, alle quali talvolta viene data un’eccessiva rilevanza mediatica. Ci troviamo di fronte non a poche parole, ma ad un ampio documento che conta 121 paragrafi e si sviluppa in cinque capitoli più un’introduzione. Come è stato notato, non è un’enciclica sociale, ma un’esortazione apostolica. L’enciclica è un documento dottrinale, l’esortazione apostolica è un documento pastorale, che non definisce dei principi, ma ci esorta a un comportamento. Papa Leone chiarisce che Dilexi te nasce da un progetto già avviato da Papa Francesco, che egli ha fatto suo, aggiungendo riflessioni personali. Tuttavia, se il tema della povertà è “bergogliano”, l’approccio non è il medesimo. Papa Francesco, sembrava spingere verso un impegno politico e sociale attivo, mentre Leone XIV, si richiama ad un impegno morale e caritativo. Francesco attribuiva un ruolo predominante ai movimenti, come artefici di giustizia sociale, Leone accenna ai movimenti in maniera generica e subordinata e tra i due poli della giustizia e della carità, attorno a cui si è svolto il dibattito sulla questione sociale dell’ultimo secolo, sembra attribuire un ruolo primario alla carità. Il riferimento a sant’Agostino nel n. 47, quando dice che «in una Chiesa che riconosce nei poveri il volto di Cristo e nei beni lo strumento della carità, il pensiero agostiniano rimane una luce sicura», rivela l’intenzione del Papa di ricondurre la carità al suo fondamento teologico e spirituale. L’espressione «opzione preferenziale da parte di Dio per i poveri», precisa il Papa «non indica mai un esclusivismo o una discriminazione verso altri gruppi, che in Dio sarebbero impossibili» (n. 16). La povertà non è per lui una categoria sociale e tanto meno rivoluzionaria, ma piuttosto la condizione umana di chi, nella società, è debole, fragile, talvolta emarginato o perseguitato. «Sul volto ferito dei poveri troviamo impressa la sofferenza degli innocenti e, perciò, la stessa sofferenza del Cristo. Allo stesso tempo, dovremmo parlare forse più correttamente dei numerosi volti dei poveri e della povertà, poiché si tratta di un fenomeno variegato; infatti, esistono molte forme di povertà: quella di chi non ha mezzi di sostentamento materiale, la povertà di chi è emarginato socialmente e non ha strumenti per dare voce alla propria dignità e alle proprie capacità, la povertà morale e spirituale, la povertà culturale, quella di chi si trova in una condizione di debolezza o fragilità personale o sociale, la povertà di chi non ha diritti, non ha spazio, non ha libertà» (n. 9). I numerosi esempi che cita il Papa rivelano l’ampiezza della categoria dei poveri a cui si riferisce, che include, non solo malati, sofferenti, perseguitati, ma anche coloro che sono bisognosi di parole di istruzione e di verità. «Tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, quando molti cristiani erano catturati nel Mediterraneo o ridotti in schiavitù nelle guerre, sorsero due Ordini religiosi: l’Ordine della Santissima Trinità per la Redenzione degli Schiavi (Trinitari), fondato da San Giovanni de Matha e San Felice di Valois, e l’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede (Mercedari), fondato da San Pietro Nolasco con l’appoggio di San Raimondo di Peñafort, domenicano. Queste comunità di consacrati sono nate con il carisma specifico di liberare i cristiani fatti schiavi, mettendo a loro disposizione i propri beni e, spesso, offrendo in cambio la propria vita» (n. 60). «Nel XVI secolo san Giovanni di Dio fondando l’Ordine Ospedaliero che porta il suo nome, creò ospedali-modello che accoglievano tutti, indipendentemente dalla condizione sociale o economica. La sua celebre espressione “Fate del bene, fratelli miei!” divenne un motto per la carità attiva verso i malati. Contemporaneamente, san Camillo de Lellis fondò l’Ordine dei Ministri degli Infermi – i Camilliani – facendo sua la missione di servire i malati con totale dedizione» (n. 50). Il Papa ricorda ancora le Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli, le Suore Ospedaliere, le Piccole Suore della Divina Provvidenza e molte altre congregazioni femminili, che «sono diventate una presenza materna e discreta negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo» (n. 51). Nel XIX secolo, san Marcellino Champagnat fondò l’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole, «sensibile ai bisogni spirituali ed educativi del suo tempo, soprattutto all’ignoranza religiosa e alle situazioni di abbandono vissute in particolare dai giovani».«Con lo stesso spirito, in Italia san Giovanni Bosco iniziò la grande opera Salesiana, basata sui tre principi del ‘metodo preventivo’ – ragione, religione e amorevolezza» (n. 70). «Nel XIX secolo, quando milioni di Europei emigravano in cerca di migliori condizioni di vita, due grandi santi si distinsero nella cura pastorale dei migranti: San Giovanni Battista Scalabrini e santa Francesca Cabrini» (n. 74). Papa Leone raccomanda infine le «opere di misericordia» (n. 27) e soprattutto un precetto cristiano dimenticato, l’elemosina, perché, afferma, «l’amore e le convinzioni più profonde vanno alimentate, e lo si fa con gesti»; «In ogni caso, l’elemosina, anche se piccola, infonde pietas in una vita sociale in cui tutti si preoccupano del proprio interesse personale. Dice il Libro dei Proverbi: “Chi è generoso sarà benedetto, perché egli dona del suo pane al povero” (Pr 22,9)» (n. 116). L’esortazione Dilexi te di Leone XIV ribadisce dunque l’insegnamento della Chiesa sulla carità verso il nostro prossimo. «La cura dei poveri – dice il Papa – fa parte della grande Tradizione della Chiesa, come un faro di luce che, dal Vangelo in poi, ha illuminato i cuori e i passi dei cristiani di ogni tempo» (n. 103). “Quella carità cristiana – potremmo concludere con le parole del suo grande predecessore Leone XIII – che compendia in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a sacrificarsi per il prossimo, è il più sicuro antidoto contro l’orgoglio e l’egoismo del secolo» (Rerum Novarum, n. 45). |