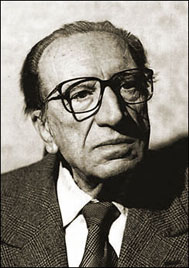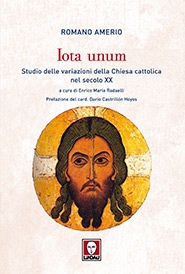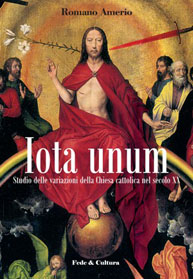|
|
||
|
|
||
| LO STRANO CASO
Dopo un’assenza di 20 anni,
ecco riapparire in libreria il ben noto testo del Prof. Romano Amerio: Iota unum – Studio delle variazioni della
Chiesa cattolica nel XX secolo. Un testo noto universalmente ai
cattolici, non solo per le innumerevoli citazioni che si riscontrano in
migliaia di scritti che trattano della crisi della Chiesa, ma anche per
la sua traduzione nelle sei più importanti lingue europee.
Stampato nel 1985, vide tre edizioni italiane fino al 1989, per 7500 copie, il tutto grazie ad un modestissimo circuito divulgativo ben lontano dalla multiforme galassia della pubblicistica cattolica ufficiale. Per il mondo dell’informazione cattolica ufficiale il testo era semplicemente inesistente. Oggi si direbbe che era “politicamente scorretto”, cioè diceva molte cose giuste, nella maniera giusta, nel momento giusto, ma non soggiacenti alla vulgata cattolica dominante. Ciò nonostante, Iota unum ha rappresentato e ancora rappresenta una sorta di piccola summa delle variazioni che la Chiesa ha subito nel secolo scorso: in ordine alla morale, alla liturgia e alla dottrina cattoliche. Variazioni che per molti versi hanno condotto ad una religione diversa dalla quella vigente nei duemila anni precedenti, operando, di fatto, una cesura tra la Chiesa di sempre e la Chiesa moderna. Amerio era un fervente cattolico, preparato dottrinalmente tanto da aver collaborato col suo vescovo di Lugano alla stesura degli schemi preparatori del Concilio Vaticano II. Parlava e scriveva per conoscenza diretta e, pur con un linguaggio colto e ricercato, affrontava gli argomenti con l’immediatezza del praticante e la semplicità del credente. Certo fu questo il motivo, forse principale, dell’ostracismo dell’intellighenzia ufficiale del mondo cattolico moderno, laico e chierico, avvezzo, ancora oggi, a trastullarsi con montagne di carte spesso confuse, ripetitive e contraddittorie. Oltre che alle accuse nei confronti del Concilio e dello spirito che lo precedette, lo produsse e lo seguì, già di per sé colpa imperdonabile per i cattolici moderni, il libro conteneva riflessioni critiche importanti e puntuali su tutta la vita della Chiesa espresse in maniera schietta, logica e convincente, era quindi doppiamente pericoloso. Con l’elevazione al Soglio Pontificio dell’allora cardinale Ratzinger, e con la nuova impostazione promossa da Benedetto XVI, soprattutto in ordine alla problematica postconciliare, certuni si sono ricordati che Iota unum, pur vecchio di vent’anni, poteva servire alla bisogna. Ed ecco che se ne è parlato perfino nelle pubblicazioni ufficiali della Curia romana, L’Osservatore romano e La Civiltà cattolica, cosa prima inaudita. Si sono svolti perfino dei convegni, con la partecipazione di prelati di Curia, anche grazie all’interessamento del Prof. Radaelli, discepolo di Amerio, curatore del suo libro postumo Stat Veritas e autore di un interessante testo con cui presenta Amerio e la sua opera : Romano Amerio. Della verità e dell’amore. Si potrebbe pensare che sia
finito l’ostracismo, che si sia aperta una nuova fase di apprezzamento
di questo testo e soprattutto dei suoi principali contenuti.
Indubbiamente questo è quello che appare, ma dietro l’apparenza
continuano a muoversi i vecchi postulati moderni della discussione per
la discussione, sempre noncuranti dell’essenziale.
Partiamo dalla nuova impostazione data dal Santo Padre. Essa nasce da una semplice constatazione: quarant’anni di postconcilio hanno prodotto più guasti e danni di quanto si potesse pensare all’inizio, occorre un nuovo approccio alle tematiche conciliari e soprattutto a quelle postconciliari. Iota unum, per il suo rigore e per il suo radicarsi nella dottrina tradizionale della Chiesa potrebbe essere un valido strumento di lavoro, tanto più che per tutti questi anni è stato considerato un testo anticonciliare, preconcetto e relegato in ambito “integralista”. Rivedere il postconcilio usando, tra l’altro, Iota unum permetterebbe anche di sanare la frattura tra l’ambito tradizionale e il più vasto contesto conciliare. Lungo questa strada si incontrano elementi diversi, che vale la pena anche solo accennare. Il primo riguarda la lettura del testo. Pare che questo si possa fare a prescindere dalla critica puntuale che Amerio fa del Concilio, dello spirito che lo produsse e dello spirito che lo attuò, spirito che prima ancora di essere parziale e interessato è essenzialmente anticattolico. Le variazioni di cui parla Amerio fin dal titolo del volume, non sono elementi accidentali ed episodici, magari circoscritti a questo o a quell’aspetto dell’insegnamento della Chiesa, ma variazioni strutturali nella concezione stessa del cattolicesimo e della vera religione. È nell’aver mostrato questo che sta il valore del testo di Amerio. Per leggerlo a prescindere da questo occorre indossare i diffusissimi occhiali deformanti prodotti in questi quarant’anni dalla nota ditta modernista “catto-…-ismo”, fornitrice ufficiale della Sede Apostolica. A mo’ d’esempio citiamo un passo di uno degli interventi sopraggiunti ultimamente. « Certo, non è possibile condividere il giudizio negativo esteso al Concilio nel suo insieme e a tutto ciò che di positivo ne è derivato. Inoltre, è opinabile il tentativo di spiegare tutte le attuali difficoltà del cristianesimo quasi solamente come esito di una deviazione dal dogma del Logos, del declassamento della Verità al secondo posto dopo l’amore. La realtà è più complessa e non si può ricondurre tutta a un solo aspetto: in questo caso c’è il rischio di riduttivismo filosofico.» (Innamorato della verità e della Chiesa, in La Civiltà Cattolica, quaderno 3762, 17.3.2007, pp. 622-623). Potremmo subito dire che per
noi semplici fedeli, che non siamo ferrati in profonde disquisizioni
teologiche, “il declassamento della Verità al secondo posto dopo
l’amore” non può essere considerato come un “aspetto” della
realtà, ci sembra piuttosto che si tratti dell’elemento centrale
e fondativo, non di questa o di quella questione, ma della stessa
religione.
Declassare la Verità, sia pure a favore dell’amore, è di per sé una relativizzazione di Dio, impossibile da giustificare o anche solo da prendere in considerazione come pura ipotesi di lavoro. Relativizzato Dio, si è distrutta la religione. Se dovessimo leggere Iota unum inforcando queste lenti deformanti, ne verrebbe fuori un ulteriore pasticcio dottrinale. Leggiamo allora cosa scrive propriamente Romano Amerio. A proposito del Concilio. «L’inclinazione del Vaticano II a sciogliersi dalla stretta continuità colla tradizione e a crearsi forme, modalità e procedure atipiche, non si sa se sia da attribuire allo spirito ammodernante che lo investì e diresse, oppure alla mente e all’indole di Paolo VI. Probabilmente l’inclinazione è da rifondere pro rata tanto al Concilio quanto al Pontefice. Il risultato fu un rinnovamento o meglio una novazione dell’essere della Chiesa che toccò strutture, riti, linguaggio, disciplina, atteggiamenti, aspirazioni, la faccia insomma della Chiesa destinata a presentarsi al mondo nuova.» (Cap.IV, 44). A proposito del declassamento
della Verità.
«La crisi della Chiesa, come si confessa e come abbiamo indicato nei paragrafi iniziali di questo libro, è crisi di fede, … Alla base del presente smarrimento vi è un attacco alla potenza conoscitiva dell’uomo … e non investe questa o quella certezza di ragione o di fede, bensì il principio medesimo di ogni certezza, cioè la capacità conoscitiva dell’uomo. … il fenomeno attinge una profondità teologica oltre che metafisica, perché attinge la costituzione dell’ente creato e quindi anche quella dell’ente increato del quale il primo è una imitazione analogica. Come nella divina Monotriade l’amore procede dal Verbo, così nell’anima umana il vissuto dal pensato. Se si nega la precessione del pensato al vissuto, della verità alla volontà, si tenta una dislocazione della Monotriade. Se infatti si nega la capacità di cogliere l’essere, l’espansione dello spirito nella primalità dell’amore rimane sconnessa dalla verità, perdendo ogni norma e degradando a pura esistenza.» (cap. XV, 147). «Il fondo dell’attuale smarrimento, mondiale ed ecclesiale, è il pirronismo, cioè la negazione della ragione. Superficiale è la taccia data comunemente alla civiltà moderna di sovraestimare la ragione. Se per ragione si intende la facoltà calcolatrice e costruttiva del pensiero, a cui dobbiamo la tecnica e il dominio delle cose, la qualificazione può correre. Ma tale facoltà è un grado inferiore, e si trova, dicono, nei ragni e nelle api. Ma se per ragione si prende, quale è, la facoltà di cogliere l’essere delle cose e il loro senso, e di aderirvi col volere, allora l’età contemporanea è molto più debitrice all’alogismo [mancanza di logica] che al razionalismo.» (cap. XV, 148). Fin qui Amerio che, dietro il discorrere puntuale e appropriato, manifesta una condanna così radicale che non potrà mai assumersi come oggetto di disquisizione. La questione posta, infatti, con parole povere potrebbe riassumersi così: senza il primario fondamento della Verità, di Dio, anche la volontà e l’amore si riducono a mero sentimento umano, non più rette e dominate dalla “ retta ragione”, l’intelletto illuminato dalla grazia, ma mosse dal continuo fluire dell’esistenza e da esso costrette. Un
altro elemento è costituito da quello che si evince da quanto
detto fin qui.
In fondo Amerio, si dice, pone innanzi tutto una questione teologica, centrando tutto il suo esame critico sulla perdita dell’assiologia, cioè della centralità della Verità e del Verbo, è su questo allora che occorrerà concentrarsi per esaminare e discutere le sue riflessioni circa le variazioni della Chiesa. Solo che per Amerio questo è l’elemento di base, su cui si fonda la nuova concezione del cattolicesimo praticata durante e dopo il Concilio, ma partendo da questa constatazione Amerio sviluppa tutta una serie di appunti critici che attengono a tutta la vita della Chiesa, dottrinale, sacramentale e pastorale. La sua attenzione si ferma su tutti gli aspetti della vita religiosa del fedele cattolico e della vita della Chiesa. Per far comprendere quanto sia fuorviante una tale impostazione, basta leggere l’indice dei capitoli e dei paragrafi, che riportiamo in calce, e subito rendersi conto che parlare di Amerio come di un metafisico preso nei cieli più alti, sia una semplice falsità. Chi volesse leggere Iota unum nonostante le sue 650 pagine non ha bisogno di affrontarlo come un trattato organico di teologia dogmatica, basta sfogliare il libro qua e là e soffermarsi su… “crisi del sacerdozio”, per esempio, o su “Chiesa e femminismo”, o su “rifiuto cattolico della scuola cattolica”, o su “la catechesi senza catechesi”, o su “l’aborto”… “la pena di morte”… “la guerra”… Chiesa e democrazia”, ecc. … e potremmo continuare per 334 paragrafi. Leggerne uno non significa essere costretti a rifarsi a tutte le 650 pagine, perché ogni argomentazione si tiene da sé. Che poi, leggendolo qua e là non si riesca a fare a meno di leggerlo tutto, è cosa che attiene alla sensibilità di tanti cattolici e cosa sommamente auspicabile soprattutto per tanti chierici che sono cresciuti nel clima superficiale e relativista dei seminari del postconcilio. C’è ancora un altro elemento che va
segnalato.
Iota unum come strumento per «attuare il progetto del Papa di leggere una continuità sostanziale tra il magistero e la teologia prima del concilio, il concilio e il post-concilio» (come scrive Mons. Luigi Negri nella prefazione all’edizione dell’editrice “Fede e Cultura”), o Iota unum come strumento per «discernere e ammirare l’inalterabile identità della nostra Chiesa, il perdurare di ciò che la definisce. Conosciamo la sua identità e la sua unità nella sua diversità» (come scrive il Card Castrillon Hoyos nella prefazione all’edizione dell’editrice “Lindau”) ? Per certi aspetti le due espressioni si assomigliano; entrambe pongono l’accento sulla possibilità che offrirebbe Iota unum di costruire un quadro complessivo in cui rientrerebbero coerentemente e organicamente gli insegnamenti di sempre e quelli nuovi sortiti dal Concilio, un quadro che descriverebbe così al meglio il multiforme volto della Chiesa. La differenza sta nel fatto che Mons. Negri privilegia la lettura a posteriori del Concilio in chiave di sopraggiunta necessità della individuazione della continuità con la Tradizione, mentre il Card. Castrillon mette in primo piano la multiforme difformità detta a priori “ricchezza delle sue [della Chiesa] policrome manifestazioni”. Non è nostra intenzione mancare di rispetto a nessuno, ma abbiamo l’impressione che i due prelati non abbiano mai letto Iota unum. Ove, tra l’altro, si dice che: «È appunto la reiezione del tomismo come filosofia, cioè come sistema di tesi, e la sua degradazione a puro atteggiamento metodico accomodato all’indole dei tempi, la nota che si vede impressa nella teologia postconciliare. Gli attacchi portati al tomismo nel Concilio non restarono senza influsso nella redazione dei testi. Il decreto Optatam totius sulla formazione intellettuale del clero al § 15 domanda che gli alunni siano guidati a una solida e coerente concezione dell’uomo, del mondo e di Dio “innixi patrimonio philosophico perenniter valido”, ma tace del tomismo […] Il concetto generico di filosofia perennemente valida subentrato a quello specifico di filosofia tomistica non ha più nessun significato ad rem.» (cap. XXXIV, 239). «…la costituzione apostolica Sapientia cristiana di Giovanni Paolo II, contenente le direttive per il rinnovamento delle Università. … si diffonde sulla libertà della ricerca teologica, ma non manifesta nessuna preoccupazione per l’unità dottrinale e lascia largo spazio alla pluralità degli insegnamenti. […] Così il § 32 prescrive per l’ammissione all’Università ecclesiastica “quei titoli di studio che si richiedono per l’ammissione alle università civili di quel paese.” Così accadrà che l’essere imbevuti di filosofia marxistica ed esistenzialistica divenga condizione per entrare negli istituti di formazione del clero». (cap. XXXIV, 240). Ci sembra difficile usare uno strumento come questo per leggere una continuità sostanziale tra il prima del Concilio, il Concilio e il post-Concilio, soprattutto ove ci si soffermi a considerare che nella sostanza le enunciazioni e le applicazioni conciliari sono connotati dal rifiuto dell’ieri della Chiesa e dall’adesione all’oggi del mondo. E dove si dice anche:
«La variazione instaurata nella Chiesa dal Vaticano II è confessata nel Convegno romano su san Tommaso d’Aquino nel centenario dell’enciclica Aeterni Patris: “Col Vaticano II, malgrado il suo riferimento a S. Tommaso, si apre il periodo del pluralismo teologico nel quale adesso viviamo» (Atti, Roma 1981, p. 168)» (cap. XXXIV, 240). «Benché il vocabolo pluralismo si trovi usato nel Concilio solo per indicare le diversità e le opposizioni interne alla società civile, e mai le varie scuole teologiche che vengono speculando sui dogmi nell’ambito della Chiesa, il pluralismo, è, insieme al dialogo, l’idea ispiratrice e direttiva del pensiero postconciliare. Ma se il pluralismo politico è conforme alla nozione di comunità politica, massime moderna, che respinge ogni unità fuorché quella che discende dal principio della libertà, non è punto facile comporre l’idea di pluralismo con quella di verità dogmatica e pertanto con quella di teologia cattolica.» (cap. XXXIV, 241). «Nel Convegno sul tomismo sopra citato il rifiuto [della protologia cattolica] è manifesto. Vi sono infatti professati aperta facie il mobilismo e il suo lemma del pirronismo relativistico. La teologia (si dice) deve aggiornarsi al pensiero moderno e perciò staccarsi dalla mentalità classica in cui la Chiesa si identificò sino al Vaticano II. Aggiornamento viene preso nel Convegno per assimilazione alla mentalità moderna senza provare antecedentemente se tale assimilazione sia possibile.» (cap. XXXIV, 242). Questa concezione del pluralismo cattolico moderno, che vige tutt’ora e che viene presentata come un valore, tanto da far parlare di ricchezza della diversità, comporta che nella Chiesa conciliare possano convivere e arricchirsi mutualmente le posizioni teologiche più diverse e le pratiche religiose più disparate. È ormai cosa nota che le diversità comporterebbero “logicamente” l’unità, sia tra le “chiese” sia all’interno della Chiesa cattolica. Come poi possano dirsi unite delle concezioni teologiche e delle pratiche cultuali che per propria natura sono separate e disunite, è un mistero che forse rimarrà insoluto fino alla fine dei tempi, nonostante la buona volontà di vescovi e cardinali. Per intanto registriamo che criticare il Concilio e il postconcilio è cosa che si concilia tranquillamente con la loro difesa, basta sottolineare le continuità e considerare una ricchezza le divergenze e convergenti le parallele. Per ultimo ci sembra il caso di annotare
una stranezza legata alla riedizione del lavoro di Amerio.
Da anni si sentiva la mancanza di Iota unum, soprattutto perché negli ultimi venti anni l’interesse per la questione tradizionale è andata sempre crescendo. Dopo vari tentativi effettuati negli ultimi tre anni, ecco che improvvisamente, anche sull’onda di quello che abbiamo su indicato, compaiono ben due diverse edizioni del libro. Una a cura di “Fede e Cultura”, di Verona, giovane casa editrice cattolica che in quasi cinque anni ha pubblicato diversi titoli interessanti, alcuni dei quali di un certo pregio. L’altra a cura di “Lindau”, di Torino, editrice esistente da vent’anni, ma solo da qualche anno voltasi alla religione, con una collana in cui sono presenti anche diversi testi del Card. Ratzinger. A marzo di quest’anno si viene a sapere che entro pochi mesi Iota unum sarà in libreria, pubblicato da “Fede e Cultura”, al prezzo di 40,00 Euri, ma si viene anche a sapere che la “Lindau” di Torino farà la stessa cosa, immettendo sul mercato entrambi i titoli più noti di Romano Amerio: Iota unum e Stat Veritas, ad un prezzo più basso (oggi 29,00 Euri il primo e 19,50 il secondo). Incredibile, ma vero! Fino all’anno scorso perfino certi editori cattolici si schermivano e prendevano tempo… com’è che nel giro di qualche mese è esploso quest’improvviso entusiasmo? Qualcuno potrebbe gridare al miracolo, ma pare che le cose siano andate in maniera del tutto prosaica. Il che, ovviamente, non ci interessa più di tanto. Quello che ci interessa invece è far notare come un’editrice cattolica sorta proprio in chiave conservatrice, se non proprio tradizionale, presenta un testo così importante ad un prezzo ben più alto di quello praticato da un’editrice che è tale quasi solo per mestiere. Come dire che per aiutare la diffusione di importanti testi cattolici è meglio rivolgersi agli editori laici piuttosto che a quelli cattolici, soprattutto se si dicono schierati. O la “Lindau” ha deciso questa volta di aiutare la Tradizione cattolica anche a costo di rimetterci, o “Fede e Cultura” si è fermata ad un semplice calcolo di interessi economici a cui ha subordinato la sua vocazione. Comunque sia andata, diciamo che è andata bene. Finalmente abbiamo la possibilità di comprare i libri di Amerio, sia per leggerli, sia per regalarli e diffonderli. A tal fine la nostra
Associazione
rende disponibili i due volumi di Amerio, della “Lindau”, ad un prezzo ridotto per i soci e i corrispondenti Indice dei capitoli e dei paragrafi
Romano Amerio
IOTA UNUM STUDIO DELLE VARIAZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA NEL XX SECOLO INDICE Capitolo I
1. Precisazioni di lessico e di metodoLA CRISI 2. Negazione della crisi 3. Errore del cristianesimo secondario 4. La crisi come inadattamento 5. Accomodazione della contrarietà della Chiesa al mondo 6. Ancora la negazione della crisi 7. Il Papa riconosce lo smarrimento 8. Pseudo-positività della crisi. Falsa teodicea 9. Nuove confessioni della crisi 10. Interpretazione positiva della crisi. Falsa teodicea 11. Ancora della falsa teodicea CAPITOLO II
12. Le crisi della Chiesa. Gerusalemme (anno 50) SCHIZZO STORICO. LE CRISI DELLA CHIESA 13. La crisi di Nicea (anno 325) 14. Gli smarrimenti dell’età di mezzo 15. La crisi della secessione luterana. Ampiezza ideale del Cristianesimo 16. Ancora della ampiezza ideale del Cristianesimo. Suoi limiti 17. Negazione del principio cattolico nella dottrina luterana 18. Ancora l’eresia di Lutero. La bolla «Exsurge, Domine» 19. Il principio di indipendenza e gli abusi nella Chiesa 20. Perché la casistica non abbia fatto crisi nella Chiesa 21. La Rivoluzione di Francia 22. Il principio di indipendenza. La «Auctorem fìdei» 23. La crisi della Chiesa nella Rivoluzione di Francia 24. Il sillabo di Pio IX 25. Lo spirito del secolo. Alessandro Manzoni 26. La crisi modernista. Il secondo Sillabo 27. La crisi preconciliare e il terzo Sillabo 28. La «Humani generis» (1950) CAPITOLO III LA PREPARAZIONE DEL CONCILIO 30. Esito paradosso del Concilio 31. Ancora l’esito paradosso del Concilio. Il Sinodo Romano 32. Ancora l’esito paradosso del Concilio. La «Veterum sapientia» 33. I fini del Concilio Vaticano I 34. I fini del Vaticano II. La pastoralità 35. Le aspettazioni intorno al Concilio 36. Le previsioni del card. Montini. Suo minimismo 37. Le previsioni catastrofali CAPITOLO IV
38. Il discorso inaugurale: l’antagonismo col mondo e la
libertà della Chiesa LO SVOLGIMENTO DEL CONCILIO 39. Il discorso inaugurale. Poliglossia e polisenso testuale 40. Il discorso inaugurale: nuovo atteggiamento di fronte all’errore 41. Reiezione del Concilio preparato. La rottura della legalità conciliare 42. Ancora la rottura della legalità conciliare 43. Conseguenze della rottura della legalità. Se ci sia stata cospirazione 44. L’azione papale nel Vaticano II. La «Nota praevia» 45. Ancora l’azione papale nel Vaticano II. Interventi sulla dottrina mariologica. Sulle missioni. Sulla morale coniugale 46. Sintesi del Concilio nel discorso di chiusura della quarta sessione. Confronto con Pio X. Chiesa e mondo CAPITOLO V IL POSTCONCILIO 48. L’oltrepassamento del Concilio. Carattere anfibologico dei testi conciliari 49. Ermeneutica neoterica del Concilio. Variazioni semantiche. Il vocabolo «dialogo» 50. Ancora l’ermeneutica neoterica del Concilio. Circiterismi. Uso della avversativa «ma». L’approfondimento 51. Caratteri del postconcilio. L’universalità del cangiamento 52. Ancora del postconcilio. L’uomo nuovo. GS 30. Profondità del cangiamento 53. Impossibilità di variazione radicale nella Chiesa 54. Ancora l’impossibilità della novità radicale 55. La denigrazione della Chiesa storica 56. Critica della denigrazione della Chiesa 57. Falsa retrospettiva sulla Chiesa dei primordi CAPITOLO VI LA CHIESA POSTCONCILIARE. PAOLO VI 59. La cattolicità nella Chiesa. Obiezione. La Chiesa come principio di divisione. Paolo VI 60. L’unità della Chiesa postconciliare 61. La Chiesa disunita nella gerarchia 62. La Chiesa disunita circa «Humanae vitae» 63. Ancora la Chiesa disunita circa l’enciclica papale 64. Lo scisma olandese 65. La desistenza dell’autorità. Una confidenza di Paolo VI 66. Un parallelo storico. Paolo VI come Pio IX 67. Governo e autorità 68. Ancora la desistenza dell’autorità. L’affare del catechismo francese 69. Carattere di Paolo VI. Autoritratto. Card. Gut 70. Sic et non nella Chiesa postconciliare 71. Ancora la desistenza dell’autorità. La riforma del Santo Officio 72. Critica della riforma del Santo Officio 73. Variazione della Curia romana. Difetto di acribia 74. Ancora la variazione della Curia romana. Cultura difettosa 75. La desistenza della Chiesa nei rapporti con gli Stati 76. Ancora la revisione del Concordato 77. La Chiesa di Paolo VI. I discorsi di settembre 1974 78. Irrealismo intermittente di Paolo VI CAPITOLO VII LA CRISI DEL SACERDOZIO 80. La legittimazione canonica della defezione sacerdotale 81. Tentativi di riforma del sacerdozio cattolico 82. Critica della critica del sacerdozio cattolico. Don Mazzolari 83. Sacerdozio universale e sacerdozio ordinato 84. Critica dell’adagio «il prete è un uomo come tutti gli altri» CAPITOLO VIII LA CHIESA E LA GIOVENTÙ 86. Carattere della gioventù. Critica della vita come gioia 87. I discorsi di Paolo VI ai giovani 88. Ancora del giovenilismo nella Chiesa. I vescovi svizzeri CAPITOLO IX LA CHIESA E LA DONNA 90. Critica del femminismo. Il femminismo come mascolismo 91. La teologia femminista 92. La tradizione egualitaria della Chiesa. Subordinazione e sovraordinazione della donna 93. La subordinazione della donna nella tradizione cattolica 94.Apologia della dottrina e della prassi della Chiesa circa la donna 95. Elevazione della donna nel cattolicismo 96. Lo scadimento del costume 97. Filosofia del pudore. La vergogna della natura 98. La vergogna della persona. Reich 99. Documenti episcopali sulla sessualità. Card. Colombo. Vescovi tedeschi CAPITOLO X SOMATOLATRIA E PENITENZA 101. Lo sport come perfezione della persona 102. Lo sport come incentivo di fraternità 103. La somatolatria nei fatti 104. Spirito penitenziale e mondo moderno. Riduzione di astinenze e digiuni 105. La nuova disciplina penitenziale 106. Etiologia della riforma penitenziale 107. Penitenza e obbedienza CAPITOLO XI MOTI RELIGIOSI E SOCIALI 109. Scomparsa o trasformazione dei partiti cattolici 110. La desistenza della Chiesa nella campagna italiana sul divorzio e sull’aborto 111. La Chiesa e il comunismo in Italia. Le condanne del 1949 e del 1959 112. Chiesa e il comunismo in Francia 113. Ancora dei cristiani impegnati 114. Indebolimento delle antitesi 115. Principii e movimenti nella «Pacem in terris» 116. Di un socialismo cristiano. Toniolo. Curci 117. La dottrina del padre Montuclard e lo svuotamento della Chiesa 118. Passaggio dall’opzione marxistica alla teologia della liberazione. Il nunzio Zacchi. Il documento dei diciassette vescovi 119. Giudizio sul documento dei Diciassette 120. Ancora dell’opzione di cristiani. Mons. Fragoso 121. Esame della dottrina di mons. Fragoso 122. Consensi alla dottrina dei Diciassette CAPITOLO XII LA SCUOLA 124. Necessità relativa della scuola cattolica 125. Il documento della Congregazione per l’educazione cattolica del 16 ottobre 1982 126. Rifiuto cattolico della scuola cattolica. Mons. Leclercq 127. Pedagogia moderna. La catechesi 128. Pedagogia neoterica 129. La cognizione del male nella dottrina cattolica 130. Insegnamento e autorità. La catechesi CAPITOLO XIII LA CATECHESI 132. La dissoluzione della catechesi. Padre Arrupe. Card. Benelli 133. La dissoluzione della catechesi. Le Du. Charlot. Mons. Orchampt 134. Rinnovamento e inanizione della catechesi in Italia 135. Il convegno dei catechisti romani attorno al Papa 136. Antitesi della nuova catechesi alle direttive di Giovanni Paolo II. Card. Journet 137. La catechesi senza catechesi 138. Restaurazione della catechesi cattolica CAPITOLO XIV GLI ORDINI RELIGIOSI 140. L’alterazione dei principii. La stabilità 141. La variazione di fondo 142. Le virtù religiose nella riforma postconciliare. Castità. Temperanza 143. Povertà e obbedienza 144. Nuovo concetto dell’obbedienza religiosa 145. Insegnamento del Rosmini circa l'obbedienza religiosa 146. Obbedienza e vita comunitaria CAPITOLO XV IL PIRRONISMO 148. Il pirronismo nella Chiesa. Card. Léger. Card. Heenan. Card. Alfrink. Card. Suenens 149. L’invalidazione della ragione. Sullivan. Rifiuto neoterico della certezza 150. Ancora l’invalidazione della ragione. I teologi di Padova. I teologi di Ariccia. Manchesson CAPITOLO XVI
151.Dialogo e discussionismo nella Chiesa postconciliare. Il
dialogo in «Ecclesiam suam»IL DIALOGO 152. Filosofia del dialogo 153. Inidoneità del dialogo 154. I fini del dialogo. Paolo VI. Il Segretariato per i non credenti 155. Se, il dialogo sia sempre un arricchimento 156. Il dialogo cattolico CAPITOLO XVII IL MOBILISMO 158. Critica del mobilismo. Ugo Foscolo. Kolbenheyer 159. Il mobilismo nella Chiesa 160. Mobilismo e mondo della fuga. Sant’Agostino 161. Il mobilismo nella teologia neoterica 162. Il mobilismo nell’escatologia CAPITOLO XVIII LA VIRTÙ DELLA FEDE 164. La virtù teologica della fede 165. Critica della fede come ricerca. Lessing 166. Critica della fede come tensione. I vescovi francesi 167. Motivo e certezza della fede. Alessandro Manzoni CAPITOLO XIX LA VIRTÙ DELLA SPERANZA CAPITOLO XX LA VIRTÙ DELLA CARITÀ 170. La vita come amore. Ugo Spirito 171. L’amore e la legge 172. La negazione della legge naturale. Sartre 173. Richiamo della dottrina cattolica 174. Maestà e vilipendio della legge naturale CAPITOLO XXI LA LEGGE NATURALE 176. La legge come creazione dell’uomo. Duméry 177. Rifiuto della legge naturale ad opera della società civile CAPITOLO XXII IL DIVORZIO 179. Ancora Maximos IV. La formula “umanamente parlando” 180. Il valore dell’indissolubilità CAPITOLO XXIII LA SODOMIA CAPITOLO XXIV L’ABORTO 183. La nuova teologia dell’aborto. I Gesuiti di Francia 184. Ancora la nuova teologia dell’aborto. L’argomento Beethoven. Corte costituzionale italiana 185. Radice ultima della dottrina dell’aborto. Teoria di potenza e atto CAPITOLO XXV
186. Il suicidio IL SUICIDIO CAPITOLO XXVI LA PENA DI MORTE 188. L’opposizione alla pena capitale 189. Variazione dottrinale nella Chiesa 190. Inviolabilità della vita. Essenza della dignità umana. Pio XII CAPITOLO XXVII LA GUERRA 192. Pacifismo e pace. Card. Poma. Paolo VI. Giovanni Paolo II 193. La dottrina del Vaticano II 194. Le aporie della guerra 195. L’aporia della guerra moderata. Voltaire. Pio XII. Impossibilità finale della guerra moderna 196. Rimozione dell’aporia della guerra nella società etnarchica CAPITOLO XXVIII LA MORALE DI SITUAZIONE 198. Critica della creatività della coscienza. Passività dell’uomo morale. Rosmini 199. La morale di situazione come morale d’intenzione. Abelardo 200. Se la morale cattolica levi il dinamismo della coscienza CAPITOLO XXIX GLOBALITÀ E GRADUALITÀ 202. Puntualità della vita morale 203. Critica della globalità 204. La morale della gradualità CAPITOLO XXX L’AUTONOMIA DEI VALORI 206. Critica della teleologia antropocentrica. Prov. 16, 4 207. L’autonomia dei valori mondani 208. Il senso autentico dell’autonomia naturale. Amabilità e inamabilità dell’uomo 209. Si scioglie un’obiezione CAPITOLO XXXI LAVORO, TECNICA E CONTEMPLATIVA 211. La tecnica moderna. La manipolazione genetica 212. L’impresa lunare. Falsità dell’interpretazione religiosa 213. Nuovo concetto del lavoro. L’enciclica «Laborem exercens» 214. Il Cristo come uomo del lavoro. Critica 215. Il lavoro come autorealizzazione dell’uomo. Critica 216. Distinzione fra speculativo e pratico 217. Superiorità della contemplativa sul lavoro CAPITOLO XXXII CIVILTÀ E CRISTIANESIMO SECONDARIO 219. Civitas diaboli, civica hominis, civica Dei 220. Il cristianesimo secondario. Confusione di religione e civiltà 221. Critica del cristianesimo secondario. Errore teologico. Errore eudemonologico 222. Chiesa e civiltà nel postconcilio 223. Cattolicismo e gesuitismo 224. Il mito del grande inquisitore CAPITOLO XXXIII LA DEMOCRAZIA NELLA CHIESA 226. Variazione di dottrina circa la democrazia. Passaggio dalla specie al genere 227. Esame del sistema democratico. Sovranità popolare. Competenza 228. Esame della democrazia. Sofisma della sineddoche 229. Esame della democrazia. Maggioranza dinamica. Partiti 230. Chiesa e democrazia 231. Influsso dell’opinione pubblica nella vita della Chiesa 232. Nuova funzione dell’opinione pubblica nella Chiesa 233. Conferenze episcopali. Sinodi 234. Sinodi e Santa Sede 235. Spirito e stile dei sinodi. Il Forum elvetico 1981 CAPITOLO XXXIV
236. Filosofia e teologia nel cattolicismo TEOLOGIA E FILOSOFIA NEL POSTCONCILIO 237. La sfigurazione del tomismo. Schillebeecks 238. Attualità e perennità del tomismo. Paolo VI 239. Rifiuto postconciliare del tomismo 240. Il tomismo teologico nella Chiesa postconciliare. Epocazione della «Aeterni Patris» 241. Il pluralismo teologico nella tradizione 242. Il pluralismo teologico nei neoterici 243. Il dogma e le formule 244. Teologia e Magistero. Hans Küng CAPITOLO XXXV L’ECUMENISMO 246. La variazione conciliare. Villain. Card. Bea 247. L’ecumenismo postconciliare. Paolo VI. Il Segretariato per l’unione 248. Conseguenze dell’ecumenismo postconciliare. Cessazione dei ritorni 249. Carattere politico dell’ecumene 250. Incongruità del metodo ecumenico 251. Passaggio all’ecumene dei non cristiani 252. Carattere naturalistico dell’ecumenismo per i non cristiani. Dottrina del Segretariato per le religioni non cristiane 253. Teoria dei cristiani impliciti nel nuovo ecumenismo 254. Critica del nuovo ecumenismo. Tintura pelagiana. Insignificanza della missione 255. Conversione della religione in civiltà. L’ecumenismo campanelliano 256. Influenza della psicologia moderna sul nuovo ecumenismo 257. La summa del nuovo ecumenismo in due scritti dell’«Osservatore romano» 258. Critica del nuovo ecumenismo. Ancora l’insignificanza della missione 259. Debolezza teologica del nuovo ecumenismo 260. Stato reale dell’ecumenismo. Dall’ecumenismo religioso all’umanitario CAPITOLO XXXVI I SACRAMENTI. IL BATTESIMO 262. La pratica del battesimo nei secoli 263. Tendenza neoterica alla soggettivazione del battesimo 264. Battesimo in fide parentum CAPITOLO XXXVII L’EUCARISTIA 266. Teologia dell’eucaristia 267. Teologia neoterica dell’eucaristia 268. Il dileguo dell’adorazione 269. Culto eucaristico extraliturgico 270. La degradazione del sacro 271. Il venerandum e il tremendum dell’eucaristia nella storia della Chiesa 272. Sacerdozio e sinassi eucaristica 273. Analisi dell’articolo 7 274. La degradazione del sacerdozio nell’eucaristia. Card. Poletti 275. Preponderanza della sinassi al sacramento CAPITOLO XXXVIII LA RIFORMA LITURGICA 277. Latinità e popolarità nella liturgia 278. I valori della latinità nella Chiesa. Universalità 279. Immutabilità relativa. Carattere eletto dell’idioma latino 280. La neovulgata liturgica 281. La neovulgata liturgica. Variazione lessicale. Vene pelagiane 282. La neovulgata liturgica. Anfibologie dogmatiche 283. Disfatta generale del latino 284. Critica dei principii della riforma liturgica. L’espressività umana 285. II principio di creatività 286. Passaggio dal sacro al teatrico 287. Passaggio dal pubblico al privato 288. Bibbia e liturgia 289. Pletora e difformità nella neovulgata 290. Altare e mensa nella riforma liturgica 291. L’altare facciale 292. La nuova architettura sacra 293. Sinossi della riforma liturgica CAPITOLO XXXIX IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 295. Primario e secondario nei valori del matrimonio 296. Prevalenza del fine genetico nella dottrina tradizionale. Luc. 20, 35-6 297. Matrimonio e contraccezione 298. Critica della teologia della contraccezione CAPITOLO XL TEODICEA 300. Nuova concezione della causalità divina. I vescovi di Francia 301. Variazione nella dottrina della preghiera 302. Provvidenza e flagelli 303. Origine morale del dolore umano 304. Il male della morte 305. Preparazione alla morte e dimenticanza della morte 306. La morte improvvisa. Pio XI 307. La morte come giudizio 308. Giustizia e misericordia nella morte cristiana 309. Epocazione dell’idea del giudizio 310. Dignità della sepoltura nel rito cattolico 311. Degradazione della sepoltura 312. La cremazione CAPITOLO XLI ESCATOLOGIA 314. Apologia dell’inferno 315. L’eternità delle pene 316. L’inferno come pura giustizia EPILOGO 318. L’invariabilità del dogma. Il Lirinense e il card. Newman 319. La sostanza trascritta dai neoterici come modalità 320. La perdita dell’unità nella Chiesa 321. Sdogmatizzazione e indifferentismo. «Etudes». Mons. Le Bourgeois 322. Perdita dell’unità cultuale 323. Perdita dell’unità di regime. Sromanizzazione del Sacro Collegio 324. Sinossi della Chiesa nel mondo contemporaneo. Card. Siri. Card. Wyszynski. Episcopato di Francia 325. Crisi della Chiesa e crisi del mondo moderno. Paral¬lelo tra il declino del Paganesimo e il presente declino della Chiesa 326. Declino dell’influsso sociale della Chiesa nel mondo 327. Declino dell’influsso vitale della Chiesa nel mondo internazionale 328. La Chiesa disorbitata per il cristianesimo secondario. La «Populorum progressio» 329. Oscurazione dell’escatologia. L’ecumene umanitaria 330. Leggi dello spirito del secolo. Il piacente. L’oblio 331. I fatti dell’oblio nella Chiesa contemporanea 332. Deduzione metafisica della crisi 333. Diagnosi e prognosi. Due congetture finali 334. L’onus contra Dumam (su) AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI |