 |
 |
| LE FARANDOLE DI UNA BISCHERA DANTENAUTA di Luciano Pranzetti
Non c’è sosta per gli escursionisti dell’occulto e per i sommozzatori del mistero che, ardimentosi e tenaci, si infilano nei laberinti di elucubrazioni oracolari, con la continuità di un esercizio ermeneutico teso a dimostrare e a rivelare il vero Dante, quello che, a parer loro, sta nascosto sotto i versi della Commedia o degli altri scritti. 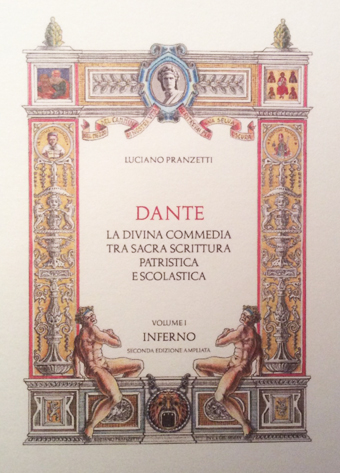 Mantengono viva la catena di un dna in cui sfilano e si avvolgono triplette, quartetti, sciami di armeggioni e fànfani, eruditi e pieni di somma verbosa sapienza, dei quali facemmo una lista nel nostro “Dante: la Divina Commedia tra Sacra Scrittura, Patristica, Scolastica – vol. I Inferno, 2016, Ed CIC”. Sono, costoro, i benemeriti che, privi di ‘sensus communis’ distillano fantasìe e fanfaluche su un Dante tipo tutt’altro che ortodosso come lo disegnano gli accademici che, poverini, non sanno andare oltre l’ apparenza ‘de li versi strani’ (Inf. IX, 63) e non colgono la vera essenza del fiorentino. E c’è in circolazione chi ancora ricerca e pesta sul tasto del Dante alchimista, omosessuale, ghibellino, massone, rosacroce, extraterrestre, templare, addirittura consumatore di hashish. Sono ondate che l’editoria del settore “misterico e sapienziale” regola con calcoli di mercato - per lo più da bancarella - e che, a dir il vero, ha dalla sua una clientela folta e variegata che oscilla dall’ignorante, al curioso fino allo “specialista”. C’era stato chi aveva tratteggiato il poeta come eretico, un eretico camaleontico pratico dell’arte dell’onesta dissimulazione, e di cui non èrasi data prova scientifica, storica e teologica, finché non è arrivato l’ultimo che ha aperto a noi le porte del mistero. Lo spunto di questo nostro intervento è stata la pubblicità, riapparsa su una pagina culturale della rete, con annesso elogio, di un libro da tempo in circolazione, con cui l’autrice, tale Maria Soresina, proclama, in modo analitico e definitivo, la verità su un Dante eretico – e che eretico! – un Dante ‘cataro’. “Libertà va cercando. Il catarismo nella Commedia di Dante” è il titolo di questo prodotto che noi, per dovere professionale, leggemmo all’indomani del suo lancio editoriale, A.D. 2009. Un fastello di conati eruditi, di raccordi e di consonanze spurie, ipotesi che evolvono in tesi mercé ‘a priori’ spiattellati come postulati, salti acrobatici e falsificazioni tesi ad asseverare l’indimostrabile, e immancabili forzature della stessa poesìa dantiana. Poiché qualche amico, giorni or sono, conoscendo il nostro sessantennale studio delle opere dantiane, ci ha chiesto di questa, a lui ignota, ‘verità’, abbiamo pensato essere ottimo e opportuno servigio, estrarre dal cassetto, una traccia critica che tirammo a mo’ di chiosa, per dire, sul nostro sito, qualcosa su tale argomento allo scopo di diradare, in alcun lettore non preparato, le brume del dubbio o della sospensione del pensiero, ma soprattutto di affermare, per dovere apologetico, la vera identità della nostra maggior Musa, cattolico inconcusso, granitico, legato alla Tradizione, ardente di fede per dottrina e per vita e che oggi, epoca di bilancini dogmatici ed etici e di angelismo neopelagiano (non esiste peccato), si appresenta come cattiva coscienza a una Gerarchìa traditrice della Parola di Dio, venduta e caduta corpo e anima, in cambio di applausi e notorierà, nella viscosa ragnatela della mondanità. Non staremo, pertanto, a dar conto del libro in maniera analitica né tanto meno a scorrere la storia della sètta similgnostica perché a noi preme, in questa sede, smontare quelle ridicole, supponenti, saccenti affermazioni mediante un semplice confronto, diremmo filologico, delle posizioni catare con quella di Dante. Enunceremo, in forma piuttosto stringata, i princìpi catari (C) a cui faremo seguire la contrapposta dottrina del poeta (D). C – Professano una dottrina dualistica, analoga al Manicheismo, affermando un contrasto tra mondo materiale e mondo spirituale. D
– Crede le due realtà come complementari, create da Dio (Par. XXXIII, 88/93)
C - Credono a due princìpi contrapposti e coeterni: il Bene e il Male. D
– E' monoteista, cristiano cattolico credente in Dio uno e
trino (Par. XXIV,
139/141), sommo Bene, pienezza
dell’essere; nega eternità al male in quanto
manifestazione ed opera di Satana, angelo creato ma decaduto (Inf. XXXIV, 34/36).
C – Considerano l’universo come opera del Male (demiurgo) D
– Crede il creato come opera di Dio infinitamente buono (Par. XXIX, 22/24).
C – Considerano il corpo umano come negatività del Male. D
– Considera il corpo umano, pur corrotto dal peccato, quale ‘tempio
dello Spirito Santo’ destinato alla gloria della resurrezione (Purg. X, 124/126 – Par. XIV, 43/51 - 52/54 - 58/60).
C – Nutrono disprezzo per la donna, la ritengono elemento malefico (specialmente la donna incinta che, per questo può essere liberamente copulata), creatura corrotta e intoccabile (specie nel periodo mestruale) e avversano il matrimonio. D
– Esalta la donna quale altissima nobiltà della natura umana (Par.
XXXIII, 4/6), creatura ‘angelicata’ e
guida alla salvezza (Par.
XXX, 79/90); considera la
maternità come culmine
dell’amore nella sequela dell’ordine divino (Gen. 1, 28), e ne dà esempio sposandosi e
generando tre figli.
C - Rifuggono l’amore e lo condannano. D
- Pone l’origine dell’amore perfetto in Dio (Par. VIII, IX) e lo esalta nella cifra dello ‘Stilnovo’.
C – Non riconoscono le autorità terrene (Papa, imperatore, re) e le istituzioni umane. D
– Riconosce, nell’ordine della gerarchìa - teorìa dei
“due soli” - i poteri spirituale - temporale (Monarchia,
III – Inf. XIX, 100/102 - Purg. XVI, 97/99).
(C – Predicano una società socialista egalitaria con in comune beni, donne e bambini. D
– Tipico intellettuale e cittadino “comunale” crede nella
proprietà privata di beni la cui gestione si estrinseca anche
nell’opera di carità (Par.
XI – San Francesco), e condanna il furto quale peccato di
appropriazione indebita di beni altrui (Inf. XXIV, XXV) e la dissipazione come peccato contro se
stessi e le cose (Inf.
XIII, 109/151 – Purg. IV,
19/21).
C – Rifiutano la dottrina del libero arbitrio. D
– Sulla scorta della Scrittura (Gen. 3, 22), di Aristotile, di San Tommaso Aquinate e
della dottrina
della Chiesa, afferma l’esistenza nell’uomo del libero arbitrio come
facoltà di scelta tra il bene e il male (Purg. XVI, 67/84 – Par. V, 19/24)
C – Idealizzano ed impongono il suicidio (endura) come strumento di salvezza. D
– Condanna il suicidio quale violenza contro se stessi e contro
l’umanità (Inf.
intero XIII, e in particolare vv. 70/72).
C – Credono nel ciclo delle esistenze (reincarnazione). D
– Afferma l’unicità personale di vita con l’immissione, dopo la
morte, nell’irreversibilità dell’eterno premio o dell’eterno
castigo (Inf. III,
85/87 – Purg. I, 88/90 – Purg. XXVII, 58 - Par. XX, 106/108).
C – Distinguono livelli e classi di dignità: perfetti (pneumatici), credenti (psichici), perduti (ilici). D
– Crede nell’uguaglianza morale e spirituale tra tutti gli uomini,
davanti a Dio perché tutti chiamati alla salvezza (Purg. X, 124/126 - Par. XVIII, 129).
C – Sono eretici, scismatici con deriva gnostica, ribelli alla Chiesa Cattolica, nutrono odio per la Croce, praticano l’omicidio e la rapina ai danni dei cristiani. D
– È cattolico ortodosso (Par. XXIV, 85/87), obbediente alla Chiesa (Par. XXV, 52/54), condanna gli eretici (Inf. X : Farinata e Cavalcante Cavalcanti, noti
catari), gli scismatico
(Inf. XXVIII, 55/57), esalta le figure di
San Bernardo, San Domenico (Par.
XII, 100/102) e Folco da Marsiglia
che combatterono l’eresìa catara, e approva le opere di
carità (Purg.
XX, 31/33 – Par. VI, 127/142)
C – Non riconoscono Gesù e il mistero della sua Morte. D
– Crede in Cristo Figlio di Dio e nell’opera di salvezza compiuta con
la crocifissione (Par.
VII, 97/105 – Par. XIV,
100/108 – Par. XXVI, 58/60).
C – Criticano la struttura gerarchica della Chiesa cattolica pur possedendone una propria. D
– Riconosce nell’ordine gerarchico della Chiesa la volontà di Dio
(Par. I, 109/120 – Par. V, 76/78).
C – Considerano ogni forma di dissolutezza, vissuta prima dell’iniziazione, come non peccaminosa. D
- Condanna la lussuria (Inf.
V, 37/39), l’ingordigia (Inf. VI, 52/54), la sodomia (Inf. XV – Purg. XXVI, 76/81) come peccati gravi contro la legge
naturale e divina.
C – Praticano la dissimulazione come forma di condotta da tenere quando conviene. D
- Critica e condanna quanti si nascondono nella neutralità
facendone uno stile di vita (Inf.
III, 34/42 – Purg. XXII,
88/93).
Questi, in breve, sono gli argomenti con cui si demolisce qualsiasi tentativo di intruppare il cattolicissimo Dante nella greggia degli gnosto/eretici catari. Dove, l’autrice del predetto libro, abbia, in recessi chissà quanto segreti, scovato gli indizî e le prove della sua bischera intuizione, è un mistero che potrebbe rientrare tra quelli che ella stessa ha tentato di svelare. Se solo si fosse dedicata ad enumerare i riporti biblici, patristici e scolastici che il poeta innesta nella sua Commedia, avrebbe di sùbito, risparmiando tempo e carta, abbandonata la sterile e maldestra impresa di annunciare urbi et orbi la corbelleria di un “Dante cataro”. 4 aprile 2017 – Sant’Isidoro di Siviglia . (torna
su)
aprile 2017 |