 |
 |
| La Compagnia di Gesù allo sbando. L’atto d’accusa di un grande gesuita di Sandro Magister Pubblicato sul sito dell'Autore “Settimo
Cielo”
L'impaginazione e l'immagine sono nostre 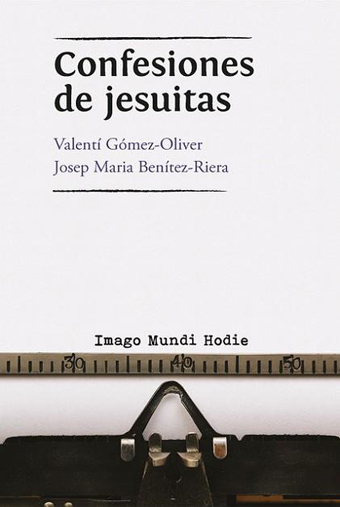 “Mi sembra di essere in buona Compagnia…”. Così un esultante Antonio Spadaro ha salutato via twitter l’uscita di “Confesiones de jesuitas”, la riedizione ampliata di un libro già pubblicato nel 2003 col titolo “31 jesuitas se confiesan”, nel quale ora compare anche lui, assieme ad altri 37 suoi confratelli tra cui alcuni di prima grandezza, vivi e defunti, da Avery Dulles a Carlo Maria Martini, da Roberto Tucci a Tomás Spidlik, da Jon Sobrino a Robert F. Taft, da Adolfo Nicolás ad Arturo Sosa Abascal, ultimi due generali dell'ordine fondato da sant'Ignazio di Loyola. I curatori del libro, i catalani Valentí Gómez-Oliver e Josep M. Benítez-Riera, scrivono nella prefazione che a stimolare l’aggiornamento di questa raccolta di testimonianze è stata l’elezione del primo papa gesuita della storia. A ciascuno degli interpellati hanno chiesto di “confessare” la loro personale esperienza di vita al fine di comporre una sorta di autoritratto collettivo della Compagnia di Gesù, arrivata oggi con Jorge Mario Bergoglio all’apice della Chiesa. Ma attenzione. “Confesiones de jesuitas” è lontano dall’essere un libro celebrativo. Padre Spadaro non deve essersene accorto, visto come ha esultato a trovarsi in mezzo a una Compagnia che non risulta affatto essere così “buona”, stando al giudizio di alcuni dei suoi stessi confratelli. Basta leggere, per capire questo, la “confessione” di Xavier Tilliette, francese, morto a quasi cent’anni il 10 dicembre del 2018 e salutato il giorno dopo su “L’Osservatore Romano” come “non solo un filosofo e un teologo di razza, ma un vero gesuita”- Tilliette non aveva rivali
come studioso del filosofo tedesco Schelling, al quale dedicò un
libro monumento a tutt’oggi insuperato. Ma le sue ricerche spaziavano
oltre, sul confine tra fede e ragione, procurandogli l’ammirazione e
l’amicizia di giganti del pensiero cattolico del XX secolo come Gaston
Fessard, Henri de Lubac, Jean Daniélou, Hans Urs von Balthasar,
i primi tre anch’essi gesuiti. Ed è tutto da leggere il commosso
ricordo che gli dedicò su “L’Osservatore Romano” il
confratello Jacques Servais, discepolo di von Balthasar e autore della
più importante intervista teologica a Joseph
Ratzinger dopo la sua rinuncia al papato.
Ebbene, ecco che cosa scrive – tra molto altro – Tilliette nella sua “confessione”. Per cominciare, queste sue parole fanno come da titolo a ciò che segue: “La mia vocazione religiosa
nella Compagnia di Gesù fu precoce e praticamente non ha mai
vacillato. Solo che negli ultimi decenni, di fronte ai cambiamenti che
ne hanno reso irriconoscibili i tratti originari, è stata messa
a dura prova e mi sono sorti degli interrogativi: sull’esercizio dei
voti, sulla povertà e l’obbedienza, sulla funzione dei
superiori, sul futuro della Compagnia”.
Uno dei momenti di svolta fu il 1968, che Tilliette visse a Parigi, proprio mentre si dedicava anima e corpo al suo monumentale studio su Schelling e mentre un suo più celebre confratello gesuita, Michel de Certeau – anni dopo definito da papa Francesco “il più grande teologo per il giorno d’oggi” ma bollato da de Lubac come un "gioachimita" infatuato di una presunta epoca d'oro senza più l’istituzione Chiesa – esaltava invece la rivolta come momento di liberazione totale: “Ho vissuto molto male la
crisi del maggio 1968, dalla quale presi subito le distanze.
L’entusiasmo di un Michel de Certeau mi sembrava del tutto fuori luogo.
Si assisteva al saccheggio di questa venerabile istituzione,
l’università, e di rimbalzo a uno sgretolamento della Compagnia
dal quale essa non si è più ripresa”.
Questo “sgretolamento”, Tilliette lo descrive così, in una Compagnia di Gesù diventata irriconoscibile per lui e per tanti altri suoi confratelli: “In parallelo all’improvviso
sommovimento del 1968 e senza relazione con esso, ha avuto luogo la
ragionata trasformazione della Chiesa a seguito del Concilio. Ma
l’aumento di libertà che ne derivò ebbe conseguenze
disastrose per gli scolasticati della Compagnia. In quell’occasione
vissi molto male anche l’evoluzione o trasformazione del nostro modo di
vita. La ribellione degli scolasticati mi sembrava assurda. Restavo
convinto che la Compagnia avesse i nervi più saldi e una forza
interiore capace di di superare la crisi senza cedere nulla
dell’essenziale. Ma il risultato non è stato quello che speravo.
Grazie a Dio, lo spirito si è salvato, ma il corpo dello
spirito, la lettera, ha sofferto in forma duratura. È una dura
prova quella che è stata inflitta ai gesuiti della mia
generazione, della generazione precedente e di quella seguente.
Sarà carenza di flessibilità, mancanza di adattamento,
però essi non si riconoscono più nello stile di vita
rilassata che si è instaurato, non si riconoscono più
nell’ordine che in tempi precedenti li accolse. Le congregazioni
generali hanno preso atto dei cambiamenti che si sono prodotti nei
comportamenti, della volontà di indipendenza dei loro membri,
della permissività che viene dalla società civile e che
si è diffusa tra noi. Hanno messo da parte il tesoro delle
regole, la priorità delle priorità non è
più la vita religiosa comunitaria, che è finita a pezzi,
ma la preoccupazione per la giustizia e la predilezione per i poveri.
Belli ideali che però corrono il rischio di ridursi a mere
parole e di essere irrealizzabili dalla gran parte”.
Un momento rivelatore della crisi della Compagnia, Tilliette lo individua in ciò che accadde dopo la morte del cardinale Jean Daniélou, nella casa parigina di una prostituta che egli aveva portato sulla soglia della conversione: “Qualcosa si è rotto
in me dopo la morte del cardinale Daniélou, quando la calunnia
circolò anche tra le file della Compagnia e l’atteggiamento dei
superiori fu impacciato e mediocre. Invece di volare in soccorso di un
confratello assassinato, si consumarono basse vendette. Fu allora che
dubitai del mio ordine, del suo discernimento, della sua
capacità d’essere solidale. Caddi dall’alto del mio ideale, come
Mallarmé. Prima del mio ingresso e nel tempo della mia
formazione, avevo un ideale molto alto della Compagnia, del suo spirito
di corpo, della sua solidarietà”.
Come professore di filosofia, prima negli istituti di formazione dei gesuiti, poi all’Institut Catholique di Parigi e infine alla Pontificia Università Gregoriana, Tilliette dice d’aver visto evaporare nella Compagnia anche il primato degli “intellettuali”: “Ho trascorso la mia
esistenza di gesuita negli incarichi tradizionali di direttore e
professore di collegio, di redattore di riviste e di scrittore, di
professore di università. Ho assunto questi compiti austeri
convinto che l’umanesimo gesuita sia primordiale e che gli
intellettuali siano la pupilla degli occhi della Compagnia. Invece pare
che oggi non sia più così e che si dia la preferenza ai
ministeri direttamente apostolici. Credo che si faccia di
necessità virtù: lo scarso reclutamento non permette di
mantenere un alto livello di studi e i superiori non dispongono di
soggetti in grado di coprire i vuoti man mano che si aprono. Da questo
punto di vista, il futuro della Compagnia è piuttosto oscuro. Si
chiudono le case e si relegano gli anziani in residenze dotate di
personale medico. Senza dubbio non c’è altra soluzione. Ma ci
piacerebbe che questo ripiegamento inevitabile non fosse accompagnato
da euforici discorsi di rito, che ricordano gli annunci di una
sconfitta in tempo di guerra”.
Tirando le somme, il quadro che tratteggia Tilliette sulla società contemporanea è oscuro, anche per il silenzio dei “superiori”: “Arrivato all’età in
cui si stendono le ombre sul cammino, sento il dovere di confessare una
delusione che condivido con molti. Sono cambiato infinitamente meno del
contesto vitale che mi circonda ed è una sofferenza sentirsi
sfasato, antimoderno e, peggio, complice, poiché l’influenza
dell’ambiente circostante è troppo forte. Non voglio incolpare
nessuno, ma in certi momenti è mancata una parola risoluta da
parte dei superiori. La mentalità materialista regna e si
estende senza essere contrastata dalla coscienza collettiva. Dio
è assente dai cuori. L’innocente e la vittima valgono meno del
colpevole. Una società che muove cielo e terra contro la pena di
morte e, nel medesimo tempo, giustifica e propaganda l’aborto libero,
è al punto più basso della scala della perversione”.
Ma la conclusione resta comunque fiduciosa, perché più che l’appartenenza alla Compagnia vale il servizio alla Chiesa: “La nostra epoca, una delle
più oscure della storia, vede tuttavia fiorire sacrifici
sublimi, eroismi, esempi di santità. Viene voglia di ripetere
con Gertrud von le Fort dopo la prima guerra mondiale: sola nel
disastro e nella rovina universale resiste la Chiesa. La santa Chiesa
cattolica, come un faro sulla collina. Che resta intatta nella sua
divina essenza anche quando i nostri peccati hanno macchiato il suo
nobile volto. La prima educazione mi inculcò l’amore e il
rispetto per la Chiesa, i suoi sacramenti, la sua liturgia, il rifugio
di misericordia, di orazione e di scienza che offre ai popoli del
mondo. La vita dei santi, l’esempio del padre de Lubac, la lettura
assidua di Claudel mi hanno insegnato a venerare la Chiesa, a
subordinare l’appartenenza alla Compagnia al servizio della Chiesa e
del papa, per il quale fu creata e che continua a restare la sua ragion
d’essere. Non la Compagnia come tale, ma alcuni gesuiti di tutte le
età devono fare un serio esame di coscienza. Il mio non è
certo tranquillizzante, e mi istruisco un processo ogni giorno. Ma non
credo di aver peccato intenzionalmente contro la luce”.
marzo 2019 |