 |
 |
| DANTE E I “FEDELI D’AMORE”
Ovvero: come si inventa una setta. Parte seconda 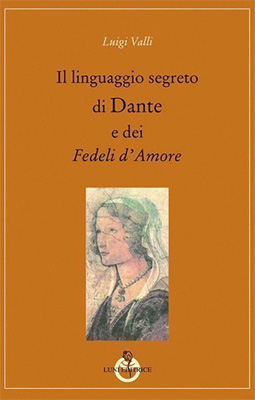 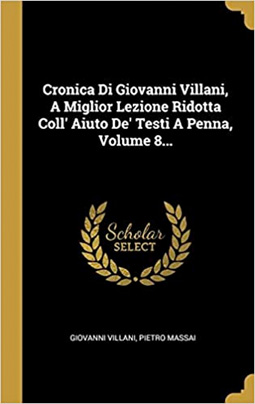 Eppure, Valli ne seguirà la rotta che il rosacroce Gabriel gli ha tracciato illuminandola con le sue idee. Vediamone alcune di queste. a - Per felice intuizione o perché lo avesse appreso dalla confraternita rosacruciana, Rossetti “ritenne” che la poesìa d’amore del Medioevo fosse soltanto un gergo convenzionale che, sotto l’aspetto amoroso, adombrava criptici messaggi di natura mistica o politica. Commento: ritenere
è un verbo che regge il congiuntivo, a significare l’incertezza
di quanto si afferma e, pertanto, tutto rimane una pia supposizione. Il
guaio è che, successivamente il nostro trasforma, in più
passaggi, il ritenuto nell’assodato.
Per ciò che attiene ai messaggi celati nelle poesie d’amore, è da dire che, quanto alla VitaNuova, ciò che vi emerge è l’insistenza con cui Dante scandisce il numero nove – 9 – multiplo di tre – 3 – con evidente richiamo alla SS Trinità e, pertanto, nessuna ambasciata occulta ma atto magisteriale, “catechistico”. È lo schema che seguirà nella redazione del suo capolavoro, la Commedia, concepita e composta sul ritmo del tre: tre cantiche, trentatré canti ciascuna, versi a terzine incatenate a esprimere l’essenza una-trina della Divinità con il finale significato della sua Unità dato dal canto iniziale con cui, aggiunto ai novantanove, forma cento – 100 – cifra riassumibile nell’1 (1 + 0 + 0 = 1). “Nella profonda e chiara sussistenza/dell’alto lume parvemi tre giri/di tre colori e d’una contenenza” (Par. XXXIII, 115/117), vale a dire: Trinità/Unità. Potremmo definire tale idealità col significato di eccelso, ardito, metafisico, trascendente ma non certamente come linguaggio coperto, settario e così delicato da gestire per il rischio di incappare nella rete della gente grossa o dell’Inquisizione. b – Queste idee potevano venir comunicate tra schiere di iniziati che si chiamavano appunto i “Fedeli d’Amore” e sfuggire in pari tempo alla “gente grossa” e all’Inquisizione che dovean vedere in quelle poesie nient’altro che sospiri e sentimenti amorosi. Commento: a dar fede al telegramma del Villani, gli “iniziati” dovrebbero essere quelle M = mille o più persone vestite di bianco che, così paludate e agli ordini del “signore d’Amore”,
mostrano chiaramente di costituire una congrega ben in vista, mettendo,
così stolidamente, sull’avviso, gli inquisitori.
Di poi, facendo un conto sbrigativo, questi mille individui, rappresentando una forte percentuale dei maschi fiorentini, il numero chiuso degli iniziati diventa, alla faccia della riservatezza, un numero aperto, il segreto di Pulcinella con il finale: “todos caballeros”! c – Le donne di questi Fedeli d’Amore, comunque si chiamino: Beatrice, Giovanna, Lagia, Selvaggia, esse sono una donna sola o, meglio, una sola idea. E come per traslato, indicando col nome di alcuna, si intende designare altro – per esempio, quando noi diciamo “Cristo ha vinto” vogliam intendere “ha vinto il Cristianesimo” – così, tale sotterfugio, nominando - che so – Beatrice, serviva per indicare, segretamente, la setta di appartenenza e di cui si protestavano fedeli. Commento: ci sembra sempliciotto siffatto meccanismo e facilmente decrittabile dal momento che, in primis, la sterminata congrega di iniziati è il ventre molle di tutto l’apparato segreto e, in secundis,
noto essendo il rapporto Beatrice/Dante, Giovanna/Cavalcanti,
Selvaggia/Cino, Lagia/Gianni, non pare còmpito arduo, al sentir
parlare di Beatrice, registrare la Commedia o il suo autore, quale oggetto del messaggio . . . cifrato.
d – Rossetti – riferisce Valli - raccolse potentissimi indizi per dimostrare l’esistenza di simile codice segreto ma, poi, sbagliò gravemente nel credere che questi Fedeli d’Amore fossero una setta ghibellina che praticava l’onesta dissimulazione in ambiente guelfo. Più tardi, Rossetti trasformò la setta ghibellina in una società segreta che riprendeva il culto iniziatico antico dei pitagorici calato nell’odio verso la Chiesa Cattolica. Commento:
come si possa costruire una struttura ideologica, quale quella dei
Fedeli d’Amore, fidandosi di un collezionista di sesquipedali
cappellate, è cosa da credere essere, della stessa pasta, colui
che ne denuncia gli scivoloni ma che, nello stesso tempo, ne esalta il
ruolo di iniziatore di un nuovo corso di studi. Tanto è vero
che, nel prosieguo del capitolo, Valli picchierà duro sulla
critica accademica ed estetica colpevole di obiettare alle fisime, alle
ubbìe del Rossetti il quale, pur dimostratosi un magliaro di
fama, era da considerare un caposcuola e non un orecchiante di esegesi
e di sapienza. Beh, se questo è il mentore di Valli, si capisce
perfettamente perché costui, nel séguito dell’opera abbia
partorito ridicoli ragionamenti di cui diamo un limitato e breve
catalogo ragionato onde dimostrarne il disutile scialo di tempo e di
energie mentali.
La prosa del Valli, così come quella di tanti specialisti dell’occulto, è erudita, zeppa di termini sub-liminali. espressa e veicolata mediante un lessico oracolare di fascino sottile sicché un lettore, che sia inesperto nauta, rischia un dolce naufragio in simile mare. A dimostrazione dell’uso disinvolto del metodo sopra definito “fai un’ipotesi e spacciala per certezza”, Valli tira cinque conclusioni di cui diamo conoscenza. 1 – “è vero che la poesìa dei Fedeli d’Amore – specialmente quella di Dante – e dei suoi più immediati predecessori. . . è scritta in un gergo segreto per il quale una trentina di parole almeno (!). . . hanno costantemente, oltre al significato apparente e riguardante materia d’amore, un secondo e talvolta anche un terzo significato convenzionale riguardante le idee di una dottrina iniziatica e la vita di un gruppo di iniziati”. Ecco alcune di tali parole: “amore, madonna, morte, vita, donne, folle e follìa, freddo, gaiezza, gravezza, noia, natura, piangere, pietra, rosa, fiore, fonte, saluto, selvaggio, vergogna”. Commento:
non ha fatto in tempo, a pagina 16, a formulare l’ipotesi
dell’esistenza, nella poesìa amorosa, di un linguaggio in
codice, che dopo una cavalcata di successive supposizioni, ti arriva a
pagina 24 dandotela per cosa certa, anzi, vera. Dante, poi, uno che
scrive in cifra coperta? Se così fosse, non si spiegherebbe
l’ordine che egli – per bocca del trisavolo Cacciaguida – si dà
allorché, in Paradiso, temendo di perdere stima a causa delle
cose narrate, con forte agrume, durante il viaggio ultraterreno,
così scrive: “Coscïenza
fusca o della propria o dell’altrui vergogna/pur sentirà la tua
parola brusca/Ma, nondimen, rimessa ogni menzogna/tutta tua visïon fa’ manifesta/e lascia pur grattar dov’è la rogna” (Par. XVII, 124/129). Se
fossero anche questi versi adombrati in codice non spiegheremmo la
condanna all’esilio e al rogo - irrogatagli, nel 1302, dal
podestà Cante de’ Gabrielli - che subì proprio per aver
parlato palam et non clam – apertamente e non in segreto.
2 – “è vero che tutte le donne del dolce stil novo sono in realtà una donna sola, e cioè la Sapienza santa, la quale nell’uso speciale del dolce stil novo prende convenzionalmente un nome diverso per ogni diverso amatore, e si chiama Beatrice per Dante, Giovanna per Guido Cavalcanti, Lagia per Lapo Gianni, Selvaggia per Cino. E poiché, come ho detto sopra, la dottrina coltivata da una setta e la setta stessa vengono confuse sotto la stessa designazione, queste donne servono anche a designare la setta dei Fedeli d’Amore”. Commento:
l’ipotesi che i nomi delle donne erano, per Rossetti la copertura di un
linguaggio segreto, diventa, qui, una verità inconfutabile.
Quanto all’identificazione del nome femminile con la dottrina dei
Fedeli d’Amore, notiamo un tentativo di una accomodatio allo scopo di far passare per liquida e ovvia l’affermazione.
Nella storia si contano centinaia e centinaia di dottrine che portano il nome del loro fondatore o il luogo dove esse sorgono: Cristianesimo, buddhismo, confucianesimo, zoroastrismo, luteranesimo, marcionismo, giansenismo, gallicanesimo, anglicanesimo, induismo, ecc, ma non ci risulta una dottrina che sostanzi la sua ragion d’essere nel beatricismo, nel giovannismo, nel lagiaismo o nel selvaggismo.
3 – “La Vita Nuova di Dante è scritta tutta in questo gergo: è tutta simbolica dalla prima all’ultima parola e riguarda la vita iniziatica di Dante e i suoi rapporti non già con la moglie di Simone de’ Bardi, ma con la Sapienza santa e con il gruppo che la coltivava”. Commento:
hai voglia, caro Valli, a disegnare un platonico quadro in cui figurano
Beatrice Portinari e Dante Alighieri, lei come Sophia e lui come
iniziato ché, alle lunghe, messer Simone de’ Bardi l’avrebbe
presa non troppo volentieri questa chiacchiera. Con ciò,
intendiamo definire sterile e monotono tale ritornello ché anche
degli immacolati e mistici stilnovisti, in qualche pausa-caffè,
avranno pur sentito, non diciamo bollente ma, comunque più che
tiepido il desiderio di scendere dall’empireo alla terza sfera, quella
di Venere. Crediamo fermamente, siffatto stile, un movimento a tre
tempi: un sentimento vero, un’accademia e un tentativo di “acchiappo”,
il tutto redatto in perfetta forma, scelto e raffinato lessico,
corredato da una sontuosa cornice retorica, strutturato in un metro
impeccabile.
Diversamente, come spiegheremmo il catalogo che vien fuori dalla conta delle donne “amate” dal Poeta? E, cioè: Beatrice (Vita Nuova e D.C.), la Donna Pietra (Rime petrose, IV), la Donna Gentile (V.N. XXXV – Convivio II, II, 1 - 2) e, poi, Gentucca (Pg. XXIV, 37), Lisetta (CV
– CXVII), Violetta (LVIII), Fioretta (LVI) e, infine Gemma Donati, la
moglie di cui Dante non parla per non coinvolgerla, pensiamo, nel
turbinìo di queste presenze femminili trasfigurate – ma non
troppo. . .
4 – “Le poesie più oscure dei Fedeli d’Amore e specialmente quelle canzoni di Dante. . . lette secondo il gergo, sciolgono la loro oscurità, si fanno di colori nuovi e acquistano una chiarezza, una coerenza, una profondità insospettate. . . con la conoscenza del significato segreto. . . si chiariscono agli occhi nostri. . . altre opere. . . come I Documenti d’amore, di Francesco da Barberino, l’Intelligenza di Dino Compagni, l’Acerba di Cecco d’Ascoli. . .” Commento:
Valli confonde un testo difficile con uno oscuro. Le Sacre Scritture,
ad esempio, la Divina Commedia o le poesie di Manzoni sono difficili e
pertanto vanno spiegate, commentate ma non perché siano avvolte
nel buio di un segreto ma, perché, i loro autori esprimono un
pensiero alto, non comune, adottando, per esso, un lessico raffinato,
raro e neologistico, figure retoriche, forme sintattiche, solenni,
aggettanti sul versante ebraico-greco latino. Ed infatti, da Boccaccio
in poi, la Divina Commedia è oggetto di commenti, di studi, di
indagini semiologiche, di convegni pertinenti al dispiegamento, ad
esempio, delle così dette “croci”, passi di complicato significato.
Soltanto i Foscolo, i Pascoli, i
Rossetti, i Valli, i Guénon, gli Asìn Palacios, i Manetti
e i molti della turba occulta ne vedono un inesistente lato oscuro
privandosi della luce che, dalle terzine – dome e incatenate – si
irradia con la vivida testimonianza cattolicissima della adamantina sua
Fede.
5 – “Queste poesie, una volta tradotte nel loro significato reale con la chiave del gergo, al posto di quell’amore vago, stilizzato, monotono, freddo, artefatto che mostrano quasi sempre secondo la lettera, ci rivelano una vita intensa e profonda d’amore per una mistica idea, ritenuta la vera essenza della rivelazione cattolica, di lotta per essa, contro la Chiesa carnale e corrotta, detta convenzionalmente “la Morte” o “la Pietra”, e dipinta come avversaria della setta dei “Fedeli d’Amore” e come occultatrice di quella Sapienza santa che i “Fedeli d’Amore” perseguono sotto la figura della donna”. Commento: c’è da sorridere di fronte a sì disinvolta tirata a danno della poesia, diciamo, di “superficie” e, per contro, di fronte a un turgido, commosso peana per quella, diciamo, di “profondità”
che ha bisogno, tuttavia, di essere liberata, con la chiave del gergo,
dalla scorza della lettera. E tutto risolvendosi in una lotta contro la
Chiesa Cattolica.
Caro fedele amoroso, non sembri
molto aggiornato in termini di lotta ché il tuo capo, ser
Durante Alighieri – noto come Dante – non ha bisogno di inveire contro la Chiesa
Cattolica - la sua Chiesa – ricorrendo al gergo, alla dissimulazione,
ai giochi verbali perché, se tu leggessi l’opera sua suprema,
quella Comedia, che ser Giovanni Boccaccio ha denominato “divina”,
troveresti molti passi in cui – ti preciso – strapazza, colpisce,
martella Papi, cardinali, frati condannandoli, chi all’inferno e chi al
purgatorio, uomini di chiesa e non la Chiesa in quanto realtà vivente e di istituzione divina.
Te ne fornisco alcuni: INFERNO – VII, 26/28 – X, 120 – XI, 8/9 – XV, 112/114 -XIX, 52/87 – XXII, 79/87 - XXIII, 103/108 – XXVII, 85/103 – XXXII, 124/139 – XXXIII, 118/120. Quanto al PURGATORIO non mette conto citarne il nome dacché, pur tra i tormenti non meno atroci degli infernali, essi sono felicemente destinati al PARADISO, nel quale, non mancano, invece, le invettive contro taluni delle quali ti indico la più aspra che il Poeta indirizza, per bocca di san Pietro, così come esplosa: “Quelli che usurpa, in terra, il loco mio/il loco mio, il loco mio che vaca/nella presenza del Figliuol di Dio/fatt’ha del cimiterio mio cloaca/del sangue e della puzza, onde ‘l perverso/che cadde di qua su, làgiù si placa ” (Par. XXVII, 22/27). In quanto alla Sapienza santa non c’è schermo femminile alcuno dacché il tuo capo la riconosce, e l’identifica, nella seconda Persona della SS Trinità, come, infatti, dichiara allorché, varcando il portone infernale, vi legge: “fecemi la divina Potestate/la Somma Sapienza e ‘l primo Amore”. A leggere con serena attenzione il passo della Vita Nuova, non si può, ex abrupto, essere colpiti da intuizioni paranormali poiché il proposito che Dante formula riguardo a un suo personale desiderio di inviare ai fedeli d’amore, quello che potremmo segnalare quale biglietto di augurî, si colloca sulla mera gestione dei rapporti tra amici, membri di una comitiva, di un’accademia, di una brigata, ma non troppi! ché il metterlo in atto sarebbe oneroso per chi amministra i collegamenti. Qualcuno potrebbe considerare, tale nostra, un’osservazione leggera da far entrare, a chi l’ascolta, da un orecchio e uscire dall’altro. Noi saremmo costretti a constatarne l’effettivo trapasso da un padiglione all’altro per mancanza, in colui, di materia grigia intermedia. Per ciò che concerne la Cronica del Villani non serve nemmeno una serena attenzione, palesandosi, l’evento descritto, come una delle tante manifestazioni festaiole funzionali a dare, della città promotrice, un’immagine di tutto rispetto, interessata a coniugare religiosità & commercio, divertimento & cultura, non escluso il “sollazzo” amoroso. Ora, che M persone o più vestano di bianco, non è cosa straordinaria dal momento che il M. E., come tutte, è l’epoca delle divise, degli apparati distintivi, dei colori. Non è, forse, la stessa organizzazione moderna che, per ogni sport, assegna una particolare livrea, che disegna costumi e divise per ogni settore delle FF. AA., che veste le varie associazioni di emblemi corrispondenti alle singole vocazioni? Non per questo ci metteremmo a indagare sopra un inesistente significato occulto, annidato nel costume, ad esempio, delle guardie svizzere pontificie, ma, tutt’al più, ci interesserebbe conoscere lo “stilista” che l’ha ideato, l’epoca, la funzionalità scenografica, ma non, ripetiamo, un’arcana intenzione. Certamente, si dànno tenute, divise di particolare significato che, talvolta, non è da sùbito compreso, ma ciò non vuol dire esoterico, occulto perché basta chiederlo a chi le indossa per esserne informati. E allora, ripetiamo: Fedeli d’Amore, catarismo, sodomia, esoterismo, alchimia, ghibellinismo, eresia, tossicodipendenza, ufologia, massoneria, sufismo, baratteria: tutte tematiche illustrate per dimostrare, apparentemente, i lati occulti della sua personalità ma, in verità, tutti tentativi concorrenti a demolirne un solo ed unico aspetto: l’essere, Dante Alighieri, uomo di integerrima Fede e di poderosa dottrina cattolica, persona che non sarà possibile farla precipitare dall’alto soglio dell’immortalità empirea perché è uno che “sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar de’ venti” (Pg. V, 14/15) (torna
su)
maggio 2022 |