 |
 |
| La “dualità” di Newmam o gli inizi del “Regno diviso” Parte seconda di Dardo Juan Calderón Parte prima Parte seconda Pubblicato su
https://catolicosribeiraopreto.com/a-dualidade-de-newman- ou-os-comecos-do-reino-dividido-parte-2/  Il cardinale John Henry Newman In Newman, la coscienza non è un triste contabile delle colpe. Egli la situa all’interno della creazione: quando Dio creò, pose la Legge del Suo Essere – che è lui stesso – nelle Sue creature. La coscienza ci presenta la verità ed è liberante; è messaggera di Dio. “Noi cattolici non siamo schiavi, nemmeno del Papa”, afferma Newman. Ma per Newman, questo carattere positivo non implica che dovremmo ignorare la voce del Papa, sebbene egli sottolinei in primo luogo “l’obbedienza dovuta alla voce divina che parla dentro di noi”. “Un cattolico inglese sarebbe un traditore di fronte al dilemma tra seguire il Papa o la propria coscienza?”, si chiede Newman, equiparando la coscienza al paese; e, a ben vedere, questa equivalenza è del tutto di gusto liberale e presuppone un paese che sia la somma delle coscienze individuali. E prende come esempio i deputati cattolici inglesi che cospirarono per impedire l’ammissione di un re di una dinastia cattolica proveniente da un altro paese (che Papa Pio IX costrinse a infrangere il giuramento). Quella grande fiducia nella bontà di Dio portò alla sorprendente conclusione, che tanto catturò l’attenzione dell’opinione pubblica inglese, che i cattolici avrebbero dovuto seguire la propria coscienza prima del Papa, impedendo così il tentativo dei Massoni di cancellarli dalla mappa. Un eroe in tutti i sensi, un eroe di una guerra reale con conseguenze concrete e preziose, un eroe la cui arma era stata la letteratura e che avrebbe potuto fermarsi lì. Ma andando oltre la presente congiuntura, l’attuale Catechismo della Chiesa Cattolica, per definire la coscienza, utilizza e cita questa lettera al Duca di Norfolk: “La coscienza è la messaggera... La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo” (CCC 1778). Con chi dovrebbe confrontarsi questa coscienza vicaria? Davanti al Vicario stesso? Lo hanno detto i Vicari stessi? Fatto è che tre anni dopo questa controversia, nel 1879, Padre Newman fu creato cardinale da Papa Leone XIII: era il prescelto per la politica di Ralliement in Inghilterra, visti i successi politici da lui ottenuti, ed era inoltre un uomo di fiducia di Roma. Ma Newman era uscito da un bivio politico salvando la testa, i beni e la posizione dei suoi, e aveva scritto letteratura polemica, mentre il tedesco ne aveva fatto una neoteologia. Bisogna tener conto – come dicevamo – che era inconcepibile per un inglese – cattolico o no – confrontarsi con “l’ordine costituito”, e bisognava trovare una via d’uscita. “L’uomo di lignaggio, con la rivoluzione, rischia solo la testa. Il piccolo borghese perderebbe tutto, perché dipende interamente dall’ordine costituito. Un ordine costituito che ama come se stesso, perché è il suo establishment” (di nuovo Bernanos; capisci perché la gente vota per Macri? [testo scritto nel 2018; gli esempi sono infiniti]). Newman ha forse appoggiato questa piroetta? Consideriamo questa bellissima frase: “Sento che Dio è dentro il mio cuore. Mi sento in sua presenza. Mi dice: fai questo, non fare quello. Puoi dirmi che questa prescrizione è solo una legge della mia natura, come lo sono la gioia o il dolore. Non riesco a capirla. No, è l'eco di una persona che mi parla. Niente mi convincerà che non provenga in ultima analisi da una persona esterna a me. Porta con sé la prova della sua origine divina. La mia natura prova un sentimento verso di essa come verso una persona. Quando le obbedisco, mi sento compiaciuto; quando disobbedisco, mi sento angosciato, come mi sento quando sono compiaciuto o offendo un amico venerato […] L'eco implica una voce; la voce si riferisce a una persona che parla. Amo e temo questa persona che parla” [i neretti sono miei]. La voce è dentro di me, ma è esterna; è la mia persona, ma è un'altra persona; alcuni hanno capito che dice espressamente che non proviene da Roma, che è precedente ad essa, ma in seguito arriveranno frasi più ortodosse che rimetteranno, in una specie di esplosione letteraria, le cose sul loro binario tradizionale e magistrale. Commentando questa frase, insieme all’altra del Cardinale che afferma che le “prove” dell’esistenza di Dio provenienti dal tomismo duro non lo lasciavano tranquillo, preferendo la propria prova nell’“esperienza della coscienza”, un autore afferma: “Questo passaggio molto denso riassume l’intero percorso dell’affermazione - a partire dall’autocoscienza e dal senso morale - del Dio personale e non di una mera legge o di un ‘qualcosa’, così che possiamo sintetizzare l’intera fenomenologia realista di Newman così: cogito ergo sum e conscientiam habeo, ergo Deus est.” (Roger Cheaib, Itinerarium cordis in Deum. Prospettive pre-logiche e meta-logiche per una mistagogia verso la fede alla luce di V. E. Frankl, M. Blondel e J. H. Newman, Editoriale Cittadella, Assisi 2012). E nessuno mi dica che il buon Roger stia travisando l’autore. Un certo signor Crosby scrive un lungo saggio per dimostrare che il personalismo ha origine in Newman, Maritain lo esprime poi in tutte le sue dimensioni e Wojtyla ne fa una dottrina magistrale (questo accadeva in URSS, paragonabile all’Inghilterra massonica, anche se alcuni non notano la somiglianza a causa della differenza tra i modali russo e inglese). Benedetto XVI, con un po’ più di consapevolezza del cambiamento teologico e non solo politico, intende salvare la pura soggettività: “La concezione di Newman della coscienza è diametralmente opposta (al puro soggettivismo). Per lui, ‘coscienza’ significa la capacità dell’uomo di conoscere la verità: la capacità di riconoscere, negli ambiti decisivi della sua esistenza – religione e morale – una verità, ‘la’ verità. La coscienza, la capacità dell’uomo di conoscere la verità, gli impone allo stesso tempo il dovere di andare verso la verità, di cercarla e di sottomettersi ad essa ovunque la trovi. La coscienza è capacità di verità e obbedienza alla verità, che si rivela all’uomo che cerca con cuore aperto. Il cammino di conversione di Newman è un cammino di coscienza, non un cammino di autoaffermazione della soggettività, ma, al contrario, di obbedienza alla verità che si è dispiegata passo dopo passo”. Dispiegata? Dove? Nella Chiesa e nel suo Magistero? O dentro di sé? O in quale luogo? E cadiamo nel circolo vizioso dell’immanenza che vuole sfuggire a se stessa e si morde la coda, tipico dei teologi tedeschi e protestanti. Un secolo dopo la controversia, l’opera di Newman continuava a destare interesse, ma non per un problema politico in Inghilterra, bensì per un problema teologico nella Chiesa, che si rifiutava di intenderla come era stata intesa fino ad allora. Un cardinale tedesco tenne una conferenza su “Newman e la coscienza” a Dallas nel 1978. Il cognome del cardinale era Ratzinger. La Provvidenza aveva deciso che i due cardinali si sarebbero incontrati a Birmingham. Non solo: la Provvidenza aveva deciso che il tedesco avrebbe rappresentato l’intera Chiesa e avrebbe posto, nel nome dell’inglese, il primato della coscienza sull’autorità del magistero, una coscienza che si formava nel mistero dell’immanenza e lanciava l’uomo verso la trascendenza, una piroetta che, come disse Rubén Calderón Bouchet, ricordava quell’attore comico – Buster Keaton – che si alzava da terra tirandosi le orecchie. Newman non ignorava il problema del superamento dell’immanenza nel suo concetto di coscienza, e così lo duplicò e diede alla Chiesa una certa influenza su di esso, in una seconda fase, non più come “formatrice” ma come “correttrice”. Ascoltiamo: “Quanto alla coscienza, per l'uomo ci sono due modi di seguirla. Nel primo, la coscienza forma solo una specie di intuizione fino al momento opportuno, una tendenza che raccomanda una cosa o l’altra. Nel secondo, è l’eco della voce di Dio. Tutto dipende da questa differenza. Il primo modo non è quello della fede; il secondo sì.” “La norma e la misura del dovere non è l’utilità, né la comodità, né la felicità del maggior numero, né la ragion di stato, né l’opportunità, né l’ordine, né il pulchrum. La coscienza non è un egoismo chiaroveggente, né il desiderio di essere coerenti con se stessi, ma il messaggero di Colui che, sia nel mondo della natura sia in quello della grazia, ci parla da dietro un velo e ci istruisce e governa attraverso i suoi rappresentanti. La coscienza è il “vicario originario di Cristo”, profetico nelle sue parole, sovrano nella sua perentorietà, sacerdotale nelle sue benedizioni e nei suoi anatemi; e se la Chiesa dovesse mai venir meno nel sacerdozio eterno, il principio sacerdotale rimarrebbe nella coscienza ed essa avrebbe il suo dominio” […] “Sono giunto alla conclusione che, in una vera filosofia, non c’è via di mezzo tra ateismo e cattolicesimo, e che una mente pienamente coerente, nelle circostanze in cui si trova quaggiù, deve abbracciare l’uno o l’altro. Eppure sono convinto di questo: sono cattolico in virtù della mia fede in Dio; e se qualcuno mi chiede perché credo in Dio, rispondo: perché credo in me stesso. Vedo che è, in effetti, impossibile credere nella mia stessa esistenza (e di questo fatto sono perfettamente certo) senza credere anche nell’esistenza di Colui che vive nella mia coscienza come un Essere Personale, che vede tutto, giudica tutto”… E poi, ecco la Chiesa e il magistero: Dio, secondo lui, non si è rivelato al mondo come un fatto storico (sebbene anche questo), ma principalmente come un’esperienza di coscienza, e la Chiesa non è la Testimone e la Custode di una Rivelazione di questo Dio che ci ha parlato attraverso la bocca degli uomini, ma la custode della coscienza che ha ricevuto la sua presenza: “…il sentimento del bene e del male, che nella religione è il primo elemento, è così delicato, così irregolare, così facile da confondere, da oscurare, da pervertire, così sottile nei suoi metodi di ragionamento, così malleabile dall’educazione, così influenzato dall’orgoglio e dalle passioni, così instabile nel suo corso che, nella lotta per l’esistenza, tra i molteplici esercizi e trionfi della mente umana, questo sentimento è allo stesso tempo il più grande e il più oscuro dei maestri; e la Chiesa, il Papa, la gerarchia costituiscono, nella divina Provvidenza, la risposta a un bisogno urgente.” Un altro autore ci dice, e non possiamo accusarlo di falsa interpretazione: «Newman ha sempre affermato pienamente la dignità della coscienza soggettiva, senza mai deviare dalla verità oggettiva. Non diceva: coscienza sì – Dio o la fede o la Chiesa no; ma piuttosto: coscienza sì – e proprio per questo motivo, Dio e la fede e la Chiesa sì. La coscienza è l’avvocatessa della verità nei nostri cuori; è ‘il vicario originario di Cristo’» (ERMANN GEISSLER). Senza forzare, vediamo i modernisti trovare nel pensiero di Newman tutti gli spunti che fanno ambigua – ma eretica – la sua dottrina; infatti, i suoi seguaci furono Loisy (un ritratto di Newman era appeso sul suo letto di morte), Tyrrel, Von Huegen e Guitton. Paolo VI disse che un giorno i posteri si sarebbero resi conto che il Concilio Vaticano II si era ispirato a lui. Potremmo anche passare giorni a citare frasi del tutto ortodosse, anche se (come ho detto prima) non più in tono letterario, ma come un’esplosione di stile, come una sorta di freno che i credenti applicano spesso quando la loro immaginazione si scatena. Qualcuno potrebbe dire: “Non capisco la monogamia; la poligamia mi piace di più, ma accetto con fatica ciò che il Magistero della Chiesa mi dice e vi aderisco con tutto il cuore”. E questo è davvero notevole in Newman, finalmente convertito, ma convertito suo malgrado. E così come ci furono lamentele a Roma (a San Pio X) da parte dei suoi pari e contemporanei sulla pericolosità delle sue dottrine (Monsignor O’Dwyer, Vescovo di Limerick), San Pio X lo difende in una lettera che diceva più o meno così (era in latino e non riesco a trovarla): “… nonostante certe incongruenze, la sua fede non può essere messa in dubbio” (1). E sono d’accordo – anche se il dubbio mi urla contro: se il Santo lo ha detto, lo accetto con la stessa disponibilità con cui Newman accettò il Sillabo. I modernisti nascondono questa accettazione dell’ortodossia? No, in genere no, ma celebrano la “dualità” di Newman (Crosby lo sottolinea in particolare) come una nota di angoscia esistenzialista. Eppure – molto di traverso – altri insinuano che si trattasse di affermazioni inserite qua e là per evitare la condanna e da utilizzare in caso di inquisizione di fronte alle accuse dei loro pari, e che quindi andrebbero ignorate; e questo sospetto si basa sul cambiamento di stile quando l’autore vi ricorre. Newman proveniva da un ambiente liberale e si era veramente convertito. Si aggrappava agli insegnamenti con le mani rugose di un cattolico appena arrivato (un insegnamento che a suo tempo condannava chiaramente e risonantemente il liberalismo, e lui lo accettava), ma continuava a respirare attraverso i pori la sua formazione e lo spirito della sua terra natale, che emergeva in lui come uomo di lettere. Questa dualità, che egli stesso sperimenta e che conduce al passaggio da Oxford al cattolicesimo, e che sono le sue “due coscienze”, quella che cerca il bene carnale, per quanto eccellente, e la coscienza della “verità”, piena di scorie, che ha bisogno della disciplina della Chiesa per emendarsi e correggersi. E nel suo caso, questo è senza dubbio ciò di cui ha bisogno, perché non può “formarsi” in essa, né conformarsi ad essa completamente. Per lui, la Chiesa è una verga dura e necessaria a cui legarsi per guidare l’albero contorto – ma nobile – della nostra personalità. Ma non vediamo questa idea serenamente cattolica secondo cui la Chiesa è l’Albero stesso da cui nasciamo e della cui linfa ci nutriamo. Concludiamo per ora: la teologia non si fa al di fuori della Chiesa e del suo Magistero. Non si fa con De Maistre e il suo ostacolo dialettico e martiniano – il suo passato massonico – che prevede una rigenerazione storica dopo la punizione rivoluzionaria con un certo sapore millenarista (Monsignor Delassus cade un po’ in questa tentazione per ammirazione del personaggio – immaginate se vedesse il Vaticano un secolo dopo, in cui supponeva una restaurazione! E questo sogno include la TFP e Roberto de Mattei. Né si fa con Blanc de Saint Bonnet e il suo passato sansimoniano. La teologia non si fa con Maurras o Péguy per i loro antecedenti, né si fa con molti altri nostri eroi controrivoluzionari. Con loro si fa la politica, la storia o la letteratura. (Ho letto molti parlare di un Mons. Lefebvre “maurrasiano” quando lo stesso Vescovo – riconoscendo i successi del francese – confessò di non aver letto una sola sua opera. La dottrina del buon Monsignore era il Magistero della Chiesa e Maurras si stava dedicando ad essa. Questa è tutta la coincidenza). Non si fa teologia con Newman. Nella sua opera su Monsignor Delassus, Louis Medler ci dice che «questi autori, la cui evoluzione (verso il cattolicesimo) dura tutta la vita, meritano di essere studiati, ma non possono essere considerati veri maestri, perché il maestro richiede una stabilità nella verità che permetta al discepolo di studiare con piena fiducia», e questa stabilità si realizza all’interno della Chiesa cattolica, nel suo Magistero, che raggiunge la sua massima espressione nella teologia di San Tommaso. Ma, naturalmente, questi maestri hanno la spiacevole abitudine di avere sempre ragione, e non presentano quegli “aspetti umani” così attraenti per noi, che troviamo in loro simili amori e risentimenti, vizi e virtù, e ne apprezziamo gli “stili”. Ed essi hanno ragione non perché abbiano ragione in sé, perché nemmeno quei “Padri della Chiesa” che Newman ammirava tanto e tramite i quali trovò la sua conversione al cattolicesimo – e con i quali, purtroppo, rimase – sono infallibili se considerati separatamente dall’intero corso del Magistero (come, seguendoli, molti credono oggi). Più vicini a noi ci sono maestri come un Cardinale Pie, un Pio X, un Monsignor Lefebvre, un Monsignor de Castro Mayer in Brasile, e includerei in questa serie persino un Meinvielle in Argentina (con minime precauzioni). Quegli altri, esperti del nemico, denunciatori di macchinazioni settarie, combattenti diretti contro la cospirazione, pubblicisti e polemisti che hanno resistito all’assalto, e furono persino vittime della confusione; meritano il nostro amore, la nostra gratitudine, la nostra comprensione, le nostre preghiere e la nostra cura. Perché, come ha giustamente detto Bernanos, per comprendere i nostri tempi, preparati in battaglie passate, non è utile parlare con i vivi, ma con i morti. Digressione: Newman è molto caro e si adatta perfettamente a noi, che viviamo situazioni simili. In realtà, non vogliamo riconoscere che per un secolo l’unico vero modo di essere cattolici è stato una sorta di martirio, essere in lotta – o almeno non collaborare – con la Bestia che governa il mondo attraverso una politica atea, laica e anticristiana. Significa essere contro l’Ordine Costituito ed essere disposti a perdere tutto. E Newman, da buon direttore spirituale, aveva cercato un modo per non chiederci nulla se non quel poco che, sempre meno, siamo disposti a dare. Un argomento che giustifichi questo modo miserabile di essere cattolici, per non aver perso tutto in Vandea, per non essere stati uccisi in Messico come Cristeros, per non essere stati massacrati in Spagna nel secolo scorso, per non essere stati relegati alla solitudine e al disprezzo come Calmel e tanti altri bravi sacerdoti, per non essere stati come Genta o Sacheri, non può essere un argomento “elegante”. Il più accettabile sarebbe una nobile povertà e un distacco, un ritiro sacrificale, ma ciò che è più caratteristico di noi è semplicemente che siamo “miserabili” e quindi andiamo a malincuore, come il Cireneo, in ginocchio davanti alla Croce. Newman sapeva come conferire a questa condizione una patina artificiale di invecchiamento e di stucco, che non è né tradizione né gloria, e a cui i cattolici del nostro tempo si aggrappano disperatamente, trasformando un’uscita tempestiva e vergognosa in uno stile di vita lodevole. NOTA 1 - “Vi informiamo che il vostro saggio, in cui avete dimostrato che gli scritti del Cardinale Newman, lungi dall’essere in contrasto con la Nostra Lettera Enciclica Pascendi, sono, al contrario, in piena armonia con essa, è stato da Noi enfaticamente approvato: poiché non avreste potuto servire meglio sia la verità che la dignità dell’uomo. È evidente che coloro i cui errori condanniamo in questo Documento hanno deciso tra loro di creare qualcosa di loro invenzione, con cui hanno cercato di attribuire alla loro causa l’approvazione di una persona illustre. Così, ovunque affermano con sicurezza di aver tratto queste cose dalla stessa fonte e dal vertice dell’autorità, e che, pertanto, non potevamo censurare i loro insegnamenti; al contrario, affermano che Noi avevamo già precedentemente condannato ciò che un così grande autore aveva insegnato.” (San Pio X, Lettera a Mons. Edward Thomas, Vescovo di Limerick, 10 marzo 1908. Fonte: Actas Sactae Sedis, vol. XLI, 1908, pp. 200-202. NOTIZIA
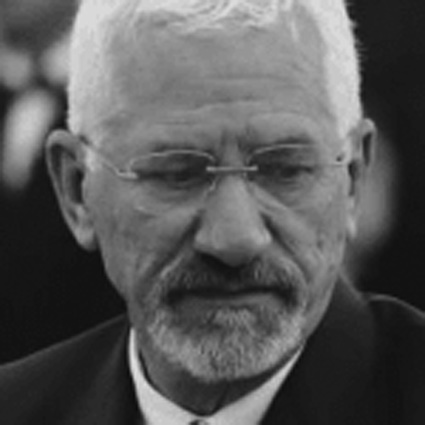 Dardo Juan Calderón DARDO JUAN CALDERÓN, è avvocato, esercita nel foro della Provincia di Mendoza, Argentina, dove è nato nel 1958. Laureato presso l’Università di Mendoza, è padre di una famiglia numerosa. Alterna l’esercizio della professione con una copiosa produzione di articoli cartacei ed elettronici, con stile polemico e critico, aderendo al pensiero cattolico tradizionale. |