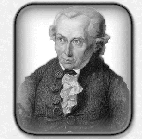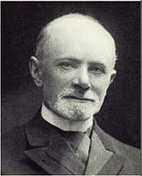|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
LA“PASCENDI” NON É INVECCHIATA 1907 - 2007
Pubblichiamo un articolo di Don Jean-Michel Gleize
(le sottolineature e i rimandi sono nostri) Sull'argomento si vedano anche:
Il modernismo di ieri condannato da San Pio X Il modernismo odierno, adottato dal Vaticano II Breve esame critico della Lumen Gentium, n° 8 Il n° 8 della Lumen Gentium Il n° 8 alla prova dei fatti Costanti e variazioni del modernismo
Esso si potrebbe paragonare anche ad un camaleonte, che possiede la capacità di cambiare il colore della pelle in funzione dell’ambiente in cui si trova. Questa caratteristica gli permette di dare l’impressione che sia cambiato, mentre in realtà è rimasto lo stesso. Questo secondo paragone ci permette di comprendere perché l’analisi di San Pio X conserva ad oggi tutta la sua attualità. Gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, infatti, hanno mutato il colore del modernismo senza cambiarne la natura profonda. Il principio primo di questo modernismo analizzato da
San Pio X è duplice.
Il problema è, allora, di mantenere e dunque di trasmettere la fede e la rivelazione. Occorre assicurare la permanenza del vissuto grazie alla Tradizione e alla Chiesa. Per comunicare l’esperienza occorre viverla insieme. La Chiesa, che è questo vissuto collettivo, è definita come " il frutto della coscienza collettiva ". Questa esperienza vissuta in comune dà vita alla tradizione vivente, cioè alla serie, continua nel tempo, delle esperienze religiose fatte in comune. Ne deriva che la costituzione della Chiesa non è più quella di una società monarchica, ma quella di una comunione o di un governo democratico, in cui l’autorità diviene il portavoce della comunità. Da ciò deriva anche un relativismo unico nel suo genere: tutte le religioni sono più o meno vere. Dal momento che la religione sarebbe la comunicazione di una esperienza, la migliore religione, e dunque la più vera, sarà quella in cui la comunicazione corrisponde meglio ai bisogni della coscienza umana e meglio perdura. Questa religione esiste: è il cattolicesimo, la religione che in fondo è solo più vera delle altre, mentre le altre, corrispondendo più o meno a questi bisogni, rimangono buone e legittime. Il modernismo, dunque, può riassumersi in tre
grandi postulati: la fede e la rivelazione consistono nel vivere un’esperienza;
la Chiesa è la comunione di coloro che vivono questa esperienza;
il cattolicesimo è solo il coronamento o la pienezza de questa esperienza.
Il modernismo odierno,
adottato dal Vaticano II:
Modernisti e tradizionalisti: i principi base del dialogo. Come in tutte le cose è importante determinare il metodo da seguire. In effetti, dice San Tommaso, colui che avanza zoppicando lungo la via, anche se progredisce poco si avvicina comunque alla meta. Colui che invece cammina fuori dalla via si allontana dalla meta tanto più presto per quanto avanza spedito (2). Ora, il metodo non è proprio lo stesso quando si
studiano dei testi ortodossi o eterodossi.
Per capirci ricordiamo che il fondamento della prima regola
è la fragilità umana.
Quando i passi eterodossi sono frequenti o anche abituali non si tratta più di lapsus o inavvertenza dovute alla fragilità umana, quindi la prima regola non può più applicarsi. " I testi ortodossi, non solo perdono il loro significato favorevole, ma diventano anche causa di un ulteriore e grave motivo di sospetto " (5) . La cosa non deve stupire: il falso è privazione del vero, esattamente come il male è privazione del bene, tale che l’eresia suppone per definizione una certa parte di ortodossia, di cui ha bisogno per poter sopravvivere in quanto privazione. " I passi apparentemente ortodossi rappresentano allora sia una incoerenza e una debolezza dell’autore, che conserva per abitudine degli elementi estranei al suo sistema, sia una volontà positiva di dissimulare l’equivoco, di camuffare l’errore, di annegare la perfidia in una pietosa caligine " (6) . Il Papa San Pio X, nella Pascendi, al n° 4,
denuncia questa attitudine dei modernisti dicendo che usano la tattica
di " presentare le loro dottrine non già coordinate e raccolte
quasi in un tutto, ma sparse invece e disgiunte l'una dall'altra
". Questo, aggiunge il Papa, " allo scopo di passare essi per dubbiosi
e come incerti, mentre di fatto sono fermi e determinati ". Al n°
20, San Pio X precisa ancora: " Negli scritti e nei discorsi sembrano
essi non rare volte sostenere ora una dottrina ora un'altra, talché
si è facilmente indotti a giudicarli vaghi ed incerti. Ma tutto
ciò è fatto avvisatamente; per l'opinione cioè che
sostengono della mutua separazione della fede e della scienza. Quindi avviene
che nei loro libri si incontrano cose che ben direbbe un cattolico; ma,
al voltar della pagina, si trovano altre che si stimerebbero dettate da
un razionalista ".
Un testo avulso dal suo contesto diventa un pretesto… Per sfuggire a tale pretesto è indispensabile collocare ed esaminare il n° 8 della Lumen Gentium in funzione dei numeri precedenti. L’insieme di questi numeri, infatti, dal primo all’ottavo, mostra chiaramente che, lungi dall’essere fortuite, le affermazioni equivoche, incomplete o sospette, sono continue. Il metodo d’esame auspicato prima si impone dunque da sé stesso. La Chiesa è la vera società soprannaturale
visibile che riunisce tutti coloro che, battezzati, professano la stessa
fede e sono sottomessi all’autorità del Sovrano Pontefice, vescovo
di Roma. L’unità della Chiesa visibile in questa terra è
ordinata ad un’altra unità: quella della Comunione dei Santi. Questa
Comunione mistica ed invisibile comincia qui in basso, ove riunisce, col
legame della carità, tutti i giusti in stato di grazia; essa trova
il suo compimento nella Chiesa trionfante del cielo, ove i beati vedono
Dio faccia a faccia. Quaggiù la Comunione dei Santi è distinta
dalla Chiesa militante, poiché in questa vi sono degli uomini peccatori
e fuori di questa si possono trovare, in modo straordinario, certe ànime
in stato di grazia (7).
E vi è un ordine ben marcato tra la Comunione mistica dei Santi
e la Chiesa visibile, poiché quella procede da questa: la società
visibile è prima in rapporto alla Comunione mistica e ne permette
l’accesso. Vediamo adesso cosa ne è di questo insegnamento nel Vaticano
II, con la costituzione Lumen Gentium.
Breve sguardo dal n° 1 al 7 Il Concilio Vaticano II ha voluto dare una nuova definizione della Chiesa. Il testo della Lumen Gentium si apre con un prologo (n° 1) che dichiara l’intenzione del Concilio nel quadro preciso di questa costituzione dogmatica sulla Chiesa: " E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale ". La difficoltà non sta nell’oggetto di questa intenzione;
il testo dice semplicemente che la costituzione De Ecclesia tratterà
della natura e della missione della Chiesa, cosa che è lapalissiana.
La difficoltà nasce dall’inciso causale: " Cum autem…", cioè
" E siccome la Chiesa è…". Ecco un modo di esprimersi
sconcertante: non si enuncia palesemente una definizione chiara e netta,
si dice per inciso che, essendo tale, la Chiesa parlerà di sé
stessa. Per un verso non si capisce bene in che consista questo legame
di causa ed effetto, per l’altro è alquanto sconcertante che questa
espressione presupponga come già conosciuta e ammessa dai lettori
la
definizione della Chiesa sacramento. Nessuna spiegazione, nessuna giustificazione
tratta dalle fonti della Rivelazione viene richiamata a sostegno di questa
affermazione, la quale viene presentata ex abrupto
come cosa
automatica mentre invece è una novità assolutamente inaudita
in un testo del magistero. E dopo aver fatto ingoiare questa pillola
senza tante formalità, il testo vi farà subito riferimento
come fosse un dato assolutamente incontestabile.
A partire dal n° 2, il capitolo I della Lumen Gentium descrive le origini della Chiesa. Il n° 2 parla del mistero della Redenzione come presente
dall’eternità nell’intenzione di Dio. "Tutti infatti quelli che
ha scelto, il Padre fino dall'eternità “li ha distinti e li ha predestinati
a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia
il primogenito tra molti fratelli ”. I credenti in Cristo, li ha voluti
chiamare a formare la santa Chiesa, la quale, già annunciata in
figure sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia
del popolo d'Israele e nell'antica Alleanza, stabilita infine “ negli ultimi
tempi “, è stata manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà
glorioso compimento alla fine dei secoli ".
Il n° 3 tratta dell’opera redentrice di Cristo e della fondazione della Chiesa, e vi si ritrovano le stesse lacune, ancora più accentuate. Da un lato, la Redenzione non è sempre definita chiaramente: è detto infatti che " Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di lui, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione ". Dall’altro lato, si fa allusione ad un aspetto visibile della Chiesa, quando si dice che " La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero " ? dunque la realtà mistica e invisibile presentata al n° 2 - , " per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo ". Ma non si precisa in che consista questa visibilità: è una visibilità formale ed intrinseca, quella di una cosa evidente in sé stessa, o è una visibilità estrinseca, quella di una cosa che è oggetto di fede, ma la cui esistenza è attestata da dei segni, dei motivi di credibilità ? Sembra proprio che quella corretta sia la seconda ipotesi, poiché il seguito di questo n° 3 vi si riallaccia affermando che l’origine e la crescita della Chiesa " sono simboleggiati" e " sono annunciati ": la Chiesa è una realtà formalmente invisibile e mistica e si può dire (per denominazione estrinseca) che il suo mistero opera una crescita visibile perché è significata e annunciata. Questa impressione è rafforzata alla fine di questo n° 3, poiché vi si dice che l’unità dei fedeli è " rappresentata ed effettuata " col " sacramento del pane eucaristico ". Il n° 4 espone l’azione dello Spirito Santo nella
Chiesa. Ed è qui, nella transizione che si effettua senza alcuna
precisazione tra il n° 3 e il n° 4 che si trova la lacuna più
grave e, indubbiamente, l’indizio che svela meglio il senso nascosto di
questo capitolo I. Si passa subito dall’opera redentrice (mal definita)
di Cristo all’azione mistica dello Spirito Santo nella Chiesa, senza aver
minimamente richiamato la fondazione di una società visibile e gerarchica
da parte di Cristo in quanto uomo.
Vi si dice, infatti, che " Compiuta l'opera che il
Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, il giorno di Pentecoste fu
inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa e affinché
i credenti avessero così attraverso Cristo accesso al Padre in un
solo Spirito ". E si afferma esplicitamente che la vita ecclesiale
è il frutto diretto e immediato di questa azione dello Spirito Santo:
" Questi è lo Spirito che dà la vita, una sorgente di
acqua zampillante fino alla vita eterna; per mezzo suo il Padre ridà
la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno risusciterà
in Cristo i loro corpi mortali. Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori
dei fedeli come in un tempio e in essi prega e rende testimonianza della
loro condizione di figli di Dio per adozione ".
Secondo questi tre passi dei nn° 2-4 della Lumen Gentium, la Chiesa è l’opera comune delle tre Persone divine. Il Padre ha predestinato tutti gli uomini nella e per la Chiesa. Con l’esempio della sua obbedienza e la rivelazione del suo mistero, Cristo (Agisce in quanto Dio o in quanto uomo ? Il testo non lo precisa.) ha suscitato un regno, cioè una comunione mistica. Lo Spirito Santo continua a suscitarla e vi aggiunge il dono della gerarchia visibile, che sta a significare il mistero di questa comunione. I nn° 5 e 7 confermano questo significato. Il n°
5 evoca la fondazione della Chiesa da parte di Cristo senza fare alcuna
allusione all’istituzione formale di una gerarchia visibile: non si parla
nemmeno una volta del primato di San Pietro. Il n° 6 elenca le diverse
espressioni metaforiche con le quali il testo sacro indica la Chiesa. Infine
il n° 7 parla della Chiesa corpo mistico di Cristo come di una comunità
spirituale ove tutti e ciascuno sono collegati al loro capo grazie allo
Spirito. Vi è solo una allusione ai ministeri, grazie ai quali noi
ci rendiamo un mutuo servizio per la salvezza. Anche qui non si parla affatto
di un legame di dipendenza gerarchica.
La prima parte La prima parte di questo numero indica nuovamente lo stesso
rapporto che abbiamo già notato al n° 3. Lì si diceva
che " La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero,
per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo ". Il n° 8
precisa: " Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente
sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di
carità, quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per
tutti la verità e la grazia ". Si ricorda la distinzione che
esiste tra la comunità mistica da un lato e la struttura visibile
dall’altro. Si dice che questa distinzione è opera di Cristo, senza
precisare se si tratti di Cristo in quando uomo o di Cristo in quanto Dio;
e trattandosi di Cristo in quanto uomo non si precisa se è Cristo
in terra prima dell’Ascensione o Cristo glorioso che invia il suo Spirito
dall’alto dei cieli. Ma sono i nn° 3 e 4 a esprimersi logicamente per
questa seconda soluzione.
E si paragona questa distinzione a quella che esiste tra l’umanità e la divinità del Verbo incarnato. In entrambi i casi si distingue tra lo strumento e chi lo usa. La struttura gerarchica è lo strumento della comunità, e siccome chi utilizza lo strumento per ciò stesso lo precede, la divinità di Cristo precede la sua umanità e la comunità mistica precede la struttura gerarchica. La seconda parte " Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida e costituì per sempre “colonna e sostegno della verità”. Questa Chiesa [di Cristo], in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica ". La seconda parte di questo numero comprende il famoso passo del " subsistit in", con la distinzione tra la Chiesa di Cristo e la Chiesa Cattolica. Il significato di questo passo si chiarisce da sé alla luce del suo contesto. L’espressione " subsistit in " indica la distinzione tra la comunità spirituale da un lato e la struttura visibile e gerarchica dall’altro. Nella realtà le due non sono mai separate, ma l’una non è formalmente l’altra e tra le due vi è un ordine, poiché la comunità precede la struttura. Per insistere sulla distinzione si aggiunge anche che la comunità può essere " presente e agente " (10) al di fuori della struttura gerarchica e visibile. Si tratta del passo che serve da punto di partenza all’ecumenismo. Elementi della Chiesa di Cristo esistono indipendentemente dalla struttura visibile della Chiesa cattolica. Su questo punto, le recenti Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa del 29 giugno 2007 completano il n° 8 della Lumen Gentium, precisando che questi elementi della Chiesa di Cristo (" Elementa Ecclesiae ") sono parte essenziale delle sette, scismatiche o eretiche. Non bisogna dimenticare, però, che questa precisazione non è nuova. Il testo della Sacra Congregazione, infatti, nella nota 8, fa riferimento a tre precedenti interventi dell’organo della Santa Sede: del 1973 (11), 1985 (12) e 2000 (13). Questi tre documenti, in sostanza, dicevano già la stessa cosa che è detta in questo quarto documento appena uscito. Anche a volerlo considerare di per sé, avulso dal
suo contesto, il testo della Lumen gentium si presenta sempre ambiguo.
L’interpretazione autentica del testo del n° 8 della Lumen gentium, dal 1973 al 2007 1973 Il testo del 1973 è indubitabile: " Questa dichiarazione del Concilio Vaticano II trova la sua spiegazione nel Concilio stesso. In esso infatti si dice che “ solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è il mezzo generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza ” (Decreto Unitatis redintegratio, n° 3), e questa Chiesa cattolica è “ stata arricchita di tutta la verità rivelata da Dio e di tutti i mezzi della grazia” (Ibidem, n° 4) con cui Cristo ha voluto colmare la sua comunità messianica. Ma questo non impedisce che […] “ al di fuori del suo organismo”, in particolare nelle Chiese e comunità ecclesiali ad essa unite con una comunione imperfetta, “si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica” (Lumen gentium, n° 8). Stando così le cose, “ è necessario che i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano presso i fratelli da noi separati.” (Decreto Unitatis redintegratio, n° 4); ed abbiano a cuore la restaurazione dell’unità dei cristiani con un comune sforzo di purificazione e di rinnovamento (Decreto Unitatis redintegratio, n° 6-8), affinché si compia la volontà di Cristo e i cristiani cessino di ostacolare, con le loro divisioni, la proclamazione del Vangelo nel mondo (Decreto Unitatis redintegratio, n° 1). Tuttavia, questi stessi cattolici devono confessare che, per effetto della misericordia divina, essi appartengono alla Chiesa che Cristo ha fondato e che è diretta dai successori di Pietro e degli altri Apostoli, nelle cui mani restano intere e viventi le istituzioni e la dottrina della comunità cattolica primitiva, patrimonio di verità e di santità che durerà per sempre nella loro Chiesa. Di modo che non è affatto permesso ai fedeli di immaginare che la Chiesa di Cristo sia semplicemente un insieme - diviso, certo, ma conservante ancora qualche unità - di Chiese e di comunità ecclesiali; né essi hanno il diritto di ritenere che questa Chiesa di Cristo oggi non sussista più in alcun luogo, così che bisognerebbe considerarla solo un fine da perseguire da parte di tutte le Chiese e comunità. " Vi è detto tutto, e Benedetto XVI arriverà troppo tardi, dopo Paolo VI. In breve, vi sono, più o meno, degli elementi di Chiesa al di fuori della Chiesa. Un po’ come vi sarebbero degli elementi di emmental nei buchi dell’emmental (N. B.: Contrariamente a quanto contenuto nell’idea quasi unanimemente accettata in Francia, al contrario dell’emmental, la gruviera non ha i buchi). 1985 Il testo del 1985 continua sullo stesso tono. Esso ricorda che il Concilio Vaticano II ha scelto il termine " subsistit " " proprio per mettere in luce che esiste una sola sussistenza della vera Chiesa, mentre al di fuori del suo insieme visibile esistono solo degli “elementa Ecclesiae”, i quali - essendo degli elementi della stessa Chiesa - tendono e conducono verso la Chiesa cattolica ". Traduciamo: in concreto, la Chiesa esiste in una sola maniera, nella struttura visibile del cattolicesimo, mentre al di fuori di questa struttura vi sono solo degli elementi della Chiesa. Questo testo è particolarmente interessante perché venne citato e commentato, quindici anni dopo, dal Cardinale Ratzinger in persona, in una conferenza del febbraio 2000 sull’ecclesiologia della Lumen gentium(14). Citando il documento del 1985, il Cardinale Ratzinger ricorda che la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva " preso posizione " sul discusso passo della Lumen gentium n° 8 a causa della tesi sostenuta dal padre Leonardo Boff. Secondo quest’ultimo (che sembra riprendere pari pari le idee di Alfred Loisy) Cristo non ha costituito alcuna istituzione visibile. " Nessuna Chiesa istituzionale potrebbe quindi affermare di essere quell'una Chiesa di Gesù Cristo voluta da Dio stesso; tutte le configurazioni istituzionali sono quindi nate da necessità sociologiche e pertanto come tali sono tutte costruzioni umane, che si possono o addirittura si devono anche nuovamente radicalmente mutare in nuove circostanze. Nella loro qualità teologica si differenziano in modo molto secondario, e pertanto si potrebbe dire che in tutte o in ogni caso almeno in molte sussiste l' “unica Chiesa di Cristo” - a proposito della quale ipotesi sorge naturalmente la domanda con che diritto in una tale visione si possa semplicemente parlare di un'unica Chiesa di Cristo " (15) . Per il Cardinale Ratzinger una simile interpretazione del Concilio è da riprovare. La critica della ecclesiologia relativista è
dunque evidente, ma essa si autodistrugge strada facendo, poiché
riconosce degli elementa Ecclesiae al di fuori dei limiti
visibili della Chiesa cattolica romana, elementa che per sé stessi
tendono verso la Chiesa di Cristo. Il che è già troppo, poiché
equivale a professare il relativismo che si condanna… e significa contraddire
l’insegnamento della Rivelazione su un articolo decisivo, poiché
riguarda il fondamento stesso della fede cattolica.
2000 Il testo del 2000 (ai nn° 16 e 17) (16) non comporta alcun cambiamento nell’esegesi del testo base della Lumengentium. Il n° 16 - " Perciò, in connessione con l'unicità e l'universalità della mediazione salvifica di Gesù Cristo, deve essere fermamente creduta come verità di fede cattolica l'unicità della Chiesa da lui fondata. Così come c'è un solo Cristo, esiste un solo suo Corpo, una sola sua Sposa: “una sola Chiesa cattolica e apostolica”. Inoltre, le promesse del Signore di non abbandonare mai la sua Chiesa (cf. Mt 16,18; 28,20) e di guidarla con il suo Spirito (cf. Gv 16,13) comportano che, secondo la fede cattolica, l'unicità e l'unità, come tutto quanto appartiene all'integrità della Chiesa, non verranno mai a mancare. I fedeli sono tenuti a professare che esiste una continuità storica, radicata nella successione apostolica, tra la Chiesa fondata da Cristo e la Chiesa Cattolica: “È questa l'unica Chiesa di Cristo [...] che il Salvatore nostro, dopo la risurrezione diede da pascere a Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida; egli l'ha eretta per sempre come ‘colonna e fondamento della verità’ (cf. 1 Tm 3,15). Questa Chiesa, costituita e organizzata in questo mondo come società, sussiste [subsistit in] nella Chiesa Cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui” (Lumen gentium, n° 8). Con l'espressione "subsistit in", il Concilio Vaticano II volle armonizzare due affermazioni dottrinali: da un lato che la Chiesa di Cristo, malgrado le divisioni dei cristiani, continua ad esistere pienamente soltanto nella Chiesa Cattolica, e dall'altro lato “l'esistenza di numerosi elementi di santificazione e di verità al di fuori della sua compagine”, (Lumen gentium, n° 8) ovvero nelle Chiese e Comunità ecclesiali che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa Cattolica (17) . Ma riguardo a queste ultime, bisogna affermare che il loro valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità che è stata affidata alla Chiesa Cattolica”. (Unitatis redintegratio, n. 3) ". La prima affermazione dottrinale deve intendersi precisamente: " La Chiesa di Cristo continua ad esistere pienamente nella sola Chiesa cattolica ". Non si dice che la Chiesa di Cristo esiste solo nella Chiesa cattolica, espressione che a rigore sarebbe accettabile nonostante l’inutile sottigliezza, si dice invece che nella Chiesa cattolica esiste solo la Chiesa di Cristo nella sua pienezza; e questa affermazione fa il pari con la seconda affermazione dottrinale, in cui è detto che al di fuori della Chiesa cattolica esistono numerosi elementi di santificazione e di verità, esiste cioè anche una Chiesa di Cristo non nella sua pienezza. La nota aggiunta al testo precisa anche che questi elementi sono degli " elementa Ecclesiae ", elementi della Chiesa di Cristo: sarebbero forse delle chiese di Cristo " in via di sviluppo " ?… In ogni caso si tratterebbe della Chiesa di Cristo, ma non nella pienezza. Il paragrafo seguente, il n° 17, precisa meglio questa analisi. Ma prima di passare a questo paragrafo, segnaliamo un altro punto del n° 16, anch’esso meglio spiegato nel n° 17. Si tratta della citazione della Unitatis redintegratio, n° 3: la forza di santificazione delle chiese e delle comunità ecclesiali che non si trovano ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, " deriva dalla pienezza della grazia e della verità che è stata affidata alla Chiesa cattolica ". Questo significa che vi è una differenza di grado tra la Chiesa cattolica (grado pieno) e le sette (grado parziale). Sarebbe giusto dire che Cristo dona la grazia della salvezza al di fuori del cattolicesimo, anche in quei gruppi religiosi sorti da una rottura con la chiesa cattolica e che si chiamano sette; ma la dona non per esse stesse, ma malgrado esse: le sette (eretiche come i protestanti o scismatiche come gli ortodossi) in quanto tali sono un ostacolo all’azione santificante di Cristo, e tali restano anche quando l’azione di Cristo è così potente da superare l’ostacolo (18) . I documenti della Santa Sede posteriori al Vaticano II esplicitano il n° 8 della Lumen gentium dicendo che Cristo santifica non solo nelle ma anche per le sette, in quanto che le sette sarebbero come delle emanazioni imperfette del cattolicesimo. Il n° 17 è ancora più chiaro. " Esiste quindi un'unica Chiesa di Cristo, che sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Le Chiese che, pur non essendo in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, restano unite ad essa per mezzo di strettissimi vincoli, quali la successione apostolica e la valida Eucaristia, sono vere Chiese particolari. (Unitatis redintegratio, nn° 14 e 15). Perciò anche in queste Chiese è presente e operante la Chiesa di Cristo, sebbene manchi la piena comunione con la Chiesa cattolica, in quanto non accettano la dottrina cattolica del Primato che, secondo il volere di Dio, il Vescovo di Roma oggettivamente ha ed esercita su tutta la Chiesa ". In altre parole, le sette scismatiche che rifiutano il dogma del Primato del Sovrano Pontefice sono " vere Chiese particolari ", delle vere parti in cui " è presente e operante la Chiesa di Cristo ". " Invece le comunità ecclesiali che non hanno conservato l'Episcopato valido e la genuina e integra sostanza del mistero eucaristico, non sono Chiese in senso proprio; tuttavia i battezzati in queste comunità sono dal Battesimo incorporati a Cristo e, perciò, sono in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa. (Unitatis redintegratio, n° 3). Il Battesimo infatti di per sé tende al completo sviluppo della vita in Cristo mediante l'integra professione di fede, l'Eucaristia e la piena comunione nella Chiesa. (Unitatis redintegratio, n° 22). In altre parole, la nozione di " elementa Ecclesiae
" ammette delle differenze di grado o, se si preferisce, una analoga estensione
del significato. Si passa qui alle sette anglicane e protestanti e si afferma
la realtà di una comunione ancora meno piena ma reale con il cattolicesimo.
Qui troviamo un errore ancora più grave: non
solo si ripete che la Chiesa di Cristo non è strettamente la Chiesa
cattolica, ma si precisa che la chiesa cattolica è la Chiesa di
Cristo nella sua pienezza e fuori di essa, nelle sette scismatiche o eretiche,
vi sono, più o meno, degli elementi parziali della Chiesa di Cristo.
29 giugno 2007 (19) La prima risposta di questo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede respinge categoricamente ogni rottura, ogni soluzione di continuità tra il magistero anteriore al 1962 e il Concilio ecumenico Vaticano II. Vi si fa un chiaro riferimento al discorso programmatico del 22 dicembre 2005, nel quale il Papa Benedetto XVI condanna ciò che egli chiama (pomposamente) " l’ermeneutica della rottura ", in altre parole l’interpretazione ultra progressista del Concilio, come l’abbiamo riscontrata, per esempio, nel padre Boff. Noi vorremmo credere a questa sconfessione, ma sentiamo il dovere di verificarla. Che dice esattamente il Discorso del 22 dicembre 2005 ? Niente di diverso di quello che hanno già detto Giovanni XXIII e Paolo VI (esplicitamente citati, peraltro) nel corso dello stesso Vaticano II. Il testo fondamentale al quale fa riferimento Benedetto XVI in questa occasione è giustamente il discorso di apertura del Concilio, pronunciato l’11 ottobre 1962, diceva Giovanni XXIII: " occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi ". 43 anni più tardi, Benedetto XVI non fa altro che ripeterlo, con parole diverse: " È chiaro che questo impegno di esprimere in modo nuovo una determinata verità esige una nuova riflessione su di essa e un nuovo rapporto vitale con essa " (20) . È il cambiamento nella continuità, cioè una rottura che nasconde sé stessa: " il programma proposto da Papa Giovanni XXIII era estremamente esigente, come appunto è esigente la sintesi di fedeltà e dinamica " (21). Siamo al cospetto di una sintesi, tanto amata dai modernisti, e cioè della fedeltà nel dinamismo e del dinamismo nella fedeltà. Già San Pio X aveva sottolineato come i modernisti ricorrano a questo genere di sintesi per ingannare gli spiriti incauti, e noi lo abbiamo citato prima, richiamando il famoso n° 20 della Pascendi: " avviene che nei loro libri si incontrano cose che ben direbbe un cattolico; ma, al voltar della pagina, si trovano altre che si stimerebbero dettate da un razionalista ". È l’arte di conciliare la verità e l’errore, a profitto dell’errore e a scapito della verità, con l’uso di espressioni equivoche e contorte. Ai tempi di San Pio X, il complice di Alfred Loisy, Mons. Mignot, vescovo di Albi, vi faceva volentieri ricorso quando auspicava la libertà " di proporre non dei nuovi dogmi, ma delle nuove spiegazioni dei dogmi eterni " (22) . Eravamo già alla purezza di Giovanni XXIII e al " processo di novità nella continuità " (23) di cui parla Benedetto XVI. La seconda risposta del documento indica in che senso occorra intendere il termine " sussistere ". Questo termine significa esistere nella pienezza; esso si riferisce " alla permanenza di tutti gli elementi istituiti da Cristo nella Chiesa cattolica ". Per dissipare ogni equivoco, il testo precisa a cosa si oppone logicamente questa esistenza nella pienezza: " mentre si può rettamente affermare che la Chiesa di Cristo è presente e operante nelle Chiese e nelle Comunità ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, grazie agli elementi di santificazione e di verità che sono presenti in esse, la parola "sussiste", invece, può essere attribuita esclusivamente alla sola Chiesa cattolica ". In altre parole, la Chiesa cattolica è la sola ove sussista la Chiesa di Cristo, perché essa è la sola in cui la Chiesa di Cristo esiste nella pienezza. Altrove, la Chiesa di Cristo non sussiste, essa è solo "presente ed agente ", il che è già una ben eccessiva concessione, poiché equivale con l’adottare quello stesso relativismo che si vorrebbe scartare. La terza risposta conferma la seconda. Giustamente ci si chiede: perché si è voluto rimpiazzare il classico e tradizionale " è " con questo nuovo " sussiste " ? La risposta data è in linea con tutto quello che precede: " L’uso di questa espressione, che indica la piena identità della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica, non cambia la dottrina sulla Chiesa; trova, tuttavia, la sua vera motivazione nel fatto che esprime più chiaramente come al di fuori della sua compagine si trovino numerosi elementi di santificazione e di verità, che in quanto doni propri della Chiesa di Cristo spingono all’unità cattolica ". Con l’espressione tradizionale si indicava l’identificazione pura e semplice della chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica: la Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica. La nuova espressione " subsistit in " indica una identificazione che non è più pura e semplice, ma parziale: una identificazione principalmente con la Chiesa cattolica, ma secondariamente anche con le altre società religiose. In questo modo la Chiesa di Cristo ha gradi diversi: essa è in pienezza con la Chiesa cattolica e in alcuni elementi più o meno sviluppati fuori di essa. L’argomento chiave è ripreso dal n° 3 di Unitatisredintegratio. Le sette scismatiche ed eretiche separate dalla Chiesa cattolica " nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di significato e di peso". La nuova espressione " subsistit in " è così poco omogenea col discorso tradizionale anteriore al Vaticano II, che i suoi interpreti autentici fanno dei grandi sforzi per cercare di adattarla al contesto del deposito rivelato. La quarta risposta dice in che senso si può utilizzare il termine " chiesa " per parlare degli scismatici. La Chiesa di Cristo implica tre elementi costitutivi: la vera successione apostolica, la realtà del Sacramento dell’Eucarestia, la comunione col Papa. Il primo e il secondo elemento sono costitutivi in maniera essenziale, e il primo (che implica il secondo) è sufficiente perché si possa parlare di chiesa; il terzo elemento, invece, è costitutivo in termini interni, ma non è essenziale. Essendo la Chiesa cattolica la sola a possedere i tre elementi costitutivi, essa si identifica con la Chiesa di Cristo. Gli ortodossi, possedendo il primo e il secondo elemento hanno il diritto reale di essere designate come delle chiese particolari. Si tratterebbe delle piccole " chiese sorelle " dell’unica Chiesa di Cristo, espressione impiegata ancora recentemente da Papa Benedetto XVI in visita al patriarca scismatico Bartolomeo I (24). Non ci sbagliamo: tutto l’insegnamento dei papi prima del Vaticano II ha sempre dato gli ortodossi per quello che sono: degli scismatici che costituiscono tante sette autocefale per quanti patriarchi o metropoliti esistono. E pure eretiche, poiché rifiutano il dogma del Primato del Vescovo di Roma, quello dell’Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, e quello dell’infallibilità pontificia; cosa che è davvero troppo per dei successori degli Apostoli. La successione apostolica non consiste nel solo fatto di far risalire la propria origine a questo o a quell’Apostolo, ma anche e soprattutto nel fatto che l’autorità dei pastori di una Chiesa particolare deriva dagli Apostoli per successione legittima e ininterrotta. E questa legittima successione garantisce anche l’autentica trasmissione della dottrina ricevuta dagli Apostoli. È per questo che laddove la legittimità della successione è venuta meno, per il fatto che i titolari di una sede si sono separati dal successore di Pietro, non vi è più vera successione apostolica, ma una semplice continuità materiale, storica, senza legittimità né continuità dottrinale con l’insegnamento degli Apostoli. La successione apostolica o è formale o non è, ed essa implica essenzialmente la comunione con il Papa. E successione e comunione sono elementi essenzialmente costitutivi della chiesa fondata da Gesù Cristo (25) . Per Benedetto XVI la successione apostolica si riduce alla sola validità dell’episcopato, cioè alla sola consacrazione episcopale validamente ricevuta. Questo significa dimenticare che una cosa è la validità del sacramento dell’Ordine, altra è la sua efficacia e la sua liceità. L’eretico o lo scismatico formale possono ricevere il sacramento ed eventualmente anche il carattere, ma non la grazia del sacramento. Leone XIII l’insegna chiaramente: i sacramenti amministrati al di fuori dell’unità cattolica, anche se validi, sono amministrati in maniera sacrilega (26) . D’altra parte, anche se validamente consacrato, un vescovo scismatico non ha alcuna giurisdizione perché è separato dal successore di Pietro, fonte visibile di ogni giurisdizione. Tra l’essenziale costitutivo e il costitutivo interno non essenziale (quando ci si fa capire, si parla sempre meglio…) vi è indubbiamente la differenza tra l’uomo malato e l’uomo sano o tra l’uomo addormentato e l’uomo sveglio; ma la Chiesa di Gesù Cristo non è mai malata o addormentata essa è interamente una, santa cattolica, apostolica, e il suo essere una società visibile richiede essenzialmente (e non solo intrinsecamente) la comunione gerarchica con il successore di Pietro. È questo il senso dell’adagio " ubi Petrus, ibi Ecclesia ", " dove è Pietro, là è la Chiesa ", che risale ai bei tempi andati dei buoni vecchi papi. Se la comunione con il Papa non è un elemento essenziale della Chiesa, lo scisma non è più uno scisma. Si tratterebbe solo di una comunione meno piena in cui la Chiesa di Cristo è comunque presente e agente grazie agli elementi di santificazione (sacramenti amministrati in maniera sacrilega…?) e di verità (affermazioni contrarie ai dogmi della fede…?) che vi si trovano. Dal 1973 al 2007: un insegnamento costante Da Paolo VI a Benedetto XVI, passando per il Cardinale
Ratzinger, la dottrina della Sacra Congregazione per la Dottrina della
Fede non è cambiata di un solo iota. Questa dottrina si può
riassumere così: la Chiesa cattolica è la Chiesa di Cristo
nella sua pienezza, mentre al di fuori della Chiesa cattolica, nelle sette
scismatiche o eretiche, vi sono (più o meno) degli elementi parziali
della Chiesa di Cristo. Si precisa che la presenza di questi elementi parziali
della Chiesa di Cristo ha per conseguenza che le sette scismatiche o eretiche
sono, in quanto tali, dei mezzi ai quali può ricorrere lo Spirito
Santo per compiere la salvezza. La differenza tra queste ultime due è
che solo le sette scismatiche hanno diritto al titolo di “Chiesa particolare”.
Benedetto
XVI, dunque, rimane invariabilmente legato alla lettera del Concilio, e
tale legame rende illusorio il fatto che questo papa possa produrre una
qualche interpretazione autentica dei testi del Concilio nel senso di un
ritorno alla Tradizione.
Il papa attuale non manca di trarre le conseguenze di questa nuova ecclesiologia. In occasione della sua visita al patriarca scismatico Bartolomeo I, il 30 novembre 2006, Benedetto XVI ha assistito (in tenuta liturgica ufficiale) alla celebrazione (scismatica) della liturgia nella chiesa di San Giorgio al Fanar, a Costantinopoli. Nell’allocuzione pronunciata alla fine di questa cerimonia,
il Papa ha detto: " Oggi, in questa Chiesa Patriarcale di san Giorgio,
siamo in grado di sperimentare ancora una volta la comunione e la chiamata
dei due fratelli, Simon Pietro e Andrea, nell'incontro fra il Successore
di Pietro e il suo Fratello nel ministero episcopale, il capo di questa
Chiesa, fondata secondo la tradizione dall'apostolo Andrea (27).
Il nostro incontro fraterno sottolinea la relazione speciale che unisce
le Chiese di Roma e di Costantinopoli quali Chiese Sorelle (28).
Il Papa ricorda che lo scopo della sua presenza è quello di " rinnovare
il comune impegno per proseguire sulla strada verso il ristabilimento,
con la grazia di Dio, della piena comunione fra la Chiesa di Roma
e la Chiesa di Costantinopoli" (29)
(Benedetto XVI, ibidem, p. 22). Cosa questa che è conseguente con
l’idea maestra del Vaticano II che distingue tra la Chiesa propriamente
detta e gli " elementa Ecclesiae ".
Come abbiamo detto all’inizio, il modernismo si basa su tre grandi postulati: la fede e la rivelazione consistono nel vivere un’esperienza; la Chiesa è la comunione di coloro che vivono questa esperienza; il cattolicesimo è solo il coronamento o la pienezza di questa esperienza. Questi tre postulati fondamentali sono le costanti del modernismo, ieri e oggi. Li si ritrova in questo n° 8 della Lumen gentium, che ne è la sintesi perfetta. La Chiesa di Cristo che sussiste (o esiste nella pienezza) nel cattolicesimo è l’esperienza mistica comune inaugurata sulla terra da Cristo. Essa è presente ed agente ovunque si ritrovino elementi parziali del movimento religioso messo in moto da Cristo. Abbiamo anche fatto notare come questo neo modernismo odierno non si presenti con gli stessi connotati di quello di ieri, e questo perché dietro il modernismo vi è una filosofia, ed essa può cambiare. Si comprende come l’errore teologico di Alfred Loisy poggiasse sull’idealismo di Emmanuel Kant e sull’evoluzionismo di Friedrich Hegel. Oggi la nuova teologia preferisce fare riferimento ai filosofi personalisti ed esistenzialisti, scartando i filosofi idealisti ormai obsoleti. Il modernismo ne approfitta per ingannare gli spiriti incauti: si pensa ingenuamente che la teologia del Vaticano II non sia modernista perché respinge l’idealismo di Loisy, ma non basta rompere con l’idealismo per sfuggire al modernismo. Esso si adatta a tutte le filosofie, considerato che queste tengono per principio il divenire invece dell’essere; e le filosofie moderne sono tutte filosofie del divenire, solo la filosofia di Aristotele e di San Tommaso è la filosofia dell’essere, la filosofia eterna del senso comune. Per uscire dal modernismo, dunque, non basta passare da
un sistema evoluzionista ad un altro, come il camaleonte che cambia il
colore della sua pelle. È necessario ritornare alla filosofia dell’essere.
Diversamente si continua ad utilizzare il linguaggio della teologia cattolica,
dandogli un senso ad essa estranea. È questo il principale peccato
del Concilio Vaticano II: ha voluto presentare la dottrina cattolica "
secondo i metodi di ricerca e di formulazione letteraria del pensiero moderno
"(34). Sfortunatamente, il Papa
attuale non sembra pronto a ripensarci, a leggere queste righe tratte dal
suo discorso programmatico, in cui ribadisce il proposito avanzato da Giovanni
XXIII: " È chiaro che questo impegno di esprimere in modo nuovo
una determinata verità esige una nuova riflessione su di essa e
un nuovo rapporto vitale con essa " (35)
(Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 2005. Cfr. Documentation
Catholique n° 2350 (15 gennaio 2006), p. 60).
NOTE 1 - Pascendi,
n° 53 (torna su)
(su)
Sull'argomento si vedano anche: - San Pio X: Decreto: Lamentabili sane exitu (Decreto del Sant'Uffizio che condanna 65 proposizioni moderniste) - San Pio X: Enciclica : Pascendi Dominici gregis (Con la quale si condanna il modernismo) - San Pio X: Motu proprio: Praestantia Scripturae Sacrae (Nel quale si ribadisce la condanna del modernismo, si menzionano le pene e si commina la scomunica per i trasgressori) dicembre 2007 AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI |