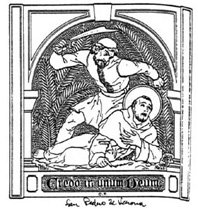SAN PIETRO MARTIRE, INQUISITORE UCCISO DAGLI ERETICI
SEVESO 1252, MORTE DI UN INQUISITORE
(Articolo di Massimo Trifirò, da la Padania del 29 agosto 2004)
La drammatica storia dell’agguato al frate domenicano
veneto Pietro Rosini
compiuto in Brianza da parte di alcuni eretici lombardi
1. IL DOMENICANO
Pietro Rosini, il domenicano che in seguito sarà
martirizzato e rapidamente elevato agli onori degli altari, venne al mondo
a Verona in un giorno imprecisato del 1206.
La sua famiglia, come altre di qualche influenza nei
territori settentrionali della Penisola, apparteneva, seppur non ne mostrasse
la sfacciata evidenza, alla setta dei catari, o manichei, specificatamente
indicati col nome di Patarini, ovvero ad una delle forme ereticali cristiane
maggiormente diffuse in quegli anni.
Appare dunque paradossale, o forse determinato da una
volontà superiore, che il successivo dipanarsi della sua esistenza
si sia poi svolto all1insegna della più rigida ortodossia cattolica,
e che addirittura Pietro ne sia poi divenuto un campione, uno strenuo difensore,
qualcuno che pagò con la vita le sue ferme convinzioni religiose.
Si narra comunque, a questo proposito, che il suo indirizzo
di pensiero fosse già ben strutturato fin dalla più giovane
età, al punto che una volta, e forse il ragazzo non aveva neppure
sette anni, trovandosi a discutere con uno zio, lo contraddisse addirittura
su un principio fondamentale della dottrina, a proposito dell’errore cataro
sull’Entità reggitrice del Creato, che era unica e identificabile
con Dio, e non dualistica come gli eretici professavano, divisa cioè
tra il concetto di Bene e quello di Male, tra spirito e materia.
La predisposizione allo studio che Pietro aveva dimostrato
fin da piccolissimo, favorirono che il padre si convincesse ad assecondarla,
inviando perciò il figlio all’Università di Bologna per completare
la propria formazione culturale.
Fu quella l’occasione per imprimere una svolta definitiva
alla sua vita, nel momento in cui, in quella città degli studi sotto
la protezione di papa Innocenzo III, il giovane studente ebbe modo di venire
in contatto con l’ambiente infiammato dallo zelo di Maestro Reginaldo e
dei suoi Frati Predicatori, e soprattutto di conoscere personalmente il
fondatore stesso dell’Ordine Domenicano appena approvato dalla Santa Sede,
ovvero proprio quel Domenico di Guzman che in quel tempo, nel 1221, era
ospite del convento di San Nicolò, in vista della preparazione del
secondo Capitolo Generale dei propri seguaci.
I due, che il destino poi accomunò nella gloria
della santità, dunque si incontrarono, e a quel punto il più
anziano raccolse dal nuovo adepto l’ormai convintissimo desiderio di dedicare
la propria esistenza agli stessi ideali, e alla medesima lotta, che animava
lo spirito battagliero dell’Ordine.
A nulla poi valsero i doverosi tentativi del castigliano
Domenico di raffreddare prudentemente una vocazione che poteva anche rivelarsi
acerba, tramite la puntuale descrizione fatta al veronese della rinunce,
dei dolori, delle fatiche, che il ruolo di predicatore comportava. Pietro,
sempre più affascinato da quella personalità dirompente,
in ultimo rispose di esserne comunque consapevole e pronto ad affrontarli,
e allora venne abbracciato, e definitivamente accolto.
Il noviziato durò in seguito ben nove anni, e
fu condotto in modo esemplare, e addirittura rigido, mostrando giorno per
giorno, ora per ora, sotto la guida del priore Ventura, l’amore del nuovo
converso per lo studio intenso e ininterrotto, e per la preghiera e la
contemplazione, che ogni notte rubavano diverse ore al suo meritato riposo.
Prima di avviarsi sulle strade del mondo, a Pietro Rosini
fu quindi riservata la sorte di far tesoro degli estremi insegnamenti di
Domenico di Guzman, e di essere testimone diretto della sua morte, quando,
tornando da Venezia, al termine di una delle tante visite alle sessanta
case della Confraternita sparse in otto province, il Fondatore cedette
alla consunzione e alla malattia, spegnendosi poi nella stanzetta disadorna
del discepolo Frate Moneta, non avendo mai voluto egli stesso, per umiltà,
possedere una cella propria.
Quando già era stato ordinato sacerdote, indossando
il caratteristico saio bianco con il mantello nero, al nuovo religioso
toccò poi di essere sottoposto ad una prova difficile, ad un’irridente
sfida del Tentatore. Trovandosi a Como, e avendo avuto una concreta apparizione
notturna delle sante martiri Agnese, Cecilia e Caterina d’Alessandria,
così come gli era già capitato a Bologna durante il noviziato,
Pietro venne infatti accusato da spiriti gretti di ricevere segretamente
donne in convento, e spedito poi, per punizione e penitenza, nel lontano
convento marchigiano di Jesi.
Fu però là, dopo che il suo comportamento
integerrimo aveva convinto i superiori a riesaminare il suo caso riconoscendone
alla fine la completa innocenza, che nel 1229 lo raggiunse il decreto di
piena reintegrazione nel ruolo di predicatore itinerante.
Gregorio IX, il papa che era intanto succeduto ad Innocenzo,
determinò perciò di inviarlo a Milano, città che allora
rappresentava il cuore pulsante dell’eresia catara.
Pietro vi giunse nel 1232, e si rese immediatamente conto
di quale forza ed organizzazione possedessero i manichei, attestati specie
all’interno delle potenti famiglie aristocratiche e grandi borghesi locali,
come ad esempio quella dei Pacta da Giussano, che il sacerdote ritroverà
poi sulla sua strada nel ruolo di attentatori alla propria vita. Non appariva
perciò incomprensibile, dati tali radicamenti, che le stesse autorità
municipali meneghine fossero, almeno tacitamente, favorevoli a che l’eresia
continuasse ad allignare, e particolarmente perciò propensi a cercare
di dissuadere ogni tentativo di restaurazione completa dell’ortodossia
cattolica.
Pietro, trovandosi di fronte una situazione tanto complicata
ed ostile, non si perse però affatto d’animo. L’investitura diretta
di San Domenico era la sua forza, e intendeva perciò metterla a
frutto. Posto il proprio quartier generale nel convento di Sant’Eustorgio,
il domenicano, come prima azione, fondò quindi un’associazione di
militanti, una “schola”, ovvero una vera propria “militia
Christi” anti eretica, cui diede nome di “Società
della Fede”.
Non solo, perché il 17 settembre del 1233, ormai
sicuro della consistenza di tali seguaci e della propria indomabile determinazione,
riuscì ad imporre alla municipalità l’inserimento nello Statuto
Comunale del decreto papale che intimava azioni concrete nei confronti
di coloro che professavano apertamente dottrine non condivise.
All’accettazione burocratica di questi principi di lotta
senza alcun compromesso, seguirono poi i fatti concreti, e il conseguente
parziale contenimento dello strapotere ereticale vigente, tanto che lo
stesso Pontefice, in una missiva dell’11 dicembre di quel medesimo anno
indirizzata all’Arcivescovo, doveva poi riconoscere e compiacersi dei risultati
ottenuti dall’energico intervento di Pietro. Il quale peraltro, non ancora
appagato, diede vita, sempre nel 132, ad un’ulteriore confraternita ispirata
al culto mariano, in evidente contrapposizione alla concezione patarina
che irrideva il dogma della verginità in “sede naturale” della madre
di Cristo, e anzi sosteneva, con profondo pensiero e in tutta serietà,
che caso mai la Madonna era stata “fecondata” dallo Spirito Santo attraverso
un orecchio. Tale associazione, che era però di stampo dottrinale
più che votata agli interventi concreti, si adoperò poi per
un capillare impegno di predicazione e diffusione della corretta dottrina.
In quest’ambito, è poi da ricordare l’episodio della “Vergine con
le corna”, che comunque attesta l’avversione, del luogo e dell’epoca, all’opera
di ripristino dell’ortodossia dei fedeli mariani.
Si narra dunque che Pietro Rosini, mentre celebrava la
Santa Messa in Sant’Eustorgio, si avvide che il demonio era penetrato in
un’icona di Maria collocata sopra l’altare, e immediatamente quindi lo
scacciò reggendo tra le dita un’Ostia consacrata.
Leggenda? Può darsi. Ma è segno comunque
preciso di una certa “diabolica” ostilità al culto della Vergine
che persisteva tra gli uomini di carne ed ossa, al punto che poi Vincenzo
Foppa si ritenne in dovere di immortalare quel clima, e l’episodio stesso,
dipingendo nella Cappella Portinari proprio una Maria dotata di inquietanti
appendici luciferine, che ancora oggi è possibile vedere.
La travolgente volontà di ben operare di frà
Pietro non si ridusse però soltanto al battagliero contenimento
dei catari, ma ottenne invece importanti risultati rispetto addirittura
alle conversioni sincere degli eretici.
Ne è prova, ad esempio, la sostanziale scomparsa
della comunità manichea di Concorezzo, dopo che il loro vescovo
Desiderio, nel 1235, aveva rigettato il contenuto del “testo sacro” non
ortodosso detto “La cena segreta”, e si era riavvicinato alle posizioni
cattoliche.
Oppure la ritrattazione dello studioso eretico Raniero
Sacconi, il quale, dopo aver abiurato nel 145, si dedicò addirittura
alla compilazione di una “Summa heresis”, compendio dottrinario cataro
utilissimo alla confutazione da parte delle compagini che intendevano ostacolarne
la diffusione.
All’impegno di Pietro, valorizzato anche dalla nomina
ad Inquisitore della Lombardia stabilita dal pontefice nel 1242, si associò
poi quello dell’arcivescovo Leone da Perego, il quale infatti, stavolta
unitamente ai governanti milanesi, si adoperò in maniera particolarmente
efficace nella lotta anticatara.
Come aveva preannunciato Domenico di Guzman, la vita del
frate che diffondeva la Parola di Cristo doveva improntarsi ad una grande
mobilità sul territorio, e alle conseguenti improbe fatiche, per
allargare il raggio d’influenza dell’insegnamento quanto più capillarmente
possibile. Durante il neppure mezzo secolo della propria esistenza terrena,
Pietro Rosini mantenne perciò fede a tale disposizione, visitando
e soggiornando in innumerevoli località del Nord. Riuscendo perfino
a promuovere la fondazione di due conventi di monache, nel 1240 il domenicano
raggiunse quindi Asti, nel cui monastero venne nominato Priore, e l’anno
seguente la città di Piacenza, nella quale s’adoperò con
energia per instradare i frati e i novizi nello studio puntuale e ininterrotto
delle Sacre Scritture. Non mancò poi di garantire la propria presenza
di ormai acclamato predicatore dall’oratoria travolgente sia a Roma, che
nelle Marche, che un po’ dappertutto in Romagna, e specificatamente a Rimini,
nel 1249.
Assolutamente decisivo fu però il soggiorno a
Firenze, cha data dal 1244. Nel capoluogo toscano avvenne infatti che i
suoi infiammati sermoni, lanciati dal pulpito di Santa Maria Novella, entusiasmassero
a tal punto i cittadini che l’autorità, opportunamente sollecitata
dalla Società della Fede, si vide poi costretta ad allargare la
piazza antistante, per permettere ad un numero maggiore di persone di assistervi
agevolmente.
Il supporto popolare ovviamente galvanizzò Rosini
e il confratello fra’ Ruggero Calcagno, spingendoli quindi ad intensificare
il già duro contrasto con gli eretici locali, in particolare con
tali Baroni, imputati di concedere ospitalità ad importanti vescovi
manichei.
Né sortì in seguito addirittura un processo,
una condanna, e la conseguente avversione alla stessa, fino alla
sua revoca, da parte dei maggiorenti fiorentini avversari di Pietro e della
sua Società, in specie il podestà Pace da Pesamigola.
Rosini però a quel punto non si diede certamente
per sconfitto, provvedendo infatti ad iscrivere pari pari i suoi maggiori
contestatori nell’elenco degli eretici, e appellandosi poi direttamente
al popolo che lo supportava, il quale ottenne allora il sequestro dei beni
dei rei e la demolizione dalle fondamenta delle loro dimore. Il domenicano
ancora una volta perciò aveva vinto, contribuendo al riaffermarsi
del cattolicesimo anche in quelle contrade.
Ma, a proposito di popolo, e delle molte “leggende nere”
fiorite in varie epoche intorno alla reazione cattolica all’eresia, fatta
salva la giusta deprecazione per le esagerazioni dell’Inquisizione giustamente
condannate dalla Storia, vale la pena a questo punto chiarire quale fosse
davvero l’atteggiamento della gente comune rispetto a tali iniziative,
cedendo la parola all’autorità indiscussa di Vittorio Messori, il
celeberrimo saggista cattolico.
In una polemica con Jacques Le Goff a proposito proprio
di Pietro da Verona, sul quale lo storico francese avanza critiche nel
suo “La civiltà dell1Occidente medioevale”, Messori infatti afferma
che “l’inquisizione nasce non contro il popolo”, ma caso mai per rispondere
efficacemente ad una sua precisa richiesta di salute, dato che l’eretico
era considerato dalla gente come colui che propagandava malattie (ideologiche)
mortali e inquinava l’ambiente (spirituale). “Per l’uomo comune l’eretico
è il Grande Inquinatore, è il nemico della salvezza dell’anima,
è colui che attira la punizione sulla comunità”, conclude
quindi lo scrittore.
Da parte della società, derivava perciò
da una tale posizione il diritto legittimo alla difesa anche con i mezzi
più intransigenti, pure se purtroppo talvolta avveniva che qualche
fanatico ne travalicasse volentieri i limiti umanamente consentiti.
Una civiltà strutturata in un certo modo, secolarmente
condiviso, si vedeva cioè costretta a preservare la propria stessa
sopravvivenza e identità, e lo faceva quindi con piena consapevolezza.
I turbamenti del cuore dell’Illuminismo, i cui influssi
sono tuttora riscontrabili, erano infatti ancora di là da venire,
e perciò appare evidente che nessuno osasse allora sostenere, come
invece accade oggi rispetto ad una programmata invasione di un’altra civiltà
che intende cancellare la nostra, che i diritti degli altri sono sempre
volterianamente sacrosanti ed intoccabili. Anche se magari costoro esplicitamente
si dichiarano nemici mortali, che approfittano proprio della nostra debolezza,
della legislazione liberale che noi stessi abbiamo conquistato a prezzo
del sangue, nonché di una malintesa solidarietà, per ripromettersi
in futuro di negarceli tutti con la violenza, a vantaggio esclusivo delle
proprie arcaiche tradizioni che in seguito ci verrebbero inevitabilmente
imposte.
Il 13 giugno 1251, sull’onda del successo fiorentino,
il nuovo papa Innocenzo IV affidò a Pietro Rosini il compito di
contrastare a Cremona l’influenza del vescovo cataro di Tolosa, Bernard
Marty, che vi si era rifugiato per sfuggire all’invasione della sua terra
da parte del cattolico re di Francia, dopo che, nel periodo di vacanza
del pontificato, si erano verificati numerosi attacchi di eretici ai capisaldi
papali, ivi compresi l’incendio della sede dell’Inquisizione e l’assassinio,
il 28 maggio del 1242, di dieci suoi membri ad Avignone.
Quindi, nel corso del medesimo anno 1251, gli pervenne
la nomina a priore del convento di Como e ad Inquisitore pontificio, sia
di quella stessa città che del territorio di Milano. Saranno le
ultime cariche ricoperte da Pietro da Verona.
La vita che il sacerdote conduceva, fin dall’insorgere
della propria vocazione, era sempre stata improntata al rigore più
estremo. L’uomo apparteneva cioè a quella sparuta schiera di coloro
che, nell’Umanità di ogni tempo, pretendono ogni volta da sé
molto di più di ciò che chiedono al prossimo. Salvo che per
quello previsto dal rito quotidiano della Messa, Pietro si asteneva
infatti dal vino, e si limitava ad alimentarsi una sola volta al giorno,
inghiottendo in fretta un piatto di verdure appena condite. Durante la
giornata, come si è visto, si dedicava ad un’attività incessante,
ma anche nelle ore notturne, non ancora pago, molto spesso il frate si
levava dal suo giaciglio e, fino all’alba, si concentrava nella preghiera
e nello studio. La predicazione, così come era avvenuto a Firenze,
produceva poi in ogni luogo una reazione popolare entusiastica.
Il suo avvento era sempre annunciato da un passa parola
eccitato, e la figura del severo domenicano era poi accolta all’arrivo
da canti, suoni di trombe e tamburi, e grida di giubilo. Non era poi infrequente
che, proprio come accadeva al Maestro, frà Pietro si trovasse talvolta
costretto ad avvicinarsi al palco dei suoi sermoni addirittura in lettiga,
perché i fedeli, anche in modo talvolta pericoloso, lo stringevano
sempre da presso, lo volevano toccare, e spesso giungevano perfino quasi
a denudarlo completamente per accaparrarsi un lembo dell’abito monacale
da conservare come reliquia.
Queste manifestazioni di riconosciuta santità
già in vita, corrisposero poi ad eventi effettivamente miracolosi,
che dopo la sua scomparsa furono quindi puntualmente valutati e inscritti
agli atti del processo canonico.
Si constatarono infatti diversi casi di guarigioni altrimenti
inspiegabili, la moltiplicazione improvvisa dell’olio del parroco di Cesena,
e il perdurare assolutamente incomprensibile della limitata scorta di carne
salata della quale si nutriva la squadra di operai addetti alla costruzione
di un convento domenicano.
Tra i tanti prodigi, le cronache riportano poi quello,
non eclatante ma certamente efficace perché venne operato in pubblico,
della scommessa fatta da Pietro con un manicheo sulla piazza di Sant’Eustorgio
a Milano. Il cosiddetto “miracolo della nuvola”, che possiede tra l’altro
un suo intrinseco valore poetico, si verificò nel momento in cui
i due stavano disputando sotto il tormento di un sole a picco che li faceva
quasi smaniare. Alla sprezzante sfida dell’eretico, che invitava l’avversario
a chiedere al proprio Dio di inviare nel cielo completamente sgombro una
nube che li riparasse, Pietro rispose accettando la provocazione, a patto
però che il cataro, se l’evento si fosse davvero verificato, s’impegnasse
ad abiurare seduta stante. La nuvola a quel punto spuntò rapidamente
dall’orizzonte, e si collocò proprio allo zenith del piazzale affollato,
non spostandosi poi di lì fino al termine dello scontro dottrinale.
Un’altra volta, nel medesimo luogo, capitò poi
a Pietro di incontrare ancora un manicheo, il quale, per porre in cattiva
luce l’inquisitore e “dimostrare” che si trattava soltanto di un abile
mistificatore, si finse infermo, chiedendo però a Rosini di guarirlo
da ciò di cui non soffriva affatto. Cosa che naturalmente il frate
s’impegnò puntualmente a fare, dopo che però aveva fatti
miracolosamente invadere l’uomo da autentici e atroci dolori, e non prima
d’aver raccolto il pentimento e l’abiura del mentitore, che a quel punto
s’era affrettato a riconoscere la propria truffa e tutti quanti gli errori
della sua vita precedente.

Oltre che di quello del prodigio, nell’ultima parte della
propria esistenza, l’inquisitore fu anche gratificato del dono divino della
profezia. Accadde infatti, ancora a Cesena nel 1252, che Pietro predicesse
la propria fine per quello stesso anno, che la Romagna sarebbe stata presto
in preda al flagello della guerra, e che il conflitto sarebbe stato condotto
da uomini che avrebbero parlato un linguaggio incomprensibile per le popolazioni
locali.
Tutto ciò infatti puntualmente avvenne, sia per
ciò che riguardava la sua morte che per l’invasione di truppe tedesche
inviate dall’imperatore Federico II, in appoggio ai ghibellini contro i
guelfi filo papali.
In un’altra occasione, Rosini intravide chiaramente nel
futuro, tre anni prima degli avvenimenti, il crollo della fortezza di Gattaedo
presso Giussano, e la successiva esumazione dei corpi di due vescovi catari,
le cui spoglie furono in seguito date alle fiamme.
Né peraltro, sempre a proposito del termine della
propria esistenza, il sacerdote mancò di illustrarne in anticipo
le precise modalità, l’identità ideologica dei colpevoli,
e perfino il luogo esatto nel quale sarebbe stato poi deposto il suo cadavere.
E ciò si verificò più volte, anche nel corso della
sera antecedente il suo ultimo giorno di vita.
È quasi superfluo poi ricordare a questo punto
che anche tali fenomeni servirono poi alle sedici società di eretici
lombardi per preparare il terreno per una violenta reazione contro l’ingombrante
Pietro, accusato d’essere fanatico, ipocrita, e addirittura un pericoloso
stregone.
Adesso era ormai maturato il tempo per la messa in opera
del complotto ai suoi danni.
A metà del XIII secolo, la relativa indipendenza
dei Comuni rispetto alle grandi aggregazioni di potere, l’Impero e il Papato,
era già avviata al tramonto. Si andava perciò imponendo,
sotto tali influssi, una maggiore rigidità dottrinale, la cui funzione,
pur se non imposta artificiosamente, era quella di compattare la coscienza
popolare in un unico e solido alveo, prescindendo dalla “tolleranza” verso
gli eretici fino allora vigente in ambito municipale, nel quale ciò
che davvero contava era soltanto l’ideologia della merce e del guadagno,
da chiunque fosse poi sostenuta.
In Lombardia, nella zona nella quale si verificheranno
i successivi sanguinosi avvenimenti, dominavano molte potenti famiglie
di fede catara, gelose sia dei loro possedimenti che della possibile, e
temuta, interferenza degli inquisitori nella loro “autonomia”, ovvero nei
loro affari.
Tra essi, spiccavano certamente le dinastie dei Pacta,
originari di Giussano, e dei Confalonieri, di Agliate. Entrambe infatti
ebbero poi, con il consenso ed il sostegno dell’intera Pataria milanese,
un ruolo decisivo nei fatti che portarono a morte l’inquisitore domenicano
Pietro Rosini da Verona, all’età di soli quarantasei anni.
La dinamica di ciò che effettivamente avvenne
è poi ben descritta negli atti del processo ai colpevoli, il quale,
alla presenza dei frati Rainerio da Piacenza e Daniele dell’Ordine dei
Predicatori, si tenne a Milano il 2 settembre del 1252.
Era dunque accaduto che fra’ Pietro, in Como, aveva intimato
ad un eretico contumace di presentarsi entro due settimane al Tribunale
dell’Inquisizione di Milano per essere giudicato. Il termine sarebbe scaduto
proprio il giorno seguente, e quindi il domenicano, dopo aver enunciato
quelle profezie di morte di cui si è già detto, si era perciò
messo in cammino dalla località lariana in direzione della grande
città. Portava con sé il confratello Domenico, in un lungo
viaggio a piedi per il quale sarebbe occorsa almeno un’intera giornata.
Per compiere il proprio dovere, o per andare incontro ad un destino che
era comunque stato già decretato, Rosini non aveva inoltre badato
affatto alla febbre quartana che in quel momento lo stava divorando. Preannunciando
per l’ennesima volta la propria dipartita dal mondo, aveva infatti dichiarato
che comunque presto avrebbe riposato tranquillo nella basilica di San Simpliciano,
che in seguito si rivelerà appunto il luogo della sua prima sepoltura.
Era un sabato, e, con i due viaggiatori, si era aggregata
un’altra coppia di frati, che era però previsto li dovessero abbandonare
poco prima di arrivare a Milano, prendendo la via di un convento di Meda,
alle porte della città. A quel tempo, in quella parte alta della
Lombardia, i lunghi tratti tra gli scarsi luoghi abitati erano luoghi pressoché
deserti, scarsamente vigilati, e coperti da boschi fitti, all’ombra dei
quali era possibile, quasi impunemente, compiere ed occultare qualsiasi
crimine. In più, non va dimenticato che l’inquisitore era un nemico
in terra ostile, popolata di manichei, e che si muoveva a piedi e senza
la scorta adatta a potere respingere un attacco.
Intanto, appunto questi irriducibili avversari stavano
per definire gli ultimi ritocchi della loro nefasta impresa. Manfredo,
della famiglia dei da Giussano si era infatti trovato, nella sua cittadina,
con Stefano Confalonieri, e insieme, già ben determinati a sopprimere
Pietro, si erano confidati, in Milano, con tale Guidotto da Sacchella,
anch’egli appartenente alla Pataria. La combriccola si era successivamente
recata da tale Giacomo della Glusa, il quale, nell’economia del complotto,
doveva essere colui che sosteneva la parte del tesoriere. Era stato dunque
richiesto denaro per pagare i sicari, e, il giorno dopo, i congiurati l’avevano
puntualmente ottenuto, in un borsa sigillata, consegnata ad un certo Facio
da Giussano, che conteneva una forte somma in lire di terzoli in denari
grossi, corrispondente più o meno a tre decine di imperiali d’argento,
simbolicamente appunto i trenta denari di Giuda Iscariota.
A quel punto c’era però da determinare l’identità
degli esecutori materiali. Sui loro precisi nominativi, le carte stesse
del processo e le memorie del tempo per la verità divergono un po’,
anche se tutte le testimonianze restringono poi il campo ad un ristretto
numero di possibili protagonisti. Tra i potenziali assassini, probabilmente
già conosciuti sulla piazza milanese per la loro sicura professionalità
di criminali incalliti, si trovava certamente Albertino Porro, detto pomposamente
il Magnifico. Un altro attore della vicenda era poi suo fratello Pietro,
soprannominato l’Uccellatore, il quale, secondo le contrastanti versioni,
o avrebbe agito direttamente, o sarebbe intervenuto in un secondo momento,
semplicemente nella veste di colui che, a misfatto compiuto, si recava
tranquillamente dai potenti per battere cassa. Il terzo uomo, citato più
volte negli incartamenti, era invece un tale Carino da Balsamo, che, per
complicare ulteriormente il quadro, o era una persona effettivamente esistente,
di cui però in seguito non si troverà traccia in alcun documento
anagrafico, oppure corrispondeva semplicemente al soprannome di Pietro
Porro, o, per altre ipotesi meno attendibili, dello stesso “magnifico”
Albertino.
In ogni modo, allertati, ricompensati, determinati, costoro,
la mattina del 6 aprile 1252, si avviarono da Milano alla volta del bosco
di Barlassina, e in specie della brughiera di Farga, nel territorio allora
silvestre di Seveso, poco fuori dal capoluogo. E giunti là, si posero
poi pazientemente in agguato, avendo la certezza, per precedenti spiate
di certi catari lariani, o per il controllo diretto dello stesso Carino
indirizzato da Manfredo da Giussano e da Stefano Confalonieri che si erano
precedentemente portati sul lago per verificare con i loro occhi la situazione,
che Pietro Rosini si era già mosso da Como, e doveva quindi necessariamente
transitare per quegli specifici luoghi desertici.
E così infatti puntualmente avvenne. L’attesa
era stata lunga e noiosa, il mezzogiorno di una giornata primaverile aveva
fatto sudare i sicari sotto le cotte di maglia di ferro, ma il frate, anzi
due, erano ormai alle viste, e stavano procedendo sereni incontro alla
loro sorte di animali sacrificali, mentre cantavano la Sequenza “victimae
paschali laudes”, ed erano quindi già pronti ad essere offerti in
olocausto per la sopravvivenza dell’eresia manichea, e dei consistenti
interessi che vi ruotavano attorno.
Carino da Balsamo, chiunque si celasse sotto questo nome,
a quel punto scattò. Venne all’improvviso allo scoperto, uscendo
di gran carriera dal fitto del bosco, e afferrò poi violentemente
l’inquisitore per un braccio, trascinandolo quindi di forza di nuovo all’ombra
dei rami. Là poi, con fredda determinazione, gli calò sulle
spalle e sul cranio due terribili fendenti di falcastro, una sorta di coltellaccio
diritto, a lama larga e punta quadrata. In quel momento Albertino, che
in verità non si stava poi dimostrando tanto magnifico, fu però
colto dal panico, e cominciò a fuggire urlando verso Meda, attirando
su di sé l’attenzione dei contadini del circondario. Carino comunque
non era certo individuo da lasciare a mezzo un lavoro per il quale era
stato lautamente ricompensato. Scrollò infatti le spalle alla vista
dell’altro complice che si era allontanato e, con rinnovata foga, si gettò
poi anche su frà Domenico, l’accompagnatore di Pietro, abbandonando
per il momento l’inquisitore ad agonizzare in mezzo alla vegetazione. Il
destino di morte del povero fraticello fu poi dilazionato di poco.
L’accorrere dei campagnoli, attirati dalle urla di Albertino,
per il momento lo salvarono, mettendo in fuga il sicario, anche se, per
le ferite riportate, la vittima rese egualmente l’anima a Dio cinque giorni
dopo l’agguato. In breve gli assassini, ormai circondati da quegli imprevisti
soccorritori, vennero comunque catturati ed incatenati, mentre si approntava
un carro coperto di fiori per trasportare in città le spoglie di
Pietro, deceduto dopo una breve ma straziante agonia. Le stesse, con grande
onore tributato da tutta la popolazione milanese, vennero in seguito deposte
nella chiesa di San Simpliciano, come Rosini aveva previsto in vita, intanto
che in città si andava scatenando una violenza reazione contro il
podestà Pietro Avogadro, accusato di complicità con i malfattori,
e successivamente salvato a stento dall’arcivescovo Leone da Perego. Il
corpo del martire venne quindi seppellito a Sant’Eustorgio, la stessa sede
del suo ufficio da inquisitore nel capoluogo, in un’arca in seguito scolpita,
nel 1399, da Balduccio da Pisa, nel bel mezzo della rinascimentale cappella
Portinari.
Il diretto assassino del frate, presumibilmente aiutato
dalle potenti famiglie mandanti, riuscì poi a fuggire dalla prigione,
ma il suo destino non doveva però più rivelarsi negli anni
a venire ancora quello di sicario a contratto. Raggiunta fortunosamente
la città di Forlì, l’uomo infatti chiese, ed ottenne, di
essere ammesso come fratello laico in un convento di domenicani, per scontare
per il resto della propria esistenza il peccato commesso con una severa
penitenza. Come si è già ricordato, cinque mesi dopo, per
gli altri complici, si tenne il processo, il quale comminò le condanne
proprio in quel Sant’Eustorgio che era diventata l’estrema dimora della
vittima.
Pietro Rosini da Verona, inquisitore e martire, venne
poi elevato agli onori degli altari nel marzo del 1253, a neppure un anno
dalla sua morte, a seguito delle istanze che Leone da Perego, numerosi
aristocratici milanesi, e centinaia di fratelli domenicani, recarono a
Sua Santità Innocenzo IV. Del nuovo eletto, testimoniò poi
anche Caterina da Siena nei suoi celebri “Dialoghi”: “egli odiò
l’eresia tanto da esser pronto a lasciarvi la vita. E mentre visse, sua
cura continua fu quella di pregare, predicare, disputare con gli eretici
e confessare, annunziando la verità e propagandando la fede senza
alcun timore”.
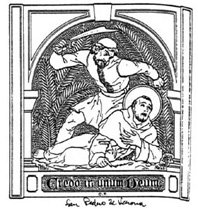
2. IL SANGUE
La testa gli ronzava, e già avvertiva che la fiammella
della vita stava rapidamente spegnendosi all’interno del suo corpo magrissimo,
scavato e prosciugato da quasi mezzo secolo di penitenze, e dalle pene
di un lavoro sempre compiuto senza risparmiarsi un solo momento.
“In manus Tuas, Domine”.
Il delinquente aveva colpito dietro il collo, sull’arco
della sua schiena curva. Poi, incerto che quella ferita potesse rivelarsi
davvero mortale, si era accanito brutalmente contro la testa, sferrando
un colpo duro, spietato, che certamente tra poco si sarebbe rivelato decisivo.
Pietro, trascinato quasi di peso dal sentiero fin al riparo dei tronchi
e della ramaglia vicina, aveva avuto modo di fissarlo per un momento in
volto. Si trattava certamente di un assassino, ma, forse non casualmente,
il male non aveva impresso nei suoi lineamenti i segni distintivi di un
impossibile ravvedimento. Il frate domenicano, come aveva più volte
profetizzato nei mesi e perfino nei giorni precedenti, si rendeva ben conto
che stava per scoccare la sua ultima ora terrena. Non ebbe però
neppure il tempo di provare paura. Era pronto. Era rassegnato. Si sentiva
sufficientemente forte per affrontare il gran passo, per quanto possa mai
esserlo, nonostante vi sia preparato, qualsiasi essere vivente che cessi
di respirare, di godere della luce, di amare e di pensare, nella prospettiva
imminente di venir scagliato nel buio.
Avrebbe pregato per chi lo stava uccidendo, decise mentre
l’altro lo gettava a terra di schianto.
Finché fosse stato in vita, avrebbe implorato
la benevolenza di Dio su di lui. Ma poi, anche dopo il trapasso, in quel
Paradiso nel quale aveva sempre fermamente creduto, si sarebbe adoperato
perché l’Altissimo gli toccasse il cuore, avviandolo ad un felice
destino di pentimento, di penitenza, di conversione.
“In manus Tuas, Domine”.
Sanguinava. Il liquido caldo, grumoso, e d1intollerabile
sentore acre, gli stava scivolando lentamente giù dal cranio squarciato,
imbrattandogli le orecchie, il collo, e impregnando via via il terreno
grasso del sottobosco proprio davanti ai suoi occhi, in quella posizione
accasciata dalla quale ormai non riusciva più a risollevarsi. Il
cervello, la lucidità di pensiero, stavano intanto evaporando, lasciandogli
intatta soltanto la residua energia per recitare mentalmente le estreme
preghiere, la formulazione dell1atto di dolore per un1esistenza comunque
ben spesa, e l'invocazione di perdono alla quale in quel momento teneva
più di ogni altra cosa.
“Fra' Domenico, povero innocente”.
Del criminale da cui era stato assalito, aveva saggiato
la forza, la volontà indomabile di distruzione. Poi, avvertendo
lo strazio della carne e dell1osso che si lacerava, che si frantumava sotto
la mannaia, aveva colto il lampo sulla superficie della lama prima che
calasse, un sottile fiotto di luce che era riuscito a penetrare tra la
vegetazione fino ad illuminare per un istante lo strumento di morte. Quindi,
era caduto all1improvviso il silenzio, e l1agitarsi, il sudore, le bestemmie,
il respiro mozzo del sicario, erano cessati, perché probabilmente,
mentre da qualche parte si udivano altre urla che il morente non riusciva
a decifrare, il bandito si era allontanato per gettarsi contro il povero
confratello che aveva avuto la sfortuna di accompagnarlo nel suo viaggio
da Como.
Pietro da Verona, stringendo i denti per non perdere
ancora coscienza, si concentrò e pregò quindi anche per lui,
affidando l'anima di quella seconda, o forse terza, vittima alla clemenza
dell1Onnipotente. Quindi, liberando a stento il braccio, che era rimasto
imprigionato sotto il corpo caduto, lo allungò, dopo aver intinto
il dito nella minuscola pozza di sangue, verso una pietra piatta, infossata
nel terreno, e che a malapena spuntava tra le erbe, nel manto di aghi di
pino, e in mezzo a qualche fiore stento che si piegava per bere i riflessi
della luce lontana.
“Credo in unum Deum”.
Aveva tracciato la pur breve scritta con crudele sforzo,
passando più volte il dito insanguinato sulle lettere stente, contorte,
dal segno impreciso, a causa della sofferenza che ormai gli aveva invaso
tutte le membra, e per la confusione nella quale stava inabissandosi il
suo indomito spirito. L'aveva vergata in modo approssimativo, ma, come
ultimo atto della propria esistenza votata proprio a quel santo principio,
era riuscito comunque a farlo, e ne era felice.
Credo
Credo che l'Uomo sia un essere fragile, nonostante tutta
la sua arroganza, la prepotenza, la sicurezza tronfia dei principi sbagliati
ai quali si arrende, il delitto cui si vota con troppa facilità.
Credo
Credo che dunque abbia bisogno di Dio, di una bussola
certa durante la sua perigliosa navigazione attraverso i marosi del suo
vivere breve, denso di dolori e di insoddisfazioni, di delusioni, di terrori
e incertezze, di sfinitezze, di crimini e tradimenti, e di sangue fatto
versare inutilmente.
Credo
E credo che compito di questo povero essere a due gambe
che solca sfinito la crosta terrestre sia quello di difenderlo, questo
Dio che lo difende. Sottraendolo agli attacchi della falsa dottrina. Combattendo
chi lo vuole cancellare dal mondo. Orgogliosamente lottando perché
altre fedi fallaci, altre civiltà ostili alla Sua parola, la tentazione
di accontentarsi delle lusinghe del mondo, la debolezza di volerLo svendere
per convenienza o viltà, non prevalgano, svuotando di senso il nostro
essere vivi, temporaneamente esistenti, ma perennemente agognanti ad un
altrove diverso, pieno, completo, di eterna mitezza e felicità.
Pietro Rosini ansimò. Era ormai la fine, se lo
sentiva. Non udiva più un suono, non avvertiva più alcun
movimento intorno a sé. Stava dando l1addio al mondo in una quiete
infinita.
Con un ulteriore moto di volontà, quasi una sorta
di estremo strappo muscolare, allora formulò l1ultima preghiera
della sua breve vita.
“In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum”.
Giacché lui era soltanto un niente che stava tornando
al Padre, e che aveva bisogno di soccorso nel viaggio. Era un grumo di
carne che era apparso fuggevolmente nel fluire della Storia, un essere
forse da poco, ma che era almeno riuscito, per quel che poteva nella sua
debolezza, a prendere le parti delle credenze sincere della propria gente,
e a porsi, per quanto indegnamente, a fianco di Dio.
Pregò dunque, Pietro. E, subito dopo, la sua anima
stanca si trovò immersa in un1oscurità impenetrabile e terrorizzante,
al cui limite già s1intravedeva però un vivido, insostenibile,
lampo di luce.
Ritorna a Documenti
|