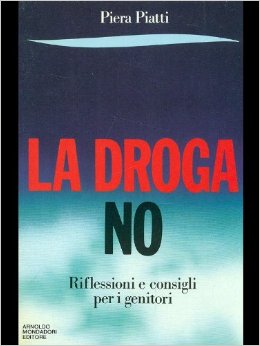LA DROGA NO
Riflessioni e
consigli per i genitori
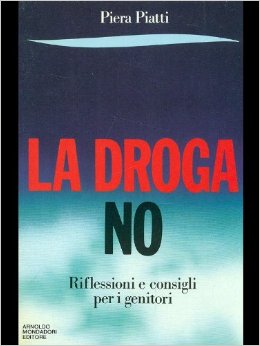
PIERA PIATTI, LA DROGA NO.
Riflessioni e consigli per i genitori, Monddori Editore,
Milano, 1988,
pp. 304, € 12,39.
Presentazione
di Don Curzio Nitoglia
Piera Piatti [1] ha scritto un libro
interessantissimo intitolato La
droga no. Riflessioni e consigli per i genitori (Milano,
Mondadori, 1988).
In questo breve articolo cerco di riassumere il suo libro
1°) per far capire al
lettore la pericolosità delle droghe dette leggere;
2°) per aiutare i giovani a non cadere nella loro
trappola ed i loro genitori a farli uscire se vi fossero caduti.
Il problema
Nel ’68 erano in prima linea l’hashish, marijuana e
Lsd. I tossicodipendenti erano ancora un numero relativamente ridotto.
Con l’arrivo dell’eroina, verso la metà degli anni Settanta,
è iniziata la vera e propria tossicodipendenza su larga scala.
Tuttavia dalla tossicodipendenza si può uscire, a
condizione che la famiglia, aiutata dallo Stato, aiuti il drogato a
disintossicarsi chimicamente e moralmente. Purtroppo la cultura
sessantottina ha parteggiato per i giovani drogati, spingendoli
all’auto-distruzione, e si è schierata contro le famiglie
accusate per principio di essere retrive e antilibertarie.
Nel problema della droga gioca un gran ruolo la cultura nichilista, la
politica libertaria, i preti d’avanguardia e la psichiatria
democratica, che hanno lasciato le famiglie senza aiuto e hanno
addirittura spinto le giovani vittime della droga verso la
libertà di drogarsi, ossia di annichilirsi poiché il
tossico era considerato da costoro un “eroe rivoluzionario
antiborghese” o una “vittima del sistema” (e in un certo senso “vittima
del sistema” lo era, ma proprio di quel sistema, che si presentava come
l’anti-sistema o l’alternativa all’ordine tradizionale, che voleva
abbattere).
L’autrice propone, alla vittima della droga e alla sua famiglia, come
prima cosa da fare l’entrata in una Comunità seria terapeutica
(Come quella di Muccioli a San Patrignano [2]), che aiuti il giovane a
disintossicarsi e a imparare un mestiere per affrontare il futuro.
Certamente occorre prendere atto che, quasi sempre, dove c’è un
drogato c’è un ambiente familiare “ammalato”, ossia in
difficoltà e con dei problemi. Infatti dal momento in cui un
figlio inizia a drogarsi 1°) è forse poiché non ha
trovato un ambiente propizio in famiglia e 2°) conseguentemente
è tutta la famiglia che ne risente. I genitori dei drogati sono
persone in crisi, che vanno aiutate a sormontare il problema che li
attanaglia e non colpevolizzate a priori.
Normalmente la famiglia del drogato poteva avere dei problemi, comuni
agli esseri umani, anche prima che il figlio iniziasse a drogarsi. La
famiglia ideale non esiste, esistono le famiglie reali, con tutti i
loro problemi, i loro limiti e le loro qualità.
L’autrice mette a fuoco le figure di “un padre assente e di una madre
dominante o viceversa di un padre eccessivamente autoritario e di una
madre iperprotettiva”. Il problema, ora, non è quello di far
loro il processo, (l’essere umano non è un angelo) ma di
aiutarli a correggersi perché possano aiutare il loro figlio ad
uscire dal tunnel della dipendenza.
Purtroppo la cultura libertaria accusa spietatamente e per principio la
famiglia come unica causa di ogni male e assolve totalmente il drogato,
invece di aiutare entrambi a capire dove hanno sbagliato e a porre un
rimedio efficace al male.
L’ambiente familiare non è la causa, ma la spiegazione del
disagio del giovane, che poi è scivolato nella droga, il quale
però avrebbe potuto scegliere un’altra via. Non è la
società, il sistema, la famiglia che hanno spinto o necessitato
il giovane verso la droga, ma la mancanza di ideali, di valori, di
forza di volontà sono delle concause, che spiegano la tragedia
che avvolge le famiglie e i giovani.
Però non bisogna mai dimenticare che nella tragedia della
tossicodipendenza il giovane drogato ha soprattutto nella famiglia
umana, con tutti i limiti che l’essere umano ha per sua natura, il
rifugio ed il punto di partenza per una possibile e difficile risalita
dall’abisso.
Il primo obiettivo della lotta contro la droga è il pieno
recupero del tossicodipendente, la prevenzione affinché altri
giovani non cadano nella tragedia della droga e l’aiuto alle famiglie
affinché offrano ai figli i valori che li aiutino a non cedere
alle sue lusinghe.
La liberalizzazione delle droghe equivale a sacrificare un certo numero
di giovani dati inizialmente e certamente per sconfitti e vittime
perpetue della droga.
Offrire eroina o metadone [3] ai tossici equivale a
condannarli alla dipendenza dalle droghe cronica e perpetua senza
nessuna speranza di sconfiggerla. Il mercato di narcotrafficanti non
verrebbe sconfitto perché vi sarebbe sempre una relativa
minoranza di drogati per necessità e legalmente riconosciuti
dallo Stato.
La libera circolazione della droga, secondo l’autrice che è
impegnata da anni nel recupero dei tossici, non fa che incentivare il
suo consumo legalizzato, allargando la fascia dei consumatori e
allontanandoli per principio e per legge dalla cura e dalla guarigione,
che pur essendo ardua è sempre possibile, purché non vi
si rinunci prima ancora di aver combattuto contro essa. Invece
occorrerebbe che lo Stato spezzi il monopolio criminale, che gestisce
lo spaccio delle sostanze stupefacenti.
I sintomi
L’autrice ci spiega quali sono i primi sintomi a partire
dai quali i genitori possono capire se i figli cominciano ad avere
problemi con la droga per poter intervenire tempestivamente quando
è più facile la disintossicazione.
I mutamenti generici del comportamento, ossia:
1°) il calo improvviso e
immotivato del rendimento scolastico o lavorativo, dell’interesse nei
confronti dello studio o del lavoro;
2°) l’alternarsi di euforia e di attività
frenetica a tristezza e abulia profonde e immotivate;
3°) il rinchiudersi del giovane in se stesso, nei suoi
pensieri, che lo estraniano dalla realtà e dalla famiglia;
4°) l’aggressività non giustificata;
5°) le pretese di libertà assoluta senza alcun
controllo familiare e una mentalità ipercritica nei confronti
dei genitori che vengono visti come la causa di tutti i mali;
6°) la richiesta sempre più pressante di denaro.
I cambiamenti specifici e gravemente allarmanti di
carattere non solo comportamentale ma anche fisico si manifestano
quando lo stato del giovane è diventato più grave, ossia
quello dell’abitudinario o dell’assuefatto alla droga, essi sono:
1°) pallore e
sudorazione abnorme;
2°) tremiti e inappetenza;
3°) sbadigli eccessivi, prolungati e continui,
4°) tendenza a grattarsi dappertutto in maniera
compulsiva.
Che fare?
Innanzitutto per aiutare un figlio drogato bisogna saper controllare le
proprie emozioni, evitare le scenate drammatiche, i furori, gli
insulti. Bisogna parlare con lui, manifestargli la gravità della
situazione e promettergli tutto l’aiuto affinché accetti di
entrare in una comunità seria di recupero e disintossicarsi
definitivamente.
Non bisogna arrendersi davanti alle menzogne dei drogati. La menzogna
è la difesa, una specie di “seconda natura” che la droga ha
apportato alla sua vittima. Bisogna fare i conti con essa, è la
“normalità” della vita anormale del drogato.
È sbagliatissimo aggredire prima con parole dure e poi cedere
nella pratica e permettere che la triste storia della dipendenza
continui. Invece occorre fare tutto il contrario: parole buone, cercare
di capire, ma totale intransigenza nelle decisioni pratiche per
spezzare il legame con la droga.
Non bisogna mai permettere al figlio di drogarsi in casa, né
fargli capire che lo si mantiene lo stesso anche se continua a
drogarsi. Egli deve sapere che o lascia la droga o la casa. I genitori
possiedono una forza enorme di cui spesso non si rendono conto: se
decidono di interrompere il mantenimento economico del figlio, questi
sarebbe costretto a trovare il tempo e la voglia di lavorare per
mantenersi, se ce la fa ancora, oppure di entrare in una
Comunità per disintossicarsi.
Perciò occorre manifestargli il proposito fermo di farlo entrare
in Comunità di recupero, senza tentennamenti né rinvii;
sarebbe come rimandare l’operazione di un cancro poiché si teme
la sala operatoria. Se il ragazzo è deciso ad abbandonare la
droga e vuole disintossicarsi, il lavoro è molto più
facile.
I genitori debbono agire tutti e due nella stessa direzione
perché, se uno lotta per la disintossicazione e l’altro “aiuta”
per falsa compassione il figlio a “drogarsi di meno”, la battaglia
è persa.
La disintossicazione
La disintossicazione fisica è il primo passo e va
affrontata in una struttura di ricovero ospedaliero specializzata. Dopo
bisogna inserire il giovane in una Comunità terapeutica. Dopo la
disintossicazione fisica, il giovane soffrirà di stati
depressivi più o meno lunghi. Egli è realmente
disintossicato fisicamente dal veleno della droga, ma i suoi effetti
sul morale e la psiche continuano a farsi sentire per qualche tempo
ancora. Quindi occorre rimettere in piedi la vita intellettuale e
morale del giovane per aiutarlo a ritrovare un motivo di vita e la
voglia di lavorare. Se le vere cause della malattia della
dipendenza non vengono individuate e rimosse, se il giovane non cambia
il suo stile di vita, la droga penderà sul suo capo come una
“spada di Damocle”.
L’autrice offre alcune regole che bisogna far osservare al
disintossicato perché possa riprendere la piena padronanza della
sua vita razionale, volitiva e sensibile:
1°) il tossicodipendente
deve alzarsi presto la mattina e ad un determinato orario;
2°) deve svolgere alcune attività di lavoro o di
studio;
3°) non deve avere molto denaro a sua disposizione;
4°) è bene che contatti gli amici e non viva
isolato;
5°) che pratichi qualche sport;
6°) che partecipi a dei gruppi condotti da un terapeuta
specializzato in tossicodipendenze e che abbia il supporto della sua
famiglia.
La Comunità
terapeutica
La comunità seria che possa aiutare il drogato a
disintossicarsi deve possedere le seguenti caratteristiche: nessuna
droga all’interno, nessuna possibilità di uscire soli per un
lungo periodo, contatti con l’esterno limitati e sicuri, obbligo di
lavorare, eliminazione di ogni comportamento violento o antisociale.
Infine sia i genitori che i giovani dipendenti debbono accettare il
principio che dalla Comunità si esce solo dopo la piena
guarigione, quando i responsabili lo ritengono opportuno. Sino a quel
giorno la casa non potrà essere aperta per accogliere i figli ex
tossici non completamente guariti nel corpo e nello spirito. I ritorni
anticipati hanno quasi sempre esito sfavorevole.
La cocaina
Si dice oggi che la cocaina somministrata in piccole dosi
non sia dannosa e aiuti a vivere al di sopra delle possibilità
comuni. Essa agisce come stimolante del sistema nervoso centrale,
aumenta inizialmente la lucidità mentale e il vigore muscolare,
riduce la sensazione di fatica e consente di apparire estremamente
vivaci e brillanti. Tuttavia poi subentra l’apatia, l’angoscia, la
depressione profonda e talvolta le manie di persecuzione o addirittura
le allucinazioni visive. Molte emorragie cerebrali son dovute all’uso
di cocaina; questa viene somministrate ai rapitori poiché
infonde aggressività e intraprendenza.
La cannabis è una
“droga leggera”?
È chiamata anche canapa indiana, da essa sono
estratti sia l’hashish che la marijuana. Il suo effetto dura alcune ore
ed è allucinogeno seppur vagamente, rilassante e blandamente
euforizzante. Aumenta inizialmente lo stato di benessere e la
loquacità e questa è la sua pericolosità, che
consente di chiamarla droga “leggera” come se non facesse male, ma
molto spesso è la porta per l’eroina. Tuttavia, la cannabis
contiene più catrame del tabacco, dopo un po’ di tempo rende
difficili i movimenti o il loro coordinamento. Ma il suo pericolo
maggiore è il distacco dalla realtà e il calo della
memoria e della forza di volontà. Inoltre produce una notevole
dipendenza psicologica, dovuta agli iniziali effetti piacevoli della
sostanza e una volta che se ne è presa l’abitudine lasciare la
cannabis è molto, molto difficile. La sua tossicità
contratta da un’abitudine si manifesta con danni psichici e mentali.
Come si vede anche la cannabis è una vera e propria droga.
Queste poche pagine, assieme alla raccomandazione di studiare il libro
su citato, sono indirizzate ai giovani che si lasciano illudere dal
mito delle droghe leggere e quindi non pericolose, alle famiglie
affinché possano aiutare i loro figli caduti nella trappola
della droga. Che Dio aiuti tutti a preservarsi da un tale flagello.
d. Curzio Nitoglia
31/05/2014
http://doncurzionitoglia.net/2014/06/02/la-pericolosita-della-droga-leggera/
http://doncurzionitoglia.wordpress.com/2014/06/02/1107/
NOTE
1 - Ha fondato la “Lega
Nazionale Antidroga” nel 1981.
2
- Via San Patrignano, n. 49 – Ospedaletto di Coriano (Forlì).
3
- Il metadone non è una medicina disintossicante, è una
droga che può sostituire l’eroina, con effetti meno devastanti,
ma pur sempre deleteri. Esso elimina in chi l’assume la volontà
di uscire veramente dalla tossicodipendenza. Appiattisce la
reattività, addormenta l’intelletto e la volontà. Insomma
è un surrogato di droga che lo Stato elargisce per mantenere i
suoi assistiti sotto un manto di inebetimento. Sin dal 1979 il dr.
Ciocca, direttore del Policlinico Gemelli di Roma, dichiarava: “dare il
metadone al drogato significa semplicemente continuare a drogarlo”.
Mentre il dr. Cattabeni dichiarava “il metadone non è meglio
dell’eroina e non risolve i problemi dei drogati” (Corriere della Sera, 17 maggio
1978). Inoltre i neuro-scienziati spiegano che l’uso della cannabis
danneggia lentamente, ma inesorabilmente le cellule della corteccia
cerebrale; come pure il fumare abitualmente il semplice tabacco dato il
tasso di catrame che contiene, al di sotto dei 18 anni, nuoce al sano
sviluppo del cervello, che non è ancora pienamente formato.
(giugno 2014)
|