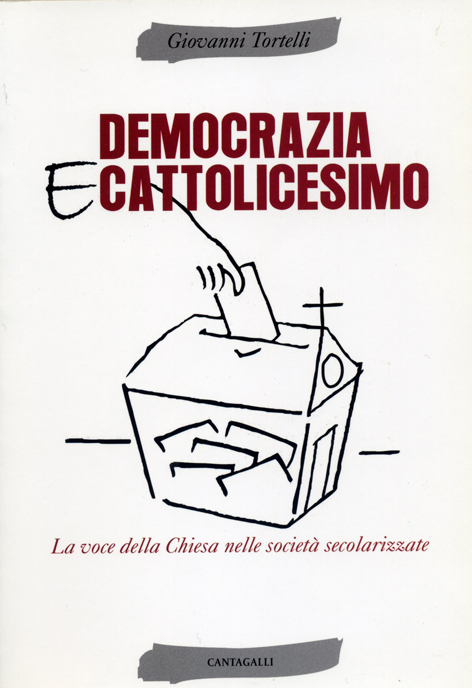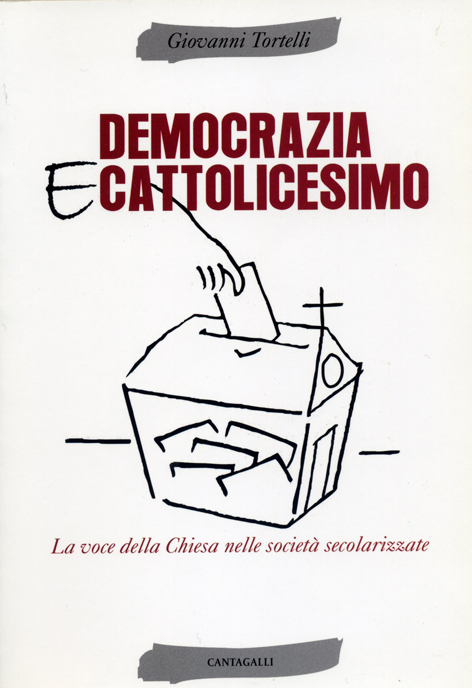
GIOVANNI TORTELLI - Democrazia e
cattolicesimo- La voce della Chiesa
nelle società secolarizzate - Con la Prefazione di
Mons. Brunero Gherardini - Edizioni Cantagalli, Siena, 2012,
pp. 192, € 15,00.
Edizioni
Cantagalli, strada Massetana Romana, 12 - Casella Postale 155 -
53100 Siena - Tel: 0577.42102 -
Fax: 0577.45.363 - Posta elettronica: cantagalli@edizionicantagalli.com
Ecco un libro di facile lettura, che
sintetizza il noto corposo lavoro di Romano Amerio: Iota Unum, pubblicato sia dalle
Edizioni
Lindau, Torino, sia dalle Edizioni Fede e Cultura, Verona
Presentazione
Prefazione
Indice
Presentazione
dalla quarta di copertina
I grandi e affascinanti
temi della democrazia, ma anche i suoi difetti di nascita, la sua
storia, le sue risposte insoddisfacenti di fronte ad una società
che cambia, la sua enfatizzazione da parte di un pensiero filosofico,
politico e giuridico sempre più ostile alla Chiesa. In primo
piano il difficile incontro tra democrazia e pensiero cattolico e
insieme la necessità che alla Chiesa e ai suoi valori venga
riconosciuto uno spazio adeguato nello Stato laico.
|
Prefazione
di
Mons. Brunero Gherardini
Questa volta non mi salva
nessuno dal giusto rimprovero d'Apelle al ciabattino che criticava una
delle sue opere: “Sutar, ne ultra
crepidas”: non al di sopra dei calzari! A dir il vero, il primo
a rimproverarmi d'esser andato “al di sopra dei calzari”, son proprio
io. Troppo chiara è in me, per non farlo, la consapevolezza dei
miei limiti. D’altra parte, il caro Dr. Giovanni Tortelli, che ha
voluto da me questa presentazione, l’ha chiesta con tanta grazia ed
amabile insistenza, da vincer ogni mia residua resistenza. Fermo
restando che non per questo mi sono trasformato all’improvviso in
ciò che non son mai stato, prendo il coraggio a quattro mani e
dico la mia, anche se non suffragata dalla competenza dello
specialista.
Forse qualcuno ricorderà che, nella seconda metà del
1900, in séguito ad alcuni interventi di papa Wojtyla e ad una
riunione programmatica della Conferenza Episcopale Italiana, si diffuse
come una parola d’ordine: dottrina sociale della Chiesa. Le iniziative
si moltiplicarono. Non ci fu Diocesi che facesse l’orecchio del
mercante. lo pure fui chiamato qua e là, dove si fosse istituito
o ripristinato un Centro Studi per la formazione sociale dei cattolici.
Ricordo benissimo che in tali occasioni, per non atteggiarmi a
sociologo, svolsi preminentemente il tema del fondamento teologico
della Dottrina sociale della Chiesa. Mi par opportuno, anche in
quest’occasione, partire dall’accennato fondamento, per non espormi al
rimbrotto d’Apelle né a quello, non meno salace, del vate Dante,
contro chiunque «vuol seder a
scranna / per giudicar da lungi mille miglia / con la veduta corta
d'una spanna» (Parad.
XIX, 79).
Di tale fondamento trovo autorevole conferma in Centesimus annus 55 (AAS
83/1991/860), un’enciclica dello stesso papa Wojtyla, che recita:
«La dimensione teologica
risulta necessaria sia per interpretare, sia per risolvere gli attuali
problemi della convivenza umana». Poco dopo, in quella
medesima enciclica, Giovanni Paolo II rincara la dose e parla non di
semplice “dimensione”, ma di “natura teologica” della Dottrina sociale
della Chiesa. Va detto, anzi, che neanche la convivenza umana si spiega
correttamente e compiutamente se si prescinde dalla teologia e non si
chiede ad essa un po’ di luce per districarsi nei contorti confini
d’un’esistenza, sempre obnubilata e tormentata da problemi perennemente
attuali, perché problemi dell’esistenza stessa. La Dottrina
sociale della Chiesa non solo risponde a tali problemi e non solo
illumina l’incerto incedere dell’umanità in mezzo ad essi, ma
s’insinua nelle maglie stesse dell’essere e ne spiega l’origine e le
finalità, agganciandolo all’atto creativo di Dio, immergendolo
nella luce della divina Rivelazione ed orientandolo verso una comunione
d’amore e di fedeltà a Dio stesso come suo principio e suo fine.
Quale riflesso di codesta comunione di fedeltà e d’amore, si
snoda la gamma vastissima dei rapporti umani in base ai quali gli
uomini son tutti figli dello stesso Padre e quindi tutti fratelli.
La Dottrina sociale, in quanto ha per oggetto l’accennata gamma dei
rapporti umani, dà un colpo d’ala allo svolgimento storico del
genere umano, collegandone le scelte e la loro attuazione alla luce di
Dio e finalizzandone al bene comune, in ossequio a tale luce, l'impegno
con cui, in ogni fase della sua storicità, tenta la soluzione
dei problemi sopra indicati come problemi dell’esistenza umana. La
Dottrina sociale è pertanto l’eco fedele e l’applicazione
articolata del “comandamento nuovo”. All’aggregarsi dei singoli applica
l’Evangelo nella sua essenzialità: l’amore. Non ciecamente,
com’è ovvio, né meccanicamente, bensì in modo
riflesso, ricercando il fondamento non tanto dell’aggregarsi proprio
della stessa natura umana - quanto della motivazione evangelica che lo
signoreggia. E determinando, quindi, il suo concreto attuarsi secondo
linee programmatiche capaci di fonder insieme giustizia e
carità. Autorità e singole coscienze vengon in tal modo
spronate a compier scelte attuative d’una convivenza giusta e pacifica.
Non è chi non veda che, sotto questo profilo, la Dottrina
sociale della Chiesa è di per sé teologia e più
specificamente teologia pratica, con il proprio fondamento ultimo nella
Rivelazione e nel Magistero ecclesiastico. Ciò che il sociologo
chiama solidarietà, per una società cristianamente
organizzata è carità sociale orientata alla comunione. E
quella pace che altri fan derivare dall’ambito della giustizia
attraverso la giusta dialettica dei diritti e dei doveri, diventa nella
e per la società cristiana la civiltà dell’amore. Proprio
questa è dunque la ragione per la quale la Dottrina sociale
della Chiesa ha un’indole indiscutibilmente teologica o, meglio,
è essa stessa teologia.
Non alla Dottrina sociale, tuttavia, s’interessa il volume qui
presentato, o non in prim’istanza, bensì a democrazia e
tradizione. Qualcuno, perciò, potrebbe considerar fuori tema
l’osservazione iniziale sul fondamento teologico della Dottrina sociale
della Chiesa. Non è così.
La tradizione, infatti, è la Chiesa stessa, la sua vita e la sua
giovinezza. La democrazia, a sua volta, la si tratti a parte o nel
quadro complessivo delle tematiche sociali, appartiene a quella visione
organica della società, qual è delineata e fondata dalla
Dottrina sociale della Chiesa. In sé, al di fuori cioè
della sua cornice teologica, la democrazia è per la
società uno dei suoi modi di strutturarsi; il parlarne fa sempre
parte d’un discorso complessivo sulla struttura sociale (oligarchia,
monarchia, democrazia). Proprio per questo la democrazia è una
forma strutturale della convivenza umana; è la struttura
specifica che tale convivenza intende, o ha inteso darsi. È
quindi un fenomeno sociale, oggetto della scienza che studia appunto i
fenomeni sociali e che Auguste Comte chiamò sociologia.
Nel metter a fuoco le dinamiche e le leggi di codesti fenomeni, la
sociologia ha nella democrazia un tema obbligato. Non potrà mai
ignorarlo, sia che lo consideri ancora in termini aristotelici (governo
non dei ricchi ma dei liberi), sia che lo descriva nel suo significato
moderno (di Stato politico i cui cittadini, senza distinzione di
nascita capacità e censo, sono in solido i detentori della
sovranità). Pertanto, un trattato di sociologia, partendo dalla
persona umana come centro di diritti e di doveri, ne analizzerà
la naturale apertura sociale, in rapporto alla famiglia ed alla
comunità. All’interno del quadro sociale, prenderà in
esame l’emergenza del singolo come valore primario, al di sopra della
stessa società, il concorso di tutti al bene comune, i valori di
verità giustizia e libertà che presiedono al pacifico e
retto consorzio civile, i problemi del lavoro e dell’assetto politico
con particolare riferimento alla correlazione tra economia e morale,
tra iniziativa privata ed impresa pubblica, tra solidarietà e
partecipazione.
Basta quest'ultima parola a riportar in primissimo piano la democrazia,
non perché partecipazione sia una parola magica, ma
perché dalla partecipazione la democrazia nasce: la esige, se ne
nutre, ne vive. Né c’è bisogno di scomodar il Parmenide di Platone, le
elucubrazioni dei neoplatonici (Plotino, Prodo, Avicenna) ed in
ultim’analisi nemmeno la metafisica di san Tommaso d’Aquino per capire
il senso del lemma partecipazione. Qui infatti non ne parliamo in
chiave rigorosamente filosofica, nonostante che proprio un principio
tommasiano potrebbe venir in aiuto anche a questo discorso: “Quando una cosa riceve in misura parziale
ciò che nella sua totalità appartiene ad altri, si dice
che ne è partecipe” (De
Hebd. 2,24).
La partecipazione sta alla radice della democrazia, appunto
perché è lo strumento mediante il quale la
sovranità, considerata di pertinenza popolare ed appartenente
perciò senza restrizioni a tutti i cittadini, vien partecipata
entro determinati limiti ad alcuni di essi. I quali, perciò, in
tanto svolgono nella società un compito democratico, in quanto
operano per mandato popolare, insieme con altri, per il bene di tutti.
Ne discende, logicamente, che: 1) non c’è vera democrazia se non
in forma partecipativa; 2) non c’è forma partecipativa se non
come concorso di tutti, in cordata o singolarmente, alla promozione del
bene comune. La qual cosa, in soldoni, è come dire: a)
promozione d’una pacifica coesistenza sociale su base familiare,
cittadina, nazionale e supernazionale; b) incremento culturale ed
economico dell’intero corpo sociale; c) costruzione d’una
società internazionale attenta al bene di tutti mediante la
corresponsabilità d’ognuno.
Ciò che precede è, ovviamente, una contenuta sintesi di
quanto sull’argomento gli specialisti son soliti dire. Aggiungo che la
sintesi è stata redatta in ottica puramente ideale. Sono
però consapevole che quando qualche politico parla di
“democrazia incompiuta” non intende affatto paragonarla all’Incompiuta di Schubert: una
sinfonia che, se pur incompiuta - o forse proprio perché
incompiuta - è un capolavoro. Nella nostra democrazia incompiuta
è possibile ravvisare il rovescio della medaglia “puramente
ideale”. All’atto pratico, infatti, quella che potrebbe apparire come
la più perfetta forma di reggimento politico rivela un'’innata
fragilità: come ogni altro reggimento politico è esposta
essa pure alla legge del più forte. Se penso alla così
detta partitocrazia ed ai suoi giochi di potere, se ne considero i
comportamenti nella storia della nostra democrazia italiana che ho
intensamente desiderato ancor prima che nascesse ed ho poi non meno
intensamente vissuto, ho sotto gli occhi un’interminabile sequenza di
comportamenti partitocratici lesivi delle libertà fondamentali,
a favore delle classi dirigenti e fatalmente ripetitivi, perciò,
delle più deprecabili forme di reggimento oligarchico.
In realtà, c’è nella democrazia qualche motivo di
profonda perplessità: lo chiamerei il suo “peccato d'origine”,
contro il quale, per il momento, non sembra aver trovato un redentore.
Essa si presenta con un suo “dogma” assoluto e indiscutibile: la
sovranità popolare. Guarda caso, è il dogma diffuso a
piene mani dalla Rivoluzione francese. Avesse almeno la delicatezza
d’attenuare l’asserita sovranità con l’aggettivo relativa: in
assoluto, infatti, per il credente la sovranità è di Dio;
per il non credente, non esiste un assoluto che non sia egli stesso. Il
“dogma” della sovranità popolare è, inoltre, come “'a
livella” di Totò: riduttivo d’ogni singolarità,
omologazione qualitativa d’ogni soggetto, relativizzazione d’ogni
capacità e d’ogni impresa.
La conseguenza dell’incenso bruciato anche da uomini di Chiesa a
codesto “dogma” è la caduta verticale d’ogni distinzione:
è, p. es., quel relativismo che a parole si depreca un po’
dappertutto, ma che nella pratica vien tutelato da quelli stessi che lo
deprecano: nel gran contenitore democratico costoro riconoscono che
tutto e perfino il contrario di tutto ha, di diritto, il suo posto.
C’è infine, nel metodo democratico, un pericolo che non
raramente affiora dalla realtà del quotidiano e che eticamente,
giuridicamente, politicamente non saprei come impedire, né come
correggerne gli esiti nefasti: alludo all’aleatorietà - almeno
in apparenza non superabile - della tutela che una maggioranza deve
assicurare alle minoranze ed a tutti i loro diritti. L’impressione
è che, nella pratica, succeda esattamente il contrario.
Si ha così nella democrazia qualcosa di simile ad un tessuto double face: da una parte lo
splendore ideale d’un reggimento politico che riconosce a tutti ed a
tutti i livelli parità di diritti e di doveri; dall’altra una
serie di non superficiali controindicazioni, per non parlare dei fatti
concreti, le cui conseguenze ammorban l’aere del consorzio civile e lo
contaminano.
Mi chiedo, a questo punto, se sia questa la visione della democrazia
descritta nella pubblicazione per la quale sto scrivendo.
Dico anzitutto che si tratta d’un’ottima pubblicazione: una scrittura
limpida ed agile, una conoscenza indubbiamente ampia e profonda della subiecta materia, una pronunciata
sensibilità - oggi non sempre reperibile nemmeno fra tutti gli
uomini di Chiesa o fra tutti gli studiosi d’estrazione cattolica – “per l'ethos come impronta della legge di
natura nella coscienza individuale e collettiva”; un’attenzione
lodevolissima ai valori di fondo di cui la democrazia non può
far a meno senza venir meno essa stessa. Non solo i valori
dell’uguaglianza, della partecipazione e della condivisione, ma anche e
soprattutto quelli della verità, del senso morale, della
libertà e della giustizia, oltre che della “necessaria correlatività tra
ragione e fede” (cfr. Ratzinger).
Evidente la conoscenza delle fonti, ma anche la capacità di
riflettere sulla tematica democratica come tale; sulla democrazia
astrattamente intesa e sulla concretezza storica di quella - o di
quelle - tuttora in atto; sulla “debolezza congenita della democrazia”
e sugli scenari del suo futuro. Un po’ a volo d’uccello può
sembrare la terza parte, forse perché una trattazione storica
dei tanti problemi legati all’argomento ed un’esposizione più
particolareggiata delle concezioni contrapposte - bastano i nomi a far
capire l’ampiezza della contrapposizione: C. Magris, P. Flores d’Arcais
(il sottoscritto conobbe il padre: altra stoffa), G. Zagrebelsky, J.
Habermas e J. Ratzinger - avrebbero richiesto non uno ma più
volumi.
Ciò avrebbe certamente moltiplicato le fatiche del bravissimo
Tortelli, che già ne sostenne molte e di non piccolo rilievo.
Egli, tuttavia, mi permetterà di dirgli molto amichevolmente che
su due punti almeno qualche pagina in più l’avrei letta
volentieri. Mi riferisco alla nozione di teologia politica, sulla quale
egli già riferisce, ma senz’approfondirne in modo ultimativo, il
rapporto con la democrazia; e mi riferisco pure alla Tradizione che, se
è quella della Chiesa, è oggetto diretto ed immediato
dell’ecclesiologia; questa, in effetti, la riconosce nel suo rapporto
con la Sacra Scrittura, nel Magistero ecclesiastico e nella secolare
attività magisteriale di esso. Ma sempre, se è quella
della Chiesa, il trattarne in termini sociologici e puramente
fenomenologici è riduttivo della Tradizione stessa. Non che sia
questa la maniera con cui Tortelli ne tratta; ma, sempre secondo me,
avrebbe fatto bene a metter qualche paletto fra teologia e
fenomenologia, per invitare chi fa finta di niente a proceder per la
propria strada, senz’indebite invasioni di campo.
Non potrebbe esser questo, per il bravo Tortelli, l'oggetto e il motivo
d’un prossimo intervento? Dopo aver terminato la sua fatica attuale con
la distaccata osservazione del Duca d’Auge sulla poca chiarezza della
situazione politica, nell’attesa delle sue fatiche future io chiudo la
mia presentazione con l’augurale ed interessata ripetizione di 1 Re 19,7: «Grandis tibi restat via».
Dal Vaticano, 5 febbraio 2011
Mons. Brunero Gherardini
|
Prefazione
Premessa
Capitolo I - Dentro
la democrazia
1. Le origini
2. La democrazia contemporanea: tentativo di
definizione
3. Fondamenti della democrazia
3.1 Il contrattualismo
3.2 La sovranità popolare e il corpo
elettorale
3.3 Cenno sui sistemi elettorali
3.4 Le regole di maggioranza
3.5 La rappresentanza politica
4. Debolezza congenita della democrazia come forma
di governo
5. Il dominio delle “élites”
6. Quando la democrazia fa autocritica
7. Considerazioni sullo stato presente della democrazia
8. Democrazia: scenari per il futuro
9. Post democrazia?
Capitolo II -
Democrazia e dintorni
1. “democraticismo” e democrazia
2. Necessità di una “teologia della politica”
2.1 Teologia e politica dai primi secoli fino a san
Tommaso
2.2 La Chiesa e le autorità terrene nel
pensiero di san Tommaso
2.3 La Riforma, san Roberto Bellarmino e la
“potestas indirecta”
3. La democrazia come risultato del processo di
secolarizzazione della storia
3.1 Thomas Hobbes, Baruch Spinoza e la fine del
vecchio mondo
3.2 Edmund Burke, tanti-illuminista
3.3 La reazione cattolica
3.4 Immanentismo e Stato assoluto
3.5 Il sofferto pontificato di Pio IX
3.6 Leone XIII e le nuove dottrine sociali della
Chiesa
4. Il Novecento: la configurazione del nuovo Stato
liberale
4.1 Max Weber
4.2 Kelsen, ovvero lo “Stato di diritto”
4.3 Carl Schmitt e il recupero dell’idea religiosa
4.4 L’associazionismo cattolico e Pio X
4.5 Pio XI e i regimi totalitari
4.6 Pio XII, la “ricostruzione”e le ultime vestigia
della Tradizione
5. Il Concilio: riposizionamento interno ed esterno
della Chiesa
5.1 La nuova “ecclesiologia di comunione”
5.2 La “libertà religiosa”
5.3 “La legittima autonomia delle realtà
terrene”
6. Giovanni Paolo II
6.1 Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa
Capitolo III -
«Il Signore piantò un
giardino in Eden»
1. Il progressivo distacco della politica dalla
morale
1.1 La “legge naturale”
1.2 Una morale “relativista”
2. Il pensiero democratico anticattolico
2.1 Claudio Magris, Paolo Flores d’Arcais e Gustavo
Zagrebelsky
2.2 Il risveglio dell’ethos
3. Il saggio sulla "Democrazia nella Chiesa" di
Joseph Ratzinger
3.1 Il rapporto democrazia-morale nel pensiero del cardinal Ratzinger
3.2
Ancora il cardinal Ratzinger sul rapporto fra democrazia politica e
morale
4. Le “condizioni prepolitiche” di Jürgen
Habermas e di Joseph Ratzinger
4.1“Undici tesi”di Flores d’Arcais contro le
«condizioni prepolitiche»
5. Democrazia e Chiesa nel magistero di Benedetto XVI
5.1 L’esortazione apostolica Verbum Domini e
“Gesù davanti a Pilato”
Considerazione
finale
|
aprile 2015
|