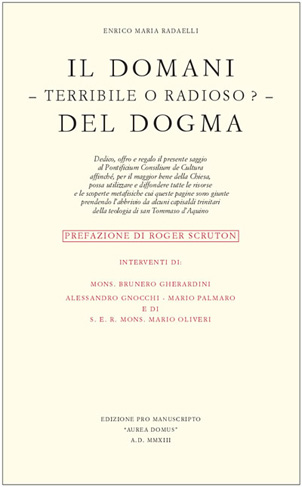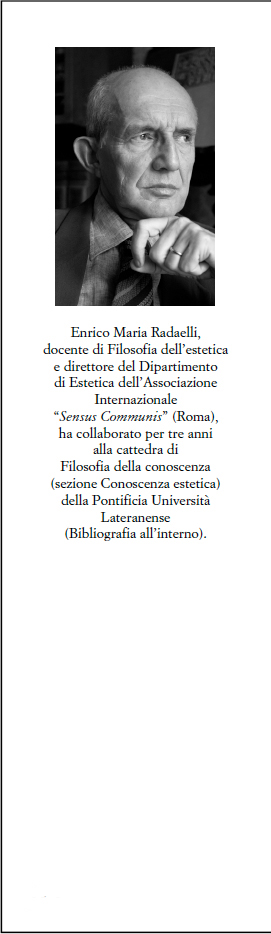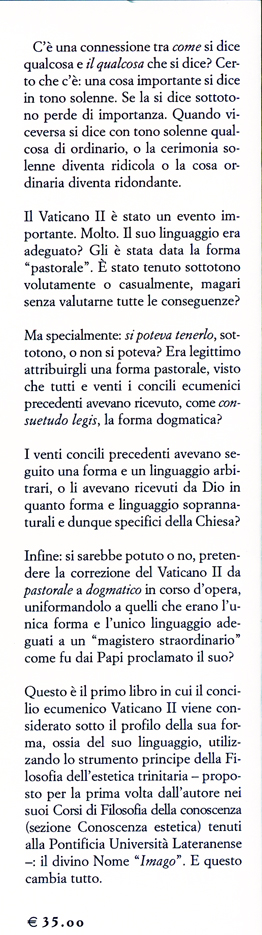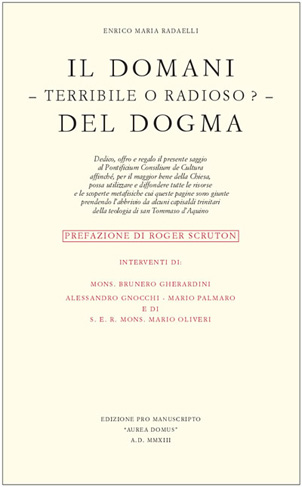
ENRICO MARIA RADAELLI, Il domani - terribile o
radioso? - del dogma,
Pro manuscripto, 2013,
pp. 262, € 35,00.
Contiene:
· LA PREFAZIONE DI ROGER
SCRUTON ·
· INTERVENTO DI S.E.R.
MONS. MARIO OLIVERI ·
· INTERVENTO DI MONS. BRUNERO GHERARDINI ·
· INTERVENTO DI ALESSANDRO GNOCCHI - MARIO PALMARO ·
· IL PERCORSO DEL LIBRO E LA SUA LOGICA·
Il libro è reperibile presso
l'autore (info@enricomariaradaelli.it)
presso la libreria
Hoepli (http://www.hoepli.it/libro/la-bellezza-che-ci-salva/9786009942039.asp)
presso la libreria
Coletti
(http://www.libreriacoletti.it/libro/la-bellezza-che-ci-salva.aspx?p=785685)
Presentazione
nostra
Presentazione dell'Autore
Risguardi di copertina
Il percorso del libro e la sua logica
Gli indici si possono consultare sul sito dell'Autore
Il Prof. Enrico Maria
Radaelli pubblica il suo sesto titolo affrontando questa volta la
problematica dell'importanza del pronunciamento asseverativo del
Magistero della Chiesa cattolica e realizzando quella che Giovanni T.,
nel suo articolo Verità
e Bellezza, Lingua e Volto della Chiesa di sempre, chiama «Un’opera «critica», dunque,
che segna una particolare riflessione sull’essenza della Chiesa uscita
dal Vaticano II sotto l’inesplorato profilo della «forma»
scelta dall’Assise e dai documenti conciliari che ne uscirono - la
pastoralità - che fu anche un modo, e il più immediato ed
appariscente, di manifestare un nuovo stile, un nuovo linguaggio ed un
nuovo vocabolario per la Chiesa del dopo.»
Un lavoro che sviluppa anche, in termini applicativi, la sua ricerca
sul rapporto tra bellezza e verità, che ha già portato
alla pubblicazione
dei suoi tre precedenti lavori: Ingresso alla bellezza,
Sacro al calor bianco
e La Bellezza che ci salva.
Allievo del compianto Prof. Romano Amerio, l'Autore ha contribuito
primariamente e con lodevole perseveranza a tenere acceso l'interesse
del mondo cattolico per questo benemerito studioso delle “variazioni
della Chiesa Cattolica nel XX secolo”, espressione che è
esattamente il
sottotitolo dell'ormai ben noto Iota
Unum, il testo che, pur avvolto nel più profondo silenzio
per tanti anni, è ormai annoverato, nel mondo intero, tra gli
indispensabili testi di riferimento per ogni serio studio su tutta la
problematica relativa alla crisi che attanaglia la Chiesa Cattolica da
cinquan'anni. Questo è stato possibile anche per il lavoro
svolto dal Prof. Radaelli in questi anni: dalla cura del secondo noto
titolo di Romano Amerio, Stat Veritas,
uscito postumo proprio grazie al nostro Autore, alla pubblicazione
dell'interessantissima raccolti di pensieri annotati in quasi 50 anni
da Amerio: Zibaldone,
all'organizzazione di
due importantissime tavole rotonde sulla figura e l'opera di Amerio, a
Lugano e ad Ancona. Di quest'ultima sono stati pubblicati gli Atti: Romano Amerio, il
Vaticano II e le variazioni nella Chiesa Cattolica del XX secolo.
In questo suo nuovo lavoro, l'Autore affronta la cosiddetta
«crisi formale» della Chiesa, come dicono Alessandro
Gnocchi e Mario Palmaro nell'intervento riportato nel libro stesso “Dalla cultura pop alla
Chiesa 'melanchonica'. Il linguaggio dogmatico ai tempi della 'crisi
formale'”: «Questa
nostra povera Chiesa si trova in una condizione inedita della sua vita
e Radaelli la definisce maneggiando con cura termini e concetti
acuminati come quello di “crisi” e di “forma”. Mostra come la
Chiesa di Roma sia toccata dalla malattia nell’intimità
dell’“essere”, ma senza che ne venga mutata l’essenza poiché la
Chiesa cattolica non è passibile di tale mutazione. Basterebbe
questa intuizione per giustificare il libro.»
Lo stesso Autore, nel presentare Il percorso del libro e
la sua logica, scrive che «l’imperatività dogmatica
dell’insegnamento della Chiesa discende direttamente dalla ss.
Trinità e la Chiesa ha come linguaggio suo proprio e “tipico”
precisamente e non altri che il linguaggio dogmatico.»
Considerazione da cui si può partire per giungere a quello che
sostiene Mons. Brunero Gherardini, nel suo intervento riportato nel
libro stesso, Perché sono
d'accordo con il libro di Enrico Maria Radaelli, «Tenendo presente che quello della “forma”,
in effetti, è il valore di fondo che consente all’Autore di
sviluppare le sue riflessioni, queste vengon da lui rivolte anzitutto
alla soluzione del problema ermeneutico del Vaticano II e quindi ai due
modelli in atto dal Vaticano II in poi: l’uno, « ipodogmatico
» e disposto perfino a snaturare il contenuto del dogma nel
cosiddetto linguaggio pastorale, l’altro autenticamente e
tradizionalmente dogmatico come linguaggio proprio dell’insegnamento
ecclesiale.»
Riflessione rafforzata da quanto scrive S. Ecc. Mons. Mario Oliveri nel
suo Qualche annotazione per
il lettore circa il libro di Enrico Maria Radaelli “Il domani del dogma”,
anchesso riortato nel libro, «Da
cosa sarebbe causato il “domani terribile” che paventa l’Autore?
Dall’aver operato in modo (in Concilio e fuori del Concilio) da privare
l’Assise Ecumenica del suo carattere più vero, quello più
consono alla sua natura, più consono a ciò che un
Concilio Ecumenico è sempre stato nella vita della Chiesa, e che
non può non essere nella vita della Chiesa, e tale carattere
è la qualifica di ‘Dogmatico’.»
Per offrire un’anticipazione del testo e dello stile dell’Autore,
abbiamo riprodotto la prima parte della presentazione del libro, che
può leggersi per intero sul sito dell'Autore.
Corre l’obbligo di segnalare anche gli altri scritti di Enrico Maria
Radaelli, di cui si può avere ampia notizia nell'apposita pagina
del suo sito “Aurea
Domus”.
|
Presentazione dell'Autore
(prima parte)
(Qui
l'intera presentazione)
La prima domanda che
uno si fa è: perché mai uno che si occupa di estetica si
mette a discettare sul dogma? cosa c’entra una cosa seria come il dogma
con l’estetica?
Risposta: perché si dà il caso che la
bellezza viva di verità. Niente verità, niente bellezza.
La bellezza spilla allegra solo dalla fontana della verità. Ma
la bellezza oggi è rovinata dalle scorrerie di vandali e
arcivandali fin nelle chiese, e ciò perché la fontana
della verità oggi si è inaridita, la Chiesa ha stretto i
rubinetti della verità, l’ha ipodogmatizzata, dedogmatizzata,
con un linguaggio che quasi non è più il suo.
Da quando la Chiesa ha ipodogmatizzato e
dedogmatizzato il suo linguaggio? È ciò che si
scoprirà nel libro. Di certo si può dire che tutto ruota
intorno all’evento culmine del secolo XX: il famoso Concilio ecumenico
Vaticano II.
Parlando però di linguaggio, viene da sé
che della cosa se ne debba occupare un filosofo di estetica. Per cui
questa è la prima volta che il concilio Vaticano II viene
analizzato sotto il profilo della sua forma, che è a dire del
suo linguaggio, e Il domani –
terribile o radioso? – del dogma è il primo libro che
per far ciò usa uno strumento del tutto nuovo, mai usato prima,
per quanto sia stato “scoperto” da più di 700 anni, e “scoperto”
da un pensatore come san Tommaso, sto parlando di Imago, Immagine (o Volto, Species, Aspetto).
Imago, che
con Logos, Splendor e Filius, è una delle quattro
qualità sostanziali del Monogenito di Dio, è il
formidabile, specialissimo strumento della Filosofia dell’estetica
trinitaria, che stringe bellezza a verità, linguaggio a forma, e
rende evidente il nesso tra volto e anima, tra bellezza e
verità, intuito dai tempi di Platone: il nesso c’è, ed
è divino: è Imago.
Il domani del dogma è il
primo saggio che, muovendo dalle antiche e severe stanze della
filosofia della conoscenza, per salire (come insegna la metodologia
esigente e angolare di Antonio Livi), ai piani alti della teologia,
ciò compie con gli occhi, per così dire, della conoscenza
estetica, ossia attraverso l’analisi del linguaggio e della forma di
insegnamento utilizzati dal magistero della Chiesa a partire dal
Vaticano II.
È così che, col rigore scientifico
massimo, si può giungere a enunciare: la presente grave e
pericolosa crisi che sta soffocando la verità nella Chiesa
è una crisi ‘formale’.
Dichiarare che la crisi
della Chiesa è formale, e portarne le cause, è decisivo,
perché senza la giusta diagnosi non si guarisce dal male, ma lo
si aggrava: individuare la diagnosi giusta è essere già a
metà dell’opera.
Ma come fa una crisi
della Chiesa a essere ‘formale’ senza intaccare la sopravvivenza della
Chiesa? Non si rende conto forse l’autore della contraddizione in
termini? Ed è qui che, allievo di Romano Amerio, posso calare
quel che si direbbe il primo carico da undici, e mettere finalmente a
nudo la più vera verità mostrando che, a riguardo del
Vaticano II, non esistono solo, come dicono, ‘un’ermeneutica della
rottura’ e ‘un’ermeneutica della riforma nella continuità’, ma
una terza ermeneutica, individuata da quel grande filosofo cattolico,
la quale terza è però un’ermeneutica, ahimè,
schizoide, dubbia, schizofrenica: de
voce (a parole) tutta in continuità con la Tradizione, ma
de facto (nei
fatti) in totale rottura.
Questa impietosa, ma
assolutamente necessaria e chirurgica sollevazione dei lembi della
pelle del linguaggio (o forma) sulla carne viva della Chiesa, compiuta
sull’infezione ‘formale’ e dunque totale che ha intaccato il corpo
storico della Chiesa col Vaticano II, è il cuore del cuore del
libro.
|
Risguardi di copertina
(torna su)
I capitolo. Ogni ente ha
il suo essere nella forma. Se dunque si dimostra (§§ 1-9) che
la forma di un certo ente è in qualche modo mancante, lo
sarà anche il suo essere e quell'ente è nullo. Si applica
qui dunque per la prima volta il processo ‘formale’ al Vaticano II,
tanto più se per ‘forma’ si può intendere, come qui si
dimostrerà corretto intendere, sia il nous o contenuto di un
ente che il suo aspetto o linguaggio.
In particolare, si potrà capire che tutti i mali di cui oggi
soffre la Chiesa in ogni ambito dipendono da un ‘male totale’ che tutti
li origina: il male formale,
il male della Chiesa di essere da cinquant’anni forzata a presentarsi
per una Chiesa che, svuotata di sé, né è,
né può essere; forzata a presentarsi, vano ma ostinato
tentativo, 'Chiesa pastorale’ (ma è ‘finto-pastorale’: è iperpastorale) invece che Chiesa
dogmatica, invece cioè che quella Chiesa dogmatica che
metafisicamente sempre è stata e che, salvo por mano
dogmaticamente alla sua dedogmatizzazione, sempre e necessariamente
sarà (§ 5).
Per prima cosa va verificata (§§ 10-15 b) l’esistenza della
correlazione biunivoca tra nous e aspetto, che è a dire tra
Verità e Bellezza. La si trova nella ss. Trinità, dove Logos e Imago coincidono nel Figlio. A Logos si dimostra corrispondere la
Verità come a Imago la
Bellezza, e a tutti e quattro una certa interscambiabilità. La
conclusione (§ 16-16 a) è che la forma del Vaticano II
può essere giudicata dal linguaggio dei suoi documenti, conformi
alla sua essenza come la Verità alla Bellezza, cioè il
contenuto al suo aspetto: se esso è “proprio”, anche la forma
del Vaticano II sarà “propria”; se non lo è, non lo
sarà neanch’essa.
Per secondo si verifica (§§ 17-18) se esista e che linguaggio
sia un linguaggio divino, un linguaggio cioè intrinseco all’essere e alla ss. Trinità.
Esso esiste, si chiama “Linguaggio dogmatico” e serve a far conoscere
il Padre alle creature (e, nella Trinità, a contemplarlo,
§§ 19-20). Da esso discende ogni altro linguaggio umano:
tutti meno perfetti ma tutti necessari alla completezza della
conoscenza delle cose, fino all’ultima: quella del Padre. Esso è
dato da Imago, il linguaggio
di Logos, che è a dire
la Bellezza della Verità; dunque è lo stesso Cristo,
incarnazione di Logos/Imago
(§§ 21-21 c).
Si può (si deve) concludere il I capitolo con la constatazione
che (§ 22) l’imperatività dogmatica dell’insegnamento della
Chiesa discende direttamente dalla ss. Trinità e la Chiesa ha
come linguaggio suo proprio e “tipico” precisamente e non altri che il
linguaggio dogmatico.
II capitolo.
Originalità totale del linguaggio dogmatico della Chiesa
nell'infinita varietà delle sue specifiche modalità
manifestative; sua specifica caratura (§ 23). Analisi di alcuni
aspetti salienti del linguaggio dogmatico, da distinguere dal teologico
(§ 24): è il più tipico linguaggio dell'amore
(§ 25); è naturale e non artefatto (§ 26); è
sommamente cristico (§ 27); è per natura autoritativo e
obbligativo (§§ 28-32).
Riconosciute le basi teologiche, anzi tomistiche, del “linguaggio
tipico” della Chiesa (dogmatico,
asseverativo e obbligativo), eccone i fondamenti
scritturali, limitati al NT (§ 33).
Mostra della diversità di linguaggio usato nella Chiesa dal
Vaticano II in qua e di quanto la sua natura, anche a parere degli
stessi novatori, incida sulla forma dello stesso (§ 34) e persino
sull’ordine logico-normativo della realtà (§§ 35-6);
infatti tutti i concili ecumenici della Chiesa hanno costantemente
usato una forma e un linguaggio sempre e solo dogmatici (§ 37),
mentre la forma e il linguaggio del Vaticano II non sono propriamente
nemmeno “pastorali” (§ 38).
Opposizione dei due modelli teoretici di Chiesa presenti dopo il
concilio, il dogmatico e il non-pastorale (§§ 39-41).
Si possono così illustrare le cause per cui sono state
congetturate la forma non-pastorale e le sue risultanze del tutto vane,
che pongono la Chiesa in un vicolo cieco (§§ 42-5).
Illustrazione della fondamentale
tesi di Romano Amerio sul rapporto Chiesa/Verità, tesi
che è a base dell’individuazione della via – dell’unica via –
per far uscire la Chiesa dalla crisi che la sta stringendo da
cinquant’anni (§ 46) tra i due cippi liberali chiamati « Dislocazione della divina Monotriade
», e « Ambiguità
tra rottura de voce e
continuità de facto » (§ 46 a), posto che
né si può cancellare il “vecchio” modello teoretico,
basato sul linguaggio dogmatico, né formalizzare il nuovo,
basato sul non-pastorale (§ 47), possibile esito, questo, di
peccati contro la verità – verificandone la possibilità
almeno teorica – compiuti anche dagli ultimi Papi (§ 48).
Per tirare alle conclusioni, è rivisitato in chiave
estetico-linguistica il nesso uomo/realtà dato dalla nota
affermazione aristotelico-tomista « veritas est adæquatio rei et
intellectus » (§§ 49-9 b), così da
mostrare in tutta la sua forza la necessità del ritorno a un munus docendi impostato sul dogma
(§§ 50-2), anzi, propriamente – posto che il vero
responsabile della crisi è il linguaggio –, sul linguaggio del dogma (§
53).
Ma la Chiesa non può ritrovare la pace senza recuperare la sua
nota di “unità di spirito”, per cui tradizionisti e novatori
debbono sapersi incontrare nella carità, ossia combattere le
proprie idee senza sbranarsi a vicenda (§ 54).
III capitolo:
conclusioni. Si articolano in una considerazione generale e in quattro
specifiche: dimostrato che un linguaggio della Chiesa esiste, che
è di origine divina, che è stato volutamente tralasciato
dal Vaticano II in poi optando per una forma linguistica (e, da
ciò, sostanziale) radicalmente inadeguata al grado del suo
magistero, bisogna riconoscere che il primo strumento che muove e
cambia la Chiesa, e da essa il mondo, è il linguaggio,
sicché la Chiesa deve riprendere a parlare col suo linguaggio
d’amore, il dogmatico, abbandonando la “lingua di legno” artefatta e
ingannevole usata in sua vece (§ 55), giacché i due modelli
teoretici di Chiesa sortiti dal Vaticano II sono irriducibili uno
all’altro (§ 55 a), per cui si renderà necessario che il
magistero del Papa torni al suo stato ordinario, al primo modello,
tutt’uno col dogma (§ 55 b); ciò egli può fare
attraverso la via, qui vista unica per validità intrinseca ed
estrinseca, dedotta dalla tesi di Amerio, (§ 55 c); si spera siano
presto molti i vescovi che auspichino venga percorsa tale via e che,
per il bene della Chiesa e come unico vero servizio all’alto magistero
del Papa, ne incoraggino la migliore e più celere riuscita
(§ 55 d).
Conclude una riflessione “fuori
campo”, per la quale quello illustrato parrebbe il solo modo per
prepararsi ad affrontare (e non sarà fra un secolo) un Vaticano
III, sapendo che la forma non-pastorale con cui i novatori lo vorranno
aprire andrà rigettata in
toto come del tutto impropria al munus del suo insegnamento, dunque
invalidante il medesimo (§ 56).
Illustrazione infine (§ 57) dei motivi per cui il libro è
stato dedicato al Pontificium
Consilium de Cultura.
(ottobre 2013)
|