 |
 |
| LA RIPROVAZIONE D’ISRAELE NEL
VANGELO
Prima parte Articolo di Don Curzio Nitoglia La parabola del fico secco (Mt., XXI, 18-22) 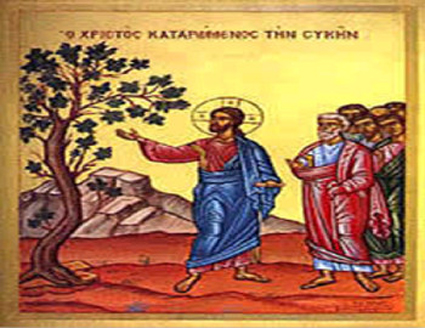 Introduzione
Il lunedì dopo la Domenica delle Palme, Gesù andò da Betania (ove si era ritirato) a Gerusalemme. Lungo la strada vide un fico e, non avendovi trovato alcun frutto, lo maledisse. Giunto a Gerusalemme entrò nel Tempio, da cui espulse i venditori che lo profanavano. In questo stesso giorno rese la vista a due pagani che erano ciechi, a sera ritornò a Betania. Il martedì, tornando a Gerusalemme e contemplando il fico che si era seccato, istruì gli Apostoli sull’efficacia della preghiera. Poi, essendo entrato nel Tempio, dette luogo alle grandi polemiche con gli scribi e i farisei. Questa polemica di Gesù con gli scribi e i farisei costituisce un nucleo omogeneo di parabole sulla riprovazione d’Israele, che sono commentate da san Paolo nell’Epistola ai Romani. Di qui l’importanza di contemplare il Vangelo di Matteo alla luce di san Paolo, commentato da san Tommaso per far un po’ di chiarezza su un tema, che in questi tempi di confusione e di “grande apostasia”, non è più presentato ai fedeli come la Tradizione patristica l’ha unanimemente letto. Giuseppe Ricciotti
L’Abate Giuseppe
Ricciotti, nella sua celeberrima Vita
di Gesù Cristo scrive: «Gesù
s’avvicinò a un albero di fico che stava presso la strada ed era
lussureggiante di foglie […], e cercò tra il fogliame se c’erano
frutti; ma, frutti non ce ne erano e non potevano esserci, per la
semplice ragione che non era la stagione dei fichi […]. L’albero […]
[aveva] gettato i primi bocci, i cosiddetti fichi/fiori […]. Volendo
allora giudicare quell’albero come se fosse stato una persona morale e
responsabile, bisognerebbe dire che esso non era colpevole, se non
aveva frutti in quella stagione: in realtà, Gesù cercava
ciò che, regolarmente, non poteva trovare. Con tutto ciò,
egli maledisse quell’albero
dicendo: “Mai più in eterno nessuno mangi da te frutto”! Tutte
queste considerazioni ci confermano che Gesù volle compiere
un’azione che aveva valore simbolico […]. In questo caso dell’albero il
simbolo prendeva argomento dal contrasto
tra l’abbondanza del fogliame inutile e la mancanza dei frutti utili,
dal medesimo contrasto era anche giustificata la maledizione all’albero colpevole
[…]. Il vero colpevole [cui
si riferiva l’insegnamento simbolico, ndr] era il popolo eletto, Israele, ricchissimo
allora di fogliame farisaico ma ostinatamente privo da lungo tempo di
frutti morali, e quindi meritevole della maledizione di
sterilità eterna” (1).
Severiano del Paramo
Padre Severiano del
Paramo nel suo Commento al Vangelo
di Matteo (Roma, Città Nuova, 1970) scrive che
l’intenzione del Signore era quella di “manifestare, mediante un’azione
allegorica, la sorte che sarebbe toccata agli Israeliti e a Gerusalemme
per la loro incredulità. La raffigurazione del popolo ebreo in
un albero fruttifero non è rara nell’Antico Testamento. Come si
vede, quest’azione di Gesù, puramente simbolica, cioè
senz’altro scopo che quello di rappresentare in maniera percepibile ai
sensi la sorte che sarebbe toccata al popolo ebreo, non era un genere
sconosciuto per gli Apostoli. Per essi il fico era una chiara immagine del popolo
ebreo che, nonostante la provvidenza specialissima con cui Dio lo aveva
governato e soprattutto la predicazione e i miracoli di Gesù,
non aveva maturato i frutti desiderati, non solo ma stava affliggendo
il cuore misericordioso di Gesù con la sua persistente
incredulità: meritava, dunque, la maledizione di Dio. È
il mistero della riprovazione del popolo eletto, su cui
più tardi san Paolo verserà lacrime amare (cfr. Rom., IX, 1 ss. ; XI, 5 ss.)”
(cit., p. 311).
I Padri della Chiesa
I Padri della Chiesa (il cui consenso unanime nell’interpretazione della Scrittura è regola infallibile della fede) spiegano questa parabola nel seguente modo: le foglie sono “simbolo del culto farisaico, con cerimonie senza frutto di buone opere” (S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matth. hom. 68; come anche S. ILARIO, In Matth. can. 21): “La vera virtù religiosa che è viva e dà la vita soprannaturale, inaridita in Giudea, passa ai Gentili” (ORIGENE, In Matth. tract. 16). “Il fico secco rappresenta chi ha la fede senza le opere; infatti, esso è un albero con frascame senza alcun frutto. Ma Dio gli chiede conto delle opere e dei frutti che avrebbe dovuto portare; e come pena della sua sterilità colpevole lo lascerà inaridire totalmente” (ORIGENE ibidem; cfr. anche sant’AGOSTINO, De cons. ev. II, 68). Tale parabola la troviamo anche nel Vangelo di san Marco (XI, 13-21). Gli stessi Padri ne hanno data la medesima interpretazione, in più vi sono i commenti di Beda il venerabile (super Dimiserunt eis; super Invenerunt pullum alligatum), Teofilatto (In Matth.), S. Ambrogio (super Lucam, lib. 9), san Girolamo (super Misit duos), tutti concordano nel veder nel fico maledetto Israele che non ha voluto accettare Cristo e portare frutti di opere buone. Dunque, è chiaro che il giudaismo post-biblico, nella divina Rivelazione, è presentato - da Gesù stesso - come un “fico infruttuoso” maledetto che diventa “secco” e viene poi condannato anche al fuoco; di qui l’espressione corrente “valere un fico secco” ossia nulla, perché il fico è un ottimo albero che porta frutti squisiti, ma se sterile e per di più seccato o secco non porta frutti e vale nulla, vale a dire è un fico secco, né più né meno. Fine prima parte
continua NOTE
(torna
su)
aprile 2023 |