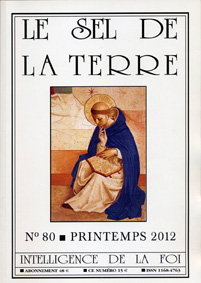|
||
 |
||
| S. Ecc. Mons. Bernard Tissier de Mallerais della Fraternità Sacerdotale San Pio X CHE COS'E' UN CONCILIO PASTORALE? PARTE SECONDA
Indice Parte Prima Parte Seconda Parte Terza - Inconvenienti di una presentazione «pastorale» della dottrina della fede - Del linguaggio pastorale si fa un linguaggio ambiguo - Il linguaggio pastorale, linguaggio del pensiero cosiddetto «moderno» - La dottrina della fede a rischio della filosofia soggettivista - La dialettica hegeliana al servizio dell’evoluzione della dottrina della fede - L’intenzione originaria del Concilio: assimilare i valori liberali - Il padre Congar, profeta del Concilio, patrocina la «purificazione» dei valori liberali - Paolo VI: il Concilio ha «rispettato, purificato e benedetto» le aspirazioni liberali - Joseph Ratzinger: il Concilio ha acquisito i valori liberali debitamente epurati e corretti - Il procedimento di purificazione-assimilazione è condannato dalla Chiesa - Una contro intenzione che priva il Concilio dell’autorità magisteriale - In che consisterebbe la vera purificazione dei «valori » liberali? - Kant, Husserl, Blondel e Buber possono succedere a San Tommaso d’Aquino? Rispondiamo ponendo tre nuove questioni. In primo luogo, come temeva già il Card. Billot sotto Papa Pio XI, un concilio nell’epoca post-modernista e laicista non sarebbe stato il campo ove si sarebbero affrontati pubblicamente veri cattolici e liberali? Questi ultimi, non avrebbero cercato di «approfittare degli stati generali della Chiesa per fare la rivoluzione, un nuovo 1789 (45)»? Un’assemblea di duemila membri non sarebbe stata facilmente manovrata da una minoranza di membri ben organizzata. E i media non avrebbero diffuso le loro tesi? E lo stile sedicente pastorale dei testi conciliari non sarebbe stato meno preciso e quindi più permeabile alle nuove idee? Evidentemente, la risposta era affermativa. In secondo luogo, che cosa avrebbe implicato un’esposizione «più ampia» del sacerdozio? L’abbiamo già detto: certi teologi degli anni cinquanta si lamentavano della maniera «molto parziale» con cui il sacerdozio era stato trattato dal concilio di Trento, vale a dire in rapporto all’Eucarestia (46). Adesso occorre, dicevano, riequilibrare il sacerdozio in rapporto al sacramento del Battesimo e ricollocare il sacerdozio in rapporto all’intero Corpo Mistico. È ciò che farà il Concilio, distinguendo il «sacerdozio comune dei battezzati» dal «sacerdozio ministeriale» dei sacerdoti (47). Il che non è falso, ma il pericolo stava nel vedere nel «sacerdozio comune» un sacerdozio in senso proprio – quando invece lo è solo in senso metaforico – e nel «sacerdozio ministeriale» una fioritura del primo! Non significa cancellare l’essenza del sacerdozio, che è il potere di consacrare il Corpo e il Sangue di Cristo e per ciò stesso riprodurre, sacramentalmente, il sacrificio di Cristo sull’altare? In terzo luogo, cos’è che si profilava dietro la lode della «precisione» del linguaggio dei precedenti concilii, se non proprio l’intenzione di non usare questa precisione? L’auspicio di una dottrina meglio conosciuta e più profondamente assimilata supponeva, dunque, l’abbandono della «precisione dei termini» e l’adozione di un linguaggio impreciso, poiché dal linguaggio preciso si differenzia solo il linguaggio approssimativo. Ed è questo linguaggio impreciso che Giovanni XXIII descriveva dicendo: «si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale (48)». Emerge dunque che l’insegnamento sedicente pastorale di un concilio ecumenico negli anni sessanta era esposto a dei gravi pericoli riguardo alla sua funzione magisteriale. (su)
17. Vediamo quale sarà esattamente questo linguaggio pastorale. Esso non sarà né il linguaggio della teologia, né quello di tutti i concilii precedenti, né il linguaggio dei catechismi, troppo preciso, ma un linguaggio forse più biblico, più patristico, in ogni caso meno tecnico, in cui si trascurerà di definire i termini. Un linguaggio che si presterà, dunque, all’ambiguità. - Un primo esempio tra gli altri, è dato dal termine «mondo», che significa sia l’universalità degli uomini, sia il dominio del peccato, sia l’insieme delle anime da conquistare a Cristo, sia lo spirito di disubbidienza e di rivolta contro Gesù Cristo, sia tutto questo insieme. Senza definire di che mondo si volesse parlare, cosa poteva esprimere la costituzione pastorale Gaudium et spes «Sulla Chiesa nel mondo contemporaneo», se non una dichiarazione equivoca? - Un secondo esempio di linguaggio equivoco è dato dall’insegnamento sulla collegialità episcopale: il Concilio insegna che il collegio dei vescovi, sotto il suo capo, il Papa, è «il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa» (49). Benché il testo conciliare precisasse i modi d’esercizio di questo potere collegiale, fu necessario precisare ulteriormente, con una «nota esplicativa previa» (50) - cosa che è il colmo della vergogna per un atto magisteriale - che il collegio «non agisce permanentemente», ma solo «ad intervalli» e «col consenso del capo». E non si precisava neanche se questo potere fosse di diritto divino o umano, cosa che costituisce il dubbio essenziale su questa nuova dottrina. - Un ultimo esempio di linguaggio equivoco è dato dal termine «sacramento», usato per descrivere la Chiesa: come «sacramento visibile di questa unità salvifica» e «sacramento dell’unità di tutto il genere umano» in Cristo (51). Ora, un sacramento è un segno sacro, efficace, indubbiamente, ma che deriva solo dalla causalità esemplare ed efficiente. La Chiesa non può essere ridotta alla funzione di polo di unità, essa è formalmente il corpo di Cristo, al quale tutti gli uomini e ciascuno di essi individualmente devono essere incorporati come membri, per essere salvati. Inoltre, San Cipriano, citato in nota al n. 9, 3 di Lumen gentium, usa l’espressione «unitatis sacramentum» per indicare la Chiesa come mistero di unità (52) e non come sacramento di unità, quanto meno non principalmente e nient’affatto come sacramento dell’unità del genere umano nella sua globalità: idea questa che appartiene all’idealismo platonico. 18. E allora noi poniamo la domanda: quale sorta di autorità ha un magistero che scade nell’imprecisione del linguaggio e perfino nell’equivoco, fino al platonismo, pur pretendendo di rispettare l’integrità del deposito della fede? Sicuramente non si tratta dell’autorità del magistero di cui il Papa Pio IX enuncia le qualità obbligate: fedeltà al deposito e progresso nella precisione: Infatti la Chiesa di Cristo,
fedele custode e garante dei dogmi a lei affidati, non ha mai apportato
modifiche ad essi, non vi ha tolto o aggiunto alcunché, ma
trattando con ogni cura, in modo accorto e sapiente, le dottrine del
passato per scoprire quelle che si sono formate nei primi tempi e che
la fede dei Padri ha seminato, si preoccupa di limare e di affinare
quegli antichi dogmi della Divina Rivelazione, perché ne
ricevano chiarezza, evidenza e precisione, ma conservino la loro
pienezza, la loro integrità e la loro specificità e si
sviluppino soltanto nella loro propria natura, cioè nell’ambito
del dogma, mantenendo inalterati il concetto e il significato (53).
(su)
19. In realtà, questo linguaggio, oltre a tenere il partito preso dell’imprecisione, sarà il linguaggio del pensiero moderno, poiché Giovanni XXIII spiegava che: occorre che questa dottrina
certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia
approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri
tempi. [Gaudet Mater Ecclesia]
Ma un qualunque magistero ha solo il dovere di «prestare un assenso fedele» alla dottrina? Ci si è preoccupati di dichiararla «immutabile», è vero; si è confermato che sarà «approfondita», e sia; ma non era necessario che le vedute profonde ed elevate dei Padri nuocessero all’insegnamento delle verità del semplice catechismo! In realtà, questa dottrina dichiarata immutabile, il Concilio la rivestirà di una «forma» nuova, della strana impronta del pensiero moderno: Altro è infatti –
diceva Giovanni XXIII - il deposito della Fede, […] altro è il
modo con il quale esse [queste verità] sono annunziate, sempre
però nello stesso senso e nella stessa accezione. [Gaudet Mater
Ecclesia]
Questa distinzione è capziosa. Vero è che il magistero aveva sempre mirato a migliorare la forma dei suoi insegnamenti, ma sempre nel senso di una maggiore distinzione dei concetti e di una migliore precisione dei termini, e questo, come abbiamo già detto, non per adattare la dottrina all’auditorio moderno, ma per adattare un auditorio attuale alla dottrina eterna. E la pastorale era sempre consistita in questo: elevare gli spiriti verso le realtà superiori. Per far questo, il magistero aveva sempre usato un linguaggio selezionato: il linguaggio teologico e la formulazione scolastica, che sono quelli della filosofia realista, della filosofia dell’essere, la quale fa uscire l’uditore dal suo «io», per condurre il discepolo verso le realtà extra mentali e così poterlo elevare verso i misteri divini, che sono l’essere stesso oggettivo di Dio e non la creazione soggettiva dello spirito. Che poteva accadere invece se il Concilio avesse voluto usare il pensiero moderno? Perché è proprio così che esso ha voluto esporre la dottrina cattolica, come spiegò subito Giovanni XXIII in un discorso successivo: lo spirito cristiano,
cattolico ed apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi
verso una penetrazione dottrinale e una formazione più viva
delle coscienze, in perfetta fedeltà alla autentica dottrina; ma
questa studiata ed esposta attraverso le forme della indagine e della
formulazione letteraria del pensiero moderno (54).
(su)
20. Ora, il pensiero moderno è essenzialmente soggettivista, erede dell’agnosticismo del filosofo di Königsberg, Emmanuel Kant (1724-1804). Esso vede nelle idee che abbiamo delle cose e nei principi che teniamo rispetto ad esse, non l’essenza o la natura di queste cose – che pretende essere inconoscibile – ma il nostro modo di percepirle. L’oggetto non è mai l’oggetto in sé, ma l’oggetto come è percepito secondo le nostre categorie mentali e i nostri stati d’animo. Al linguaggio realista dell’essere, esso preferisce la «formulazione letteraria» della coscienza, che è quella del soggettivismo; e al linguaggio della finalità, esso preferisce la formula del compimento di sé (GS, 74, 11), che è quella dell’esistenzialismo. Quindi, piuttosto che contemplare il dogma, esso preferirà esprimere la reazione vitale del credente al cospetto del dogma proposto dalla Chiesa. All’insegnamento dottorale del dogma da parte della Chiesa, esso preferirà l’espressione della coscienza che ne ha la Chiesa. Già Pio XII aveva denunciato, nel 1950, la pretesa di certi teologi di utilizzare, come strumento di investigazione teologica, la filosofia moderna al posto di quella di San Tommaso: Perciò è
quanto mai da deplorarsi che oggi la filosofia confermata ed ammessa
dalla Chiesa sia oggetto di disprezzo da parte di certuni […] essa non
può darci - aggiungono - un metodo ed un indirizzo filosofico
che risponda alle necessità della nostra cultura moderna.
Oppongono, inoltre, che la filosofia
perenne non è che la filosofia delle essenze immutabili,
mentre la mentalità moderna deve interessarsi della “esistenza”
dei singoli individui e della vita sempre in divenire. Però,
mentre disprezzano questa filosofia, esaltano le altre, sia antiche che
recenti, sia di popoli orientali che di quelli occidentali, in modo che
sembrano voler insinuare che tutte le filosofie o opinioni, con
l’aggiunta - se necessario - di qualche correzione o di qualche
complemento, si possono conciliare con il dogma cattolico. Ma nessun
cattolico può mettere in dubbio quanto tutto ciò sia
falso, specialmente quando si tratti di sistemi come l’immanentismo,
l’idealismo, il materialismo, sia storico che dialettico, o anche come
l’esistenzialismo, quando esso professa l’ateismo o quando nega il
valore del ragionamento nel campo della metafisica (55).
Pio XII stabilì anche che per la Chiesa era cosa negativa l’uso dell’evoluzionismo, dello storicismo e del soggettivismo, e se fosse passato ancora qualche anno sarebbe stato escluso anche il personalismo. Ebbene, 12 anni dopo, il suo successore, Giovanni XXIII, pretenderà che il Concilio debba usare le «formulazioni letterarie» dello spirito moderno… E sessant’anni dopo, Benedetto XVI conferma la necessità di questa formulazione sempre da adattare e necessariamente fluente della dottrina della fede da parte del magistero. Interrogato sulla Chiesa e il mondo moderno, ecco quello che ha risposto: Ma come ho detto, in questo
grande contesto la religiosità deve rigenerarsi e trovare
così nuove forme espressive e di comprensione. L’uomo di oggi
non capisce più immediatamente che il Sangue di Cristo sulla
Croce è stato versato in espiazione dei nostri peccati. Sono
formule grandi e vere, e che tuttavia non trovano più posto
nella nostra forma mentis e nella nostra immagine del mondo; che devono
essere per così dire tradotte e comprese in modo nuovo (56).
E quello che era allora il professore universitario Joseph Ratzinger, spiegava ai suoi allievi, nel 1967, che l’espiazione di Cristo sulla Croce non doveva più essere considerata come la sua sostituzione a noi per subire al nostro posto la pena dei nostri peccati e soddisfare così la giustizia divina, ma doveva essere interpretata come la sua sostituzione all’uomo per amare al suo posto: Se tuttavia nel nostro testo
si afferma ancora che Gesù ha operato la redenzione col suo
sangue (Ebr. 9, 12), questo
sangue non va inteso come un dono materiale, come un mezzo espiativo da
misurarsi quantitativamente, bensì come la pura concretizzazione
di quell’amore che ci viene additato come spinto fino all’estremo […]
Il culto cristiano […] si esplica nella nuova forma di funzione vicaria
[sostituzione] inclusa in quest’amore: nel fatto che egli si è
incaricato di rappresentarci e noi ci lasciamo impersonare da lui. Esso
comporta pure che noi ci decidiamo una buona volta ad accantonare i
nostri conati di auto-giustificazione (57).
Dunque la dottrina della redenzione dovrebbe essere rivista e corretta per farla quadrare con il pensiero moderno restio all’espiazione riconciliante, ma in sintonia con l’amore che si dona, caro alla fenomenologia di Max Scheler (1874-1928) e all’esistenzialismo di Sören Kirkegaard (1813-1855) e di Karl Jasper (1883-1969). Il dono che Dio fa all’uomo con la persona e l’amore crocifissi di Cristo, basta a riconciliare l’uomo, non c’è più bisogno che l’uomo si riconcilii con Dio con una soddisfazione. È Dio che ha fatto tutto, l’uomo non deve fare più niente per la sua redenzione, se non accogliere il dono di Dio. Ci si ritrova con la teoria protestante della redenzione. Allo stesso modo, tutti i dogmi e tutta la dottrina della fede devono essere periodicamente riadattati alla mentalità corrente. Benedetto XVI conferma così ciò che sappiamo già dell’intenzione del concilio Vaticano II: il Concilio non ha avuto lo scopo di riaffermare la dottrina immutabile nel mondo moderno, ma quello di integrarla nei nuovi modi di pensare moderni. Mentre la Chiesa ha sempre lavorato per cambiare le mentalità e adattarle alla saggezza di Dio incarnato in Gesù Cristo (cosa che hanno fatto tutti i missionari), il Concilio ha cambiato la saggezza di Dio per adattarla alle mentalità del mondo (58). San Paolo insegna che la fede ci fa comprendere che i secoli sono stati organizzati e adattati secondo il piano della saggezza divina (Ebr. 11, 3); il Concilio invece ha voluto riscrivere questo piano divino per adattarlo al secolo scorso, che fu tanto transitorio quanto ribelle a Dio. Quale autorità magisteriale si oserebbe attribuire a questa empia audacia? Non significa mettere nello stesso magistero della Chiesa l’uomo al posto di Dio? In effetti, le «forme della indagine» del deposito della fede, il Concilio non le ha piuttosto concepite come forme di inversione e di sovversione della fede? (su)
21. Del pari, al metodo scolastico del sillogismo che assiste le verità di fede con lo strumento degli alti principi della ragione (59), per ricavare o dedurre da queste verità di fede altre verità coerenti con esse, il pensiero moderno preferisce un'altra «forma di indagine»: il metodo dialettico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hegel ritiene di avere scoperto che ad ogni proposizione, per il fatto stesso della sua affermazione, si opponga il suo contraddittorio. Per risolvere la loro contraddizione, lo spirito opera una «sintesi» delle contraddizioni, con la quale la tesi originaria viene ripresa, arricchita dall’antitesi. E siccome sorgono continuamente nuovi fatti o nuove affermazioni che contraddicono le precedenti, la verità evolve senza fine. E questa evoluzione, detta storicismo, è inerente alla dimensione storica nella quale vive la verità. Una illustrazione di questo procedimento dello spirito è fornita dal materialismo dialettico di Karl Marx: Il materialismo dialettico
è la teoria generale del partito marxista-leninista. Il
materialismo dialettico è così chiamato perché il
suo modo di considerare i fenomeni della natura, il suo metodo di conoscenza e di indagine
è dialettico, e la sua interpretazione, la sua concezione
dei fenomeni della natura è materialista (60).
Certo, il Concilio non adottò il materialismo di Marx, ma non rifiutò di usare il metodo «di indagine» dialettico di Hegel, applicato alla storia della dottrina della fede. Le mutazioni della libertà religiosa illustrano l’uso che il Concilio fece di questa dialettica logica e storica. Lo vedremo più avanti. Riassumiamo qui l’intenzione di Giovanni XXIII, espressa all’apertura del Concilio: il pericolo non era la persecuzione comunista, ma una fede superficiale e una perdita di passo della Chiesa in rapporto al mondo. Bisognava dunque: ad intra approfondire la verità rivelata e impregnarne le anime, e ad extra presentare la Chiesa al mondo in una maniera adattata: in poche parole, la Chiesa necessitava di un cambiamento «pastorale» che presentasse la Chiesa stessa e la sua dottrina secondo le idee e gli schemi dell’uomo moderno, cioè secondo i concetti e i metodi della filosofia moderna. Si coglie con facilità l’illegittima illazione: al fine di risvegliare la fede dei cattolici (vero problema), la Chiesa cambiava pelle e dottrina (falsa soluzione). Ci rimane da vedere se lo stesso Concilio non riveli qualcosa di questa intenzione: «Concilio, che dici di te stesso?» (su)
22. È importante infatti leggere ciò che lo stesso Concilio, e non solo il Papa che l’ha convocato, ha dichiarato delle sue intime intenzioni. Se si evidenzia che l’intenzione del Concilio non fu quella che doveva essere, non ci si stupirà che un concilio ecumenico regolarmente convocato, che riuniva tutti i vescovi della Chiesa cattolica sotto l’autorità del romano Pontefice, abbia potuto esprimere degli errori contrari alla dottrina della fede. Ora, una tale intenzione sembra che sia esistita. Infatti il Concilio ha espressamente dichiarato quale fosse la sua intenzione originaria: In questa luce, il Concilio
si propone innanzitutto di esprimere un giudizio su quei valori che
oggi sono più stimati e di ricondurli alla loro divina sorgente.
Questi valori infatti, in quanto procedono dall’ingegno umano che
all’uomo è stato dato da Dio, sono in sé ottimi, ma per
effetto della corruzione del cuore umano non raramente vengono distorti
dall’ordine richiesto, per cui hanno bisogno di essere purificati (61).
Questa netta dichiarazione d’intenti dev’essere presa sul serio, poiché essa figura nel documento del Concilio che meglio corrisponde all’intenzione «pastorale»: la sua «costituzione pastorale». I «valori» da giudicare sono, evidentemente, i valori liberali che hanno preoccupato il magistero della Chiesa da dopo la Rivoluzione, come l’aspirazione al «libero esercizio della religione nella società», affermata in diverse dichiarazioni dei diritti dell’uomo, e di cui il Concilio dice: Considerando diligentemente
tali aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e come siano
conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano
rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali
trae nuovi elementi in costante armonia con quelli già posseduti
(62).
Qui è espresso il desiderio di accogliere dei nuovi valori, posto che essi siano conformi alla verità; è un desiderio di novità nella continuità. E siccome la Sacra Scrittura e la Tradizione, debitamente scrutate, lungi dal sostenere una tale libertà, sembrano condannarla, per affermare la continuità si utilizzerà il procedimento della dialettica logica e storica descritta prima. 23. Quale era stata in effetti l’attitudine della Chiesa nei confronti del mondo moderno e delle sue idee liberali? Fino ad allora, la Chiesa aveva giudicato questi valori liberali, non purificandoli, ma condannandoli senza pietà. Nell’ultima proposizione del suo Syllabus, Pio IX aveva condannato la seguente opinione: «Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e farsi amico con il progresso, il liberalismo e civiltà moderna» (Dz 1780, DS 2980). In nome della fede, i papi avevano riprovato i principi della politica liberale, come il preteso diritto naturale alla libertà civile di coscienza, condannata da Gregorio XVI come un «delirio» (enciclica Mirari vos, Dz 1613, DS 2730), come il preteso diritto naturale alla libertà civile di coscienza e di culto, condannato da Pio IX nell’enciclica Quanta cura (Dz 1690) e nel Syllabus (Dz 1777-1780, DS 2977-2980). Lungi dal tentare una sintesi tra la novità e la Tradizione, il magistero aveva riprovato senza discussione la novità. Lungi dal cercare una continuità in questa novità, esso aveva affermato solennemente la sua discontinuità con la Tradizione, specialmente nell’enciclica Quanta cura, per ciò che concerne la libertà religiosa: Contro la dottrina delle
sacre Lettere della Chiesa e dei Santi Padri, non dubitano di affermare
“essere ottima la condizione della società nella quale non si
riconosce nell’Impero il dovere di reprimere con pene stabilite i
violatori della Religione cattolica, se non in quanto lo chieda la
pubblica pace” (63).
E Pio IX concludeva l’enciclica con delle parole che esprimevano un giudizio solenne e infallibile circa le dottrine in essa menzionate o quantomeno circa quelle indicate con precisione: Pertanto, tutte e singole le
prave opinioni e dottrine espresse nominatamente in questa Lettera, con
la Nostra autorità apostolica riproviamo, proscriviamo e
condanniamo; e vogliamo e comandiamo che esse siano da tutti i figli
della Chiesa cattolica tenute per riprovate, proscritte e condannate [Dz 1699].
(su)
24. Ma, pensavano certi teologi degli anni quaranta (1940), una rilettura della Quanta cura permetterebbe forse di valutare che Pio IX avesse condannato un diritto illimitato alla libertà religiosa, rivendicato in nome dell’indifferentismo. Quindi un’immunità limitata richiesta dalla dignità della persona umana potrebbe essere accettabile: a condizione di subire questa purificazione, essa sarebbe assimilabile alla dottrina della fede, posto che contestualmente si purifichi il Cristo Re dal suo esclusivismo medievale e il bene comune dal suo totalitarismo cesareo. Era questo il programma fissato dal padre Yves Congar nel 1945, ben prima del Concilio, nei suoi corsi e nelle sue conferenze: come fare acquisire dalla Chiesa le idee liberali. All’epoca di Lamennais, ed
anche al tempo del Sillon, i principi capaci di assimilare al
cristianesimo le idee di libertà, democrazia, ecc, non erano
stati sufficientemente valutati e approfonditi, perché, su tali
verità divenute eccessi nel mondo moderno, si potessero operare
il discernimento e le purificazioni necessarie per un adattamento
veramente organico. A quel tempo, i progressisti avevano fatte proprie
così com’erano delle idee nate in un mondo diverso, sovente
ostile e ancora troppo gravido di un altro spirito, e avevano pensato
di introdurle nel cristianesimo e, a loro modo di vedere, battezzarle.
Senza dubbio l’ottantesima e ultima proposizione del Syllabus del 1864 intendeva
condannare essenzialmente ogni adattamento al mondo moderno, col quale
la Chiesa avrebbe mutato i principi suoi propri per adottarne degli
altri. Ma riconciliare la Chiesa e un certo mondo moderno non poteva
farsi introducendo nella Chiesa delle idee di tale mondo moderno
così come esse erano; questo processo presupponeva un lavoro in
profondità, col quale i principi permanenti del cattolicesimo
assumessero uno sviluppo nuovo, assimilando, dopo averli decantati e se
necessario purificati, gli apporti validi di questo mondo moderno (64).
Dunque, una tale riforma della dottrina sfuggirebbe, sembra, alla condanna pronunciata da San Pio X contro il modernismo nel giuramento antimodernista: «condanno ogni errore con cui, al divino deposito consegnato da Cristo alla Sposa per essere da lei custodito fedelmente, viene sostituita l’invenzione filosofica (65)». Non si sostituirà il liberalismo alla dottrina cattolica, ma lo si inietterà in essa, debitamente attenuato come un vaccino: realizzando una procedura più elegante e una pratica più scientifica. È palese che il concilio Vaticano II ha realizzato questo programma. Il testo di Gaudium et spes n. 11 non è altro che una citazione implicita di padre Congar. Il Concilio ha realizzato il lavoro di purificazione e di assimilazione degli «apporti validi» del liberalismo. Il padre Congar si è dunque rivelato uno dei geniali progettisti del Concilio che poi sarebbe stato convocato. (su)
25. Che l’intenzione del Concilio sia stata proprio quella di assimilare i «valori» liberali, è ciò che il Papa Paolo VI ha confermato nel suo discorso in occasione dell’ultima seduta pubblica del Concilio, il 7 dicembre 1965, precisando che l’assimilazione era stata effettivamente operata come la risposta della Chiesa alla sfida lanciatale da un mondo anticristico. Invece di rinnovare la condanna del liberalismo, lo si era assimilato: L’umanesimo laico profano
alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un certo
senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto
Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale
è) dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno
scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma non è
avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma
della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha
tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto maggiori sono,
quanto più grande si fa il figlio della terra) ha assorbito
l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi
umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e
riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di
tutti, siamo i cultori dell’uomo. […]
Ma bisogna riconoscere che
questo Concilio, postosi a giudizio dell’uomo, si è soffermato
ben più a questa faccia felice dell’uomo, che non a quella
infelice. Il suo atteggiamento è stato molto e volutamente
ottimista. Una corrente di affetto e di ammirazione si è
riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori,
sì; perché ciò esige la carità, non meno
che la verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed
amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di
funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il
mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma
onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e
benedette (66).
Dunque, agli assalti del mondo anticristico, il Concilio ha risposto con il dovuto sentimento: ottimismo, simpatia, affezione, ammirazione, fiducia. Poniamo per inciso una domanda: che cos’è un magistero affettuoso e simpatico? «Riprovati gli errori». Sì, degli errori estremi, per legittimare l’inoculazione del virus liberale attenuato: il Concilio ha riprovato l’ateismo, la libertà interiore di coscienza, la collegialità senza il Papa, l’irenismo in campo ecumenico, un sacerdozio propriamente detto dei laici, ecc, ma, non ha condannato come necessario il comunismo, ha assorbito il diritto alla libertà civile dei culti, il doppio potere supremo nella Chiesa, il valore salvifico delle confessioni cristiane non cattoliche, l’espressione “sacerdozio comune” dei fedeli, ecc. E così facendo, ha assimilato e benedetto, dopo averli purificati, i valor liberali del mondo sorto dalla Rivoluzione. Per inciso, poniamo ancora una domanda: che cos’è un magistero che battezza la Rivoluzione? (su)
26. Che l’assimilazione dei valori liberali sia sta tentata dal Concilio è ciò che conferma anche il cardinale Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, parlando della costituzione Gaudium et spes «sulla Chiesa nel mondo contemporaneo», in collegamento con i documenti conciliari dello stesso tenore sulla libertà religiosa e sulle religioni del mondo: Il Syllabus di Pio IX […] ha tracciato
una linea di separazione rispetto alle forze determinanti del 19°
secolo: le componenti scientifiche [filosofiche ed esegetiche] e
politiche del liberalismo. Nella controversia modernista, questa doppia
frontiera è stata ancora una volta rafforzata e fortificata […]
Per «mondo» si
intende, in fondo, lo spirito dei tempi moderni, di fronte al quale la
coscienza di gruppo nella Chiesa si sentiva come un soggetto separato
[che soffriva del complesso del ghetto] che ricercava, con una guerra
sia calda, sia fredda, il dialogo e la cooperazione. […]
Accontentiamoci qui di
constatare che il testo [della Gaudium
et spes] giuoca il ruolo di contro-Syllabus, nella misura in cui
rappresenta un tentativo di riconciliazione ufficiale della Chiesa col
mondo com’era divenuto dopo il 1789 (67).
Questo è anche quello che riteneva Mons. Marcel Lefebvre: «il Concilio è stato la riconciliazione della Chiesa con la Rivoluzione», cioè ne ha tentato la sintesi. Ma il cardinale spiegava il motivo di questa riconciliazione: i gerarchi modernisti degli anni cinquanta non potevano più sopportare che la Chiesa fosse separata dal mondo, che dovesse ancora combatterlo, che essa fosse considerata solo come nemico, che essa fosse esclusa dall’edificazione di questo mondo, che non avesse udienza nelle sue assemblee. L’equivoco tra il mondo anticristico che non si voleva più combattere, il mondo da convertire che non si voleva più convertire, e il mondo com’esso era e nel quale si doveva pur vivere, annebbiava la vista di questi gerarchi. Ed allora, privi di orientamento, avendo perduto la saggezza ed essendo divenuti spiritualmente ottenebrati, una volta riuniti in concilio, quale soluzione veramente cattolica e magisteriale potevano proporre a questo scontro penoso fra la Chiesa e il «mondo», al fine di guarire il loro «complesso del ghetto»? Poniamo ancora una domanda per inciso: che cos’è un magistero che vuole guarire da un complesso psicologico? 27. Il Concilio imposta il problema allo stesso modo del padre Congar e vi apporta la medesima soluzione. È esattamente ciò che conferma implicitamente lo stesso Joseph Ratzinger in un’intervista del 1984: Il problema degli anni
sessanta era di acquisire i migliori valori espressi da due secoli di
cultura «liberale». Sono infatti dei valori che, anche se
sono nati fuori dalla Chiesa, possono trovare il loro posto, epurati e
corretti, nella sua visione del mondo. È quello che è
stato fatto (68).
Questo testo è capitale, per l’autorità del suo autore, per la sua perfezione stilistica e per il fatto che condensa in quattro righe l’intenzione originaria del Concilio, secondo la Gaudium et spes e la Vraie et fausse réforme. Il termine «problema» esprime esattamente lo scontro da riassorbire; l’espressione «cultura liberale» suggerisce una ricchezza simpatica; il termine «valori» evoca preziose regole di vita da non trascurare; l’espressione «possono trovare il loro posto» e il verbo «acquisire» significano che è già pronto il nido capace di ricevere questi valori e che essi arricchiranno la Chiesa: «i principi permanenti del cattolicesimo prenderanno un nuovo sviluppo assimilandoli», diceva il padre Congar. E questa assimilazione richiederebbe appena una piccola operazione preliminare: questi valori sarebbero «decantati e se necessario purificati» (Congar), «purificati» (Gaudium et spes) o «epurati e corretti» (Ratzinger). E il cardinale aggiunge: «È quello che è stato fatto», il Concilio ha realizzato questa purificazione e questa assimilazione dei valori liberali, e ci si aspettava un nuovo sviluppo della dottrina e della vita. (su)
28. Eppure, un tale tentativo e tali speranze erano condannate dal magistero della Chiesa, come appare dalla costituzione dogmatica sulla fede, Dei Filius, del concilio Vaticano I: La dottrina della fede, che
Dio ha rivelato, non è stata proposta all’intelligenza
umana come un sistema filosofico da perfezionare, ma, come un divino
deposito, è stata affidata alla Chiesa, sposa di Cristo,
perché la custodisca fedelmente e infallibilmente la proclami.
In conseguenza il senso dei sacri dogmi che deve sempre essere
conservato è quello che la santa Madre Chiesa ha determinato una
volta per tutte e non bisogna allontanarsi da esso sotto il pretesto e
in nome di una intelligenza più profonda [sub specie et nomine altioris
intelligentiae] (69).
La Chiesa non proibisce che si scruti il deposito della fede (70) con l’aiuto della ragione e della sana filosofia, per trarne una conoscenza più scientifica con la spiegazione, più saggia con lo spirito di sintesi e il ricorso ai più alti principi del mistero di Dio, e anche più profonda grazie all’intelligenza dei contemplativi – conoscenza che tuttavia non supererà in perfezione la piena intelligenza che ne ebbero gli Apostoli; ma la Chiesa condanna ogni tentativo di matrimonio del dogma con la falsa filosofia, con l’idea di farlo progredire. È evidente che l’assimilazione dei «valori liberali», cioè della filosofia idealista e soggettivista, da parte della dottrina della fede farà cambiare il senso di questa dottrina, esattamente come un falso giorno deforma la realtà o un falso gettone altera il giuoco. Il concilio Vaticano I affermava, come abbiamo visto, che bisogna evitare di cambiare il senso della dottrina anche in nome di una comprensione più profonda. E il giuramento anti-modernista imposto da San Pio X lo confermava: Accolgo sinceramente la
dottrina della fede trasmessa fino a noi dagli Apostoli per mezzo dei
padri ortodossi, nello stesso senso e sempre nello stesso contenuto; e
per questo respingo totalmente l’eretica invenzione dell’evoluzione dei
dogmi, che passano da un significato ad un altro, diverso da quello che
prima riteneva la Chiesa; e ugualmente condanno ogni errore con cui, al
divino deposito consegnato da Cristo alla Sposa per essere da lei
custodito fedelmente, viene sostituita l’invenzione filosofica o la
creazione dell’umana coscienza, lentamente formatasi con lo sforzo
degli uomini e da perfezionarsi per l’avvenire con un progresso
indefinito (71).
Già l’Apostolo San Paolo metteva in guardia Timoteo contro un’operazione simile: non usare un linguaggio nuovo e profano e non considerare la falsa scienza opposta alla sana dottrina: O Timoteo, custodisci il
deposito; evita le chiacchiere profane (72) e le obiezioni della
cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla
fede [1 Tim. 6, 20].
Richiama alla memoria queste
cose, scongiurandoli davanti a Dio di evitare le vane
discussioni, che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi le
ascolta. Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di
approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno
scrupoloso dispensatore della parola della verità. Evita le
chiacchiere profane, perché esse tendono a far crescere sempre
più nell’empietà; la parola di costoro infatti si
propagherà come una cancrena. [2
Tim. 2, 14-16].
È dunque chiaro che la parola di Dio scritta e trasmessa condanna la pretesa di aggregare al deposito della fede i «valori» profani del liberalismo e dei suoi surrogati. Una tale opera di assimilazione è rovinosa per il deposito rivelato ed è estranea all’unica funzione del magistero della Chiesa, che è di «conservare fedelmente e di proclamare infallibilmente» il deposito della fede. Questa «acquisizione dei valori della cultura liberale» è quindi priva dell’assistenza dello Spirito Santo, che è stato promesso alla Chiesa «non per mostrare una nuova dottrina, ma per conservare santamente ed esporre fedelmente la Rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede», come insegna ancora il concilio Vaticano I. (su)
29. Ne consegue con certezza che il concilio Vaticano II ha avuto l’intenzione dichiarata di volere «innanzi tutto» assimilare i «valori» liberali, un’intenzione anticipata dodici anni prima, nel 1950, delineata da Giovanni XXIII nel suo discorso di apertura del Concilio, nel 1962, confermata da Paolo VI nel suo discorso di chiusura del 7 dicembre 1965, ancora confermata dal futuro Benedetto XVI diciassette anni dopo il Concilio, nel 1982. È parimenti certo che, secondo diversi documenti del magistero ordinario dei papi o del magistero solenne della Chiesa, tale intenzione è contraria alla natura del magistero della Chiesa e costituisce una resistenza allo Spirito Santo. Quindi è inevitabile concludere che questa intenzione dichiarata del Concilio di volere innanzi tutto far suoi i «valori liberali», condannati peraltro dal magistero precedente con una continuità rimarchevole, è stata una contro intenzione che ha distolto l’assemblea dalla funzione magisteriale sua propria, spogliando così le sue decisioni di ogni carattere magisteriale, e ha privato da subito il Concilio dell’assistenza dello Spirito Santo, nella misura e nei dominii in cui essa è applicata. È notoriamente il caso dei tre insegnamenti maggiori del Concilio: la libertà religiosa, la collegialità, l’ecumenismo. Non per niente Mons. Marcel Lefebvre vedeva in queste tre novità un riflesso dei tre valori liberali della Rivoluzione francese, formalizzati dalle tre parole della divisa della Repubblica francese: libertà, uguaglianza, fraternità. - Più precisamente, con la collegialità, «la Chiesa del Concilio» ha assimilato il modello ugualitario e democratico. La Chiesa non è più essenzialmente gerarchica, fondata su Pietro e gli Apostoli, nei quali ha la sua origine e la sua costituzione, ma è primariamente «popolo di Dio», dal cui interno sorgono dopo diverse funzioni, tra cui quella di governare, i cui depositari sono il Papa e i vescovi. Certo, il Papa esercita la funzione del potere supremo, ma i vescovi sono costituiti in collegio (non si sa per quale autorità) il cui capo è il Papa, e anche questo collegio gode dell’autorità suprema. L’autorità del solo papa, quindi, è controbilanciata da quella del collegio sotto il suo capo. La Chiesa è dunque bicefala, non è più monarchica. Non conveniva più che la Chiesa si dicesse gerarchica e monarchica, bisognava che acquisisse il «valore» democratico, per non essere diversa dalle società moderne. - A sua volta, l’ecumenismo ha fatto acquisire alla Chiesa l’ideale della fraternità. La Chiesa si è ridefinita in rapporto alle altre confessioni cristiane. Essa non è più la sola Chiesa di Cristo, poiché altre confessioni possiedono una parte più o meno grande di verità e di mezzi di salvezza. La Chiesa è una comunione fraterna, che è perfetta nei cattolici, con i quali gli altri cristiani sono in comunione più o meno perfetta. Così le Chiese ortodosse saranno, per il Papa Giovanni Paolo II, delle «Chiese sorelle». - Infine la libertà religiosa, libertà civile di praticare la propria religione quale che sia (73), ha fatto entrare nel patrimonio della dottrina della Chiesa uno dei diritti soggettivi dell’uomo, già proclamato dalle dichiarazioni dei diritti dell’uomo su istigazione della Massoneria. Essa è definita come un diritto-dovere di cogliere e riconoscere «gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza» (DH 3, 3), cioè anche quando questa non soddisfa «l’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa» (DH 2, 3). L’idea contraddittoria di una coscienza teoricamente legata alla legge divina, ma che concretamente non aderisce ad essa (DH 2,3), e avente il potere di imporsi come norma nella società (DH 3, 3 e 4), fa assurgere la libertà della persona al di sopra della verità di Cristo. Senza volere qui dimostrare inoppugnabilmente gli errori delle tre dottrine maggiori del Concilio, abbiamo potuto mostrare che esse hanno ingerito i postulati liberali. Ora, invece dell’assimilazione sperata, non si è trattato di un’indigestione? In ogni caso, la contro intenzione che il Concilio presuppone priva questi tre testi di ogni valore magisteriale. (su)
30. Questi valori liberali che il Concilio dichiara di volere assimilare, il cardinale Ratzinger, seguendo il padre Congar, li dichiara nati fuori dalla Chiesa, eppure costituenti dei «valori» reali. Tali affermazioni, dice Mons. de Galarreta (74), inducono a diverse riflessioni: 1)
Poiché, per prima cosa, com’è possibile che vi
siano dei valori che toccano in modo così essenziale l’ordine
naturale e quello soprannaturale – per convincersene basta guardare
alla Chiesa di prima e di dopo il Concilio! - e che possano
nascere, tali valori, al di fuori della Chiesa? Non è dunque la
Chiesa la depositaria della Verità? La Chiesa cattolica non
è la vera Chiesa? E la Verità evolve dunque in base alla
storia e al tempo, alle culture e ai luoghi?
2) Non è vero affermare che questi sono valori nati al di fuori della Chiesa. Già un autore come Chesterton diceva che le idee della Rivoluzione francese sono delle idee cattoliche divenute folli. E noi potremmo dire con più esattezza: sono delle verità cattoliche indebitamente trasposte nell’ordine naturale, delle idee che sono vere nell’ordine soprannaturale, con dei limiti [libertà cristiana della carità; uguaglianza in tutti della dignità di figlio di Dio; fraternità dei figli di uno stesso Padre celeste per l’adozione battesimale], ma che sono state trasposte direttamente nell’ordine naturale. Se veramente il Concilio Vaticano II avesse preso i «valori» liberali e li avesse corretti, purificati ed emendati, allora si sarebbe ritrovata molto semplicemente la verità cattolica di sempre, poiché si tratta di verità cristiane deformate. Voglio dire che il liberalismo è un’eresia cristiana, cattolica, fin dalla sua origine [un’eresia nata nel cristianesimo]. 3) D’altra parte, era quanto meno temerario volere questa conciliazione [assimilazione], quando il magistero costante dei papi, per due secoli e mezzo, aveva condannato questi supposti valori: essi sono stati condannati in blocco e in dettaglio. Era stata condannata, non solo la possibilità di una tale conciliazione, ma anche l’affermare la necessità di una tale conciliazione. È il Syllabus, è Pio IX. Siamo di fronte ad uno dei peccati originali del Concilio. Molto spesso ci mettono sotto gli occhi il magistero e l’autorità. Spesso è il solo argomento che essi hanno. Quando sono proprio loro che hanno incominciato a sbarazzarsi di un magistero di due secoli e mezzo e proprio per fare esattamente ciò che i papi avevano già condannato [l’assimilazione]. Questo è più che temerario. 4) E poi, si cerca una conciliazione col mondo, con un mondo lontano da Dio e opposto a Dio. Guardate il mondo, basta guardarsi attorno per comprendere di che mondo si tratta. Ora, la Scrittura è molto chiara. San Giovanni ci dice: «Tutto ciò che viene dal mondo è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita» (Cfr. I Gv. 2, 16). E l’Apostolo San Giacomo diceva ai cristiani: «Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio» (Gc. 4, 4). E non è lo stesso cardinale Ratzinger che ha descritto nel modo più chiaro questa conciliazione adultera come quella che ha realizzato il Concilio, specialmente nella Gaudium et spes? Se si tenta una diagnosi
globale del testo – egli scrive – si potrebbe dire (in relazione alla
libertà religiosa e alle religioni del mondo) che si tratta di
una revisione del Syllabus di Pio IX, una sorta di contro-Syllabus. […] Accontentiamoci qui
di constatare che il testo svolge il ruolo di contro-Syllabus nella misura in cui ha
rappresentato un tentativo per una riconciliazione ufficiale della
Chiesa col mondo, com’è divenuto dopo il 1789 (75).
31. Sembra che il tentativo del Vaticano II di assimilare i valori liberali non sia stato più felice di quello di Lamennais nel XIX secolo, se si deve credere al futuro Benedetto XVI nel suo colloquio già citato con Vittorio Messori: una volta epurati e corretti, questi valori dovevano trovare il loro posto nella visione della Chiesa. Ma, aggiunge Joseph Ratzinger nel 1984, quasi vent’anni dopo il Concilio: «Adesso il clima è peggiorato in rapporto a quello che giustificava un ottimismo forse ingenuo. Oggi occorre ricercare un nuovo equilibrio» (76). «Un equilibrio impossibile!» esclamava Mons. Marcel Lefebvre (77). Ma divenuto papa, Benedetto XVI ha mantenuto il suo postulato dell’assimilazione necessaria dei valori liberali; ha espresso la teoria della possibilità della «sintesi fra la fede e la ragione dominante corrente»: come San Tommaso aveva saputo fare la sintesi fra la fede e la filosofia del pagano Aristotele debitamente corretta, così il Concilio aveva tracciato per grandi linee la sintesi fra la fede e la ragione moderna, cioè la filosofia liberale. Ma lasciamo parlare Benedetto XVI. (su)
Quando nel XIII secolo,
mediante filosofi ebrei ed arabi, il pensiero aristotelico entrò
in contatto con la cristianità medievale formata nella
tradizione platonica, e fede e ragione rischiarono di entrare in una
contraddizione inconciliabile, fu soprattutto san Tommaso d'Aquino a
mediare il nuovo incontro tra fede e filosofia aristotelica, mettendo
così la fede in una relazione positiva con la forma di ragione
dominante nel suo tempo. La faticosa disputa tra la ragione moderna e
la fede cristiana che, in un primo momento, col processo a Galileo, era
iniziata in modo negativo, certamente conobbe molte fasi, ma col
Concilio Vaticano II arrivò l’ora in cui si richiedeva un ampio
ripensamento. Il suo contenuto, nei testi conciliari, è
tracciato sicuramente solo a larghe linee, ma con ciò è
determinata la direzione essenziale, cosicché il dialogo tra
ragione e fede, oggi particolarmente importante, in base al Vaticano II
ha trovato il suo orientamento (78).
Per «ragione moderna» bisogna intendere, come Benedetto XVI, la filosofia idealista che è all’origine del liberalismo e del modernismo. All’opposizione inconciliabile dei papi Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII e San Pio X, col Concilio è seguito il dialogo, che ha posto le basi per una sintesi. Ora, il paragone fra San Tommaso e il Vaticano II è fallace. Certo, nel Medio Evo San Tommaso aveva saputo fare la sintesi tra fede e filosofia aristotelica purificata, ma perché questa filosofia è la filosofia del reale, quella dell’intelligenza delle cose in se stesse, quella delle essenze, quella che, con l’analogia dell’essere, ha accesso alla conoscenza dell’Essere primo che è Dio, e dunque è capace di dire qualcosa di Dio: è dunque quella filosofia che può diventare lo strumento di investigazione dei misteri divini, così come sono oggettivamente rivelati. Ma fare la «sintesi» fra la fede e la filosofia idealista, che è agnostica, che pretende che la ragione non conosca le cose in se stesse, ma solo il risultato del suo funzionamento, significa giungere a conoscere dei misteri della fede solo la reazione vitale del credente e ridurre la dottrina della fede all’esperienza religiosa: teoria modernista già condannata nel 1907 da San Pio X nella Pascendi (79). (su)
NOTE 45 - Risposta del cardinale Billot a Papa Pio XI, in GIOVANNI CAPRILE, S. I., Il concilio Vaticano II, cronache del concilio Vaticano II, La Civiltà Cattolica, Roma, vol. V, 1966; nella traduzione francese di RAYMOND DULAC, La Collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican, Cèdre, Paris, 1979, pp. 9-10. 46 - Si veda JOSEPH RATZINGER, Les Principes de la théologie catholique, p. 279. Sull’argomento si veda Si veda MONS. TISSIER DE MALLERAIS, L’étrange théologie de Benoît XVI, , Ed. Le Sel de la terre, Avrillé, 2010, chap. 5, «Le sacerdoce réduit au pouvoir d’enseignement», p. 79 [La strana teologia di Benedetto XVI, Ed. Ichthys, Albano Laziale, 2012, cap. 5, «Il sacerdozio ridotto al potere d’insegnamento», p.69]. 47 - Si veda CONCILIO VATICANO II, costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, nn. 10-11; decreto sulla vita e il ministero dei sacerdoti Presbyterorum ordinis, n. 2. 48 - Discorso di apertura del Concilio, Gaudet Mater Ecclesia, 11 ottobre 1962, n. 6, 5 49 - VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 22, 3. 50 - La Nota explicativa praevia fa parte degli atti del Concilio come allegato alla Costituzione Lumen gentium. 51 - VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 9, 3 e n. 1. 52 - Si veda SAN CIPRIANO, De Ecclesiae catholicae unitate, VII, 1, PL 4, col. 504: «Hoc unitatis sacramentum, hoc vinculum concordiae inseparabiliter cohaerentis…». Si tratta della solidità dell’unità interna della Chiesa, che gli scismi non possono lacerare. 53 - PIO IX, bolla Ineffabilis Deus sulla definizione dell’immacolata concezione della Beata Vergine Maria, 8 dicembre 1854. 54 - GIOVANNI XXIII, Discorso al sacro collegio e alla prelatura romana, 23 dicembre 1962. 55 - Pio XII, enciclica Humani generis, 12 agosto 1950, Dz 2323. 56 - BENEDETTO XVI, Lumière du monde, entretien avec Peter Seewald, Bayard, 2010, chap. 13, p. 180 [Luce del mondo. Una conversazione con Peter Seewald, Libreria Editrice Vaticana, 2010, cap. 13, p. 192]. 57 - CARD. JOSEPH RATZINGER, La Foi chrétienne hier et aujourd’hui, Cerf, Paris, 2005, p. 202 [Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia, 1969, pp. 232 e 233]. 58 - Vedi: ABBÉ FRANÇOIS PIVERT, Le Combat de la foi catholique, n° 166, p. 8, col. 3. 59 - «Ratio fide illustrata», dice il concilio Vaticano I, nella costituzione Dei Filius: «Quando la ragione, illuminata dalla fede, cerca con zelo, pietà e moderazione, per il dono di Dio arriva a una certa conoscenza molto feconda dei misteri» (DS 3016). 60 - Histoire du Parti Communiste (b) de l’URSS, ediz. francese del1939, capitolo «Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique», citato da JEAN MADIRAN, La Vieillesse du monde, essai sur le communisme, NEL,1966, p. 146. 61 - VATICANO II, costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 11, 2. 62 - VATICANO II, dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, n. 1, 1. 63 - PIO IX, enciclica Quanta cura, 8 dicembre 1864, Dz 1689. 64 - YVES M.-J. CONGAR, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Cerf, Paris, 1950, pp. 345-346; ROGER AUBERT, Tolérance et communauté humaine, Castermann, 1951, pp. 81-82. 65 - SAN PIO X, Giuramento anti-modernista, annesso al motu proprio Sacrorum antistitum, 1 settembre 1910, DS 3541. 66 - PAOLO VI, Discorso di chiusura del Concilio Vaticano II, 7 dicembre 1965. 67 - Cardinale JOSEPH RATZINGER, Les Principes de la théologie catholique, pp. 426-427. 68 - Cardinale JOSEPH RATZINGER, «Pourquoi la foi est en crise», entretien avec Vittorio Messori, Jesus, novembre 1984, p. 72. [Cfr: Rapporto sulla fede, Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Edizioni Paoline,1985, p. 34]. 69 - VATICANO I, costituzione dogmatica Dei Filius, capitolo 4, La fede e la ragione, DS 3020. 70 - VATICANO I, costituzione dogmatica Pastor aeternus, cap. 4, DS 1836. 71 - SAN PIO X, Giuramento anti-modernista, annesso al motu proprio Sacrorum antistitum, 1 settembre 1910, DS 3541. 72 - «Novitates vocum» secondo la vulgata latina, cioè le novità di linguaggio; «Kenophonias» secondo il greco, cioè parole prive di senso. 73 - Al contrario, il Papa Pio XII definiva la libertà religiosa precisando di quale sola religione si trattasse: «la libertà di praticare la religione fondata sulla fede in Dio e la sua Rivelazione» (Discorso ai membri del Congresso degli Stati Uniti, 15 dicembre 1944). 74 - MONS. ALFONSO DE GALARRETA, Sermone per le ordinazioni a Ecône, 29 giugno 2011. 75 - Cardinale JOSEPH RATZINGER, Les Principes de la théologie catholique, p. 426-427. 76 - Cardinale JOSEPH RATZINGER, «Pourquoi la foi est en crise», entretien avec Vittorio Messori, Jesus, novembre 1984, p. 72. [Cfr: Rapporto sulla fede, Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Edizioni Paoline,1985, p. 34]. 77 - MONS. MARCEL LEFEBVRE, Conferenza spirituale a Ecône, 21 dicembre 1984. 78 - BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia romana, 22 dicembre 2005. 79 - SAN PIO X, enciclica Pascendi, 8 settembre 1907, n. 15, Dz 2081. (su) ottobre 2012 AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI |