 |
 |
| La bottiglia e il vino Quinta parte di Francesco Gisci Prima parte Seconda parte Terza parte Quarta parte Quinta parte Settima parte Ottava parte Nona parte Decima parte Undicesima parte  Fu a partire dalla traduzione latina dell’Isagoge (260-270) di Porfirio, ad opera di Severino Boezio (480-524 d.C.), che i prometeici “dialettici” (1), nell’XI secolo, cominciarono a sabotare l’oggettiva capacità di conoscenza dell’uomo. Il trattatello di Porfirio, noto anche con il titolo Sulle cinque voci, prende in considerazione le cinque nozioni aristoteliche di genere, specie, differenza specifica, proprio e accidente. Un esempio di genere è «animale», un esempio di specie è «uomo», un esempio di differenza è «razionale», un esempio di proprio è «capace di ridere», esempi di accidente sono «bianco», «pesante», «essere seduto». Queste cinque nozioni sono dette predicabili, ovvero, i possibili modi con cui un predicato (2) può essere attribuito a un soggetto, secondo una scala di universalità tale per cui al diminuire dell’estensione aumenta la comprensione, e viceversa. Vediamo, in estrema sintesi, i cinque predicabili più nel dettaglio (da non confondere con i predicamenti o categorie (3)). (1) «Il genere è ciò che si predica di più realtà che differiscono per specie, per quel che riguarda l’essenza. “Animale”, che è genere, si predica di “uomo”, di “bue” e di “cavallo”, i quali differiscono tra di loro non solamente per numero, ma anche per specie» (4). (2) «La specie è ciò che è subordinato al genere e, inoltre, ciò che si predica di più realtà che differiscono per numero, relativamente all’essenza» (5). Questa doppia definizione chiarisce sia il rapporto tra genere e specie: il genere è sempre predicato e la specie soggetto, mai viceversa; che il rapporto tra specie e individui: la specie è sempre predicato e l’individuo soggetto, mai viceversa. Infatti «non è possibile predicare termini meno estesi di termini più estesi: non si può dire che l’animale [genere] è uomo [specie], mentre si può dire che l’uomo è animale» (6), così come non si può dire che l’uomo [specie] è Tizio [soggetto], mentre si può dire che Tizio è uomo. (3) «Si definiscono differenze specifiche quelle che determinano alterità, infatti, la differenza “razionale”, aggiungendosi ad “animale”, lo rende altro» (7) : «la differenza è ciò che porta all’essere e che è parte integrante dell’essenza della cosa» (8). «Pertanto, si producono le divisioni dei generi in specie in base alle differenze specifiche, che determinano alterità, e si formulano le definizioni con i generi e con queste differenze» (9). L’esempio classico è la definizione secondo cui Tizio (soggetto) è “uomo” (specie), ovvero, “animale” (genere) “razionale” (differenza specifica). (4) «Proprio è ciò che risulta appartenere sempre ed esclusivamente alla totalità di una specie, come, ad esempio, la “capacità di ridere” per l’uomo; e anche se non ride sempre, lo si definisce tuttavia “capace di ridere” non perché rida sempre, ma perché è un’attitudine naturale. Questa attitudine, d’altronde, è sempre presente in lui per natura, come la “capacità di nitrire” per il cavallo. Queste ultime caratteristiche vengono definite propri in senso forte, perché sono convertibili: se c’è il “cavallo” c’è anche la “capacità di nitrire”, e se c’è la “capacità di nitrire” c’è il “cavallo”» (10). «L’accidente è ciò che può essere presente o assente, senza comportare la distruzione del soggetto, o anche, ciò che non è né genere, né differenza, né specie, né proprio, e nondimeno è sempre sussistente in un soggetto» (11). Tra queste cinque nozioni, come insegnava Aristotele, le prime tre si dicono sostanze seconde, ovvero, «le specie cui sono immanenti le sostanze che si dicono prime, ed oltre alle specie, i generi di queste. Ad esempio, un determinato uomo è immanente ad una specie, cioè alla nozione di uomo, e d’altra parte il genere di tale specie è la nozione di animale» (12). Sostanze prime e seconde, o predicabili, categorie o predicamenti, ecc., sono alcune delle nozioni (le prime che compaiono nell’Organon dello Stagirita, testo la cui difficoltà è tutt’oggi disarmante) a partire dalle quali Aristotele «ricerca le condizioni che costituiscono la scienza o, meglio, nell’elaborazione dell’organo o strumento che deve rendere possibili ragionamenti corretti» (13), fondando così la Logica (o Analitica), che non è mai stata superata (e mai potrebbe). Tutt’al più, si potrebbe dire che Aristotele si “è limitato” ad occuparsi prevalentemente della sillogistica, pur essendo consapevole che «la nozione di necessario è più ampia della nozione di sillogismo: in effetti, ogni sillogismo è qualcosa di necessario, ma non tutto ciò che è necessario risulta un sillogismo» (14). Quindi, «se oggetto della logica formale è l’indagine sulle inferenze necessarie, allora gli Analitici Primi hanno fissato una volta per sempre l’oggetto della logica formale: questo è la deduzione nel senso aristotelico e moderno dell’espressione, ossia l’inferenza necessaria dalla o dalle premesse alla conclusione» (15). Qualunque logico o logistico (16), eccezion fatta per i logicisti eterodossi e paraconsistenti (gli ericlatei-hegeliani) infognati «a dimostrare la contraddittorietà del mondo reale» (17), dunque, è un nano sulle spalle del gigante. Riassumendo: un oggetto, o una cosa, può essere espresso in due modi: «secondo una connessione, o senza connessione» (18). «I termini che si dicono senza alcuna connessione, esprimono caso per caso, o una sostanza [cioè la cosa stessa, come un determinato uomo, una determinata automobile], o una quantità [due metri, tre chili], o una qualità [bianco, ingegnere], o una relazione [figlio, maggiore], o un luogo [in montagna, al mare], o un tempo [stamattina, la settimana scorsa], o l’essere in una situazione [in piedi, parcheggiata], o un avere [portare le scarpe o un rimorchio], o un agire [scrivere, correre], o un patire [essere licenziato, incidentato]. Ciascuno dei suddetti termini [o predicamenti o categorie, cioè la sostanza più i nove accidenti che sono o ineriscono nella sostanza], in sé e per sé, non rientra in alcuna affermazione; un’affermazione si presenta invece, quando tali termini si connettono tra loro» (19), come nel caso dei predicabili. Il genere, la specie e la differenza [o predicabili], sono ciò rispetto a cui la sostanza è immanente: ad esempio, un determinato ente è uomo perché appartiene alla specie umana, il cui genere è “animale”, e solo questi, tra i cinque predicabili precedentemente menzionati, vengono definite sostanze seconde, o predicati essenziali, perché «in effetti, essi soli rivelano la sostanza prima» (20), la natura propria della cosa. Tornando ai modi di esprimere le cose, diversamente dai predicamenti o categorie che si dicono senza alcuna connessione, le sostanze seconde definiscono una cosa secondo la connessione di termini: Tizio è un uomo (specie), ovvero, un animale (genere) razionale (differenza specifica). Dopo aver brevemente ricostruito i significati originari dei termini presi in considerazione, in particolare di genere, specie e differenza specifica, che «sono universali, ovvero, che per natura si predicano di parecchi oggetti» (21), ora, possiamo prendere in considerare in che modo il Chierico di Compiègne li abbia deliberatamente e arbitrariamente sabotati, svuotandoli, se mai fosse possibile, del loro valore aletico tanto accidentale e gnoseologico, quanto essenziale e ontologico (22), valore intellegibile che trascende (23) la mera esperienza sensibile, ma che il pensiero è capace di cogliere e, attraverso le parole, di significare realisticamente. Il Roscellino preparava così «il terreno fertile all’attecchimento e alla crescita abnorme della dialettica eretica con tutte le parassitarie ramificazioni di artifici verbali e di cavilli sofistici» (24) che nei secoli hanno covato e alimentato il superbo e orgoglioso uomo prometeico moderno, soggettivista e individualista, “creatore” di realtà simulate che giustificano la propria corruzione intellettuale e morale. Continua
NOTE 1 - «In dialettica questi furono i più noti sofisti: Giovanni che fece consistere la dialettica stessa nell’arte della parola [come far consistere la politica nell’arte del potere], Roberto di Parigi, Roscellino di Compiègne, Arnolfo di Lione. Questi ultimi furono discepoli di Giovanni ed ebbero a loro volta moltissimi seguaci», in una Cronaca anonima dell’XI secolo, pubblicata da C.E. Du Boulay, in Historia Universitatis Parisiensis, XVII sec. La dialettica, come insegnava Aristotele, è quel modo di dimostrare sillogisticamente che «conclude [partendo] da elementi fondati sull’opinione […] diversamente che da elementi veri e primi [Analitica]» (in Topici in Organon, 100 a 26-31, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 407). 2 - Con il termine predicato si indica ciò che si dice di un soggetto e che ne esprime una proprietà, una determinazione essenziale o accidentale. I predicati essenziali rientrano nei casi del genere, della specie e della differenza specifica, mentre i predicati accidentali rientrano nei casi del proprio e dell’accidente. 3 - Ogni termine che si dice senza alcuna connessione con un altro, esprime, caso per caso in una delle seguenti dieci categorie: «o una sostanza, o una quantità, o una qualità, o una relazione, o un luogo, o un tempo, o l’essere in una situazione, o un avere, o un agire, o un patire», in Aristotele, Categorie in Organon, 1 a 25-29, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 7. Rispetto al rapporto tra predicamenti o categorie e predicabili, Tommaso d’Aquino afferma che «il predicamento esprime un certo ordinamento dei predicabili nell’ordine predicamentale», in Rudimenti di Logica (Somma di tutta la logica di Aristotele), Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2024, pp. 23 e 75. 4 - Porfirio, Isagoge, Bompiani, Milano, 2004, p. 61, cfr. «genere è il predicato, immanente all’essenza di parecchi oggetti differenti per specie», in Aristotele, Topici in Organon, 102 a 31, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 412. 5 - Ibidem, p. 65. 6 - Ibidem, p. 73. 7 - Ibidem, p. 77, cfr. «la differenza è ciò che si predica qualitativamente di più cose differenti per specie. […] La differenza è ciò che la specie ha in più rispetto al genere, […], infatti, la specie ha in più il significato esplicito della differenza», in Tommaso d’Aquino, Rudimenti di Logica (Somma di tutta la logica di Aristotele), Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2024, p. 41 e 49. 8 - Ibidem, p. 85. 9 - Ibidem, p. 79. 10 - Ibidem, p. 87, cfr. «proprio è ciò per cui rivelando l’essenza individuale oggettiva, appartiene tuttavia a quell’unico oggetto, e sta rispetto ad esso in un rapporto convertibile di predicazione. Così è proprio dell’uomo essere suscettibile di apprendere la grammatica: se infatti un oggetto è un uomo, esso è suscettibile di apprendere la grammatica, e se è suscettibile di apprendere la grammatica, è un uomo», in Aristotele, Topici in Organon, 102 a 19-22, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 412. 11 - Ibidem, p. 89, cfr. «accidente è ciò che può appartenere e non appartenere ad un solo e medesimo oggetto, qualunque esso sia. Ad esempio, lo star seduto può appartenere e non appartenere ad un medesimo oggetto; così pure il bianco: nulla infatti impedisce che lo stesso oggetto sia ora bianco, ora per contro non bianco», in Aristotele, Topici in Organon, 102 b 6-7, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 413. 12 - Aristotele, Categorie in Organon, 2 a 14-19, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 6. 13 - F. Adorno, T. Gregory, V. Verra, Storia della filosofia, vol. I, Editori Laterza, 1982, p. 142. 14 - Aristotele, Analitici Primi in Organon, 47 a 33-36, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 181. 15 - M. Malatesta, Logistica, vol. I, Edizione della Libreria l’Ateneo, Napoli, 1976, p. 72. 16 - Per logistica si intende la sistemazione moderna della logica formale aristotelica dotata dei seguenti caratteri: «a) è costituita di espressioni, ossia di segni grafici o gruppi di segni grafici; 2) è rigorosamente deduttiva nel senso stabilito da Aristotele in Analitici Primi; 3) simbolizza le variabili analogamente a quanto faceva Aristotele pur facendo uso di segni diversi da quelli adottati dallo Stagirita; 4) simbolizza le costanti, cosa che non faceva Aristotele; 5) ha un ambito ben più vasto di quello che è l’oggetto specifico degli Analitici Primi», in M. Malatesta, Logistica, vol. I, Edizione della Libreria l’Ateneo, Napoli, 1976, p. 75. 17 - M. Malatesta, Dialettica e Logica formale, Editore Liguori, Napoli, 1988, p. 105. 18 - Aristotele, Categorie in Organon, 1 a 16-17, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 5. 19 - Ibidem, 1 a 25-31 e 2 a 1-7, p. 7. 20 - Ibidem, 2 b 30-31, p. 10. 21 - Aristotele, Dell’espressione in Organon, 17 a 37-39, Edizioni Adeplhi, Milano 2003, p. 62. 22 - T. d’Aquino, Somma Teologica, I, Q. 16, a. 1 risp., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2014, p. 220. 23 - Trascendente: ciò che determina qualcosa senza esserne parte; come l’idea creativa di un ingegnere che causa un’automobile senza essere fisicamente presente in essa. 24 - L. Gentile, Roscellino di Compiègne ed il problema degli universali, Editrice Itinerari, Lanciano, 1975, p. 123. 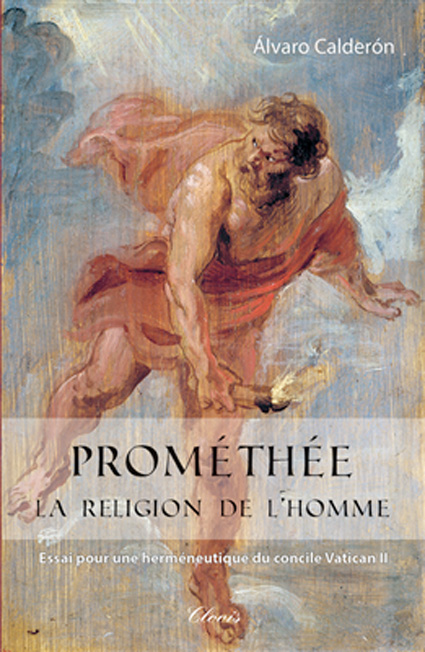 |