 |
 |
| La bottiglia e il vino Terza parte di Francesco Gisci Prima parte Seconda parte Terza parte Quarta parte Quinta parte Sesta parte Settima parte Ottava parte Nona parte Decima parte Undicesima parte  Il filosofo Roscellino nacque a Compiègne, a circa 90 km a nord di Parigi, nel 1050 (+ 1125), periodo in cui in Occidente (1) spuntava la «vegetazione minacciosa dell’eresia razionalistica e intellettuale con Abelardo (1079-1142) [allievo di Roscellino], e popolare con Pietro Valdo (1140-1218) [fondatore della setta valdese o “dei poveri di Lione”], che invase la vigna del Signore» (2). La notizia biografica più importante su Roscellino riguarda la condanna delle sue eretiche teorie trinitarie da parte del Concilio di Soissons (1092). «Egli insegnava che ogni concetto dover muovere dall’esperienza; non altro che l’individuale avere realtà e oggettività, non già i concetti universali che sono puri nomi astratti. Senza questa dottrina (nominalismo) credeva egli non potersi esattamente spiegare il mistero della Trinità e della Incarnazione. L’unità dell’essenza nelle tre divine Persone non era che un nome, l’unità fuori dell’individuo una parola vuota di senso. Che se si concepiva l’essenza di Dio nella Trinità come una sola cosa reale (una res) e non già le tre Persone come tre cose reali (tres res), queste non si mostravano più come qualcosa di reale, ma solamente come l’unico Iddio; […] al contrario […] conveniva ammettere tre dei e cadere nel triteismo» (3). Il filosofo non esitò ad abiurare «solo per timore di venire ucciso dal popolo e non perché convinto e pentito del proprio errore» (4). Il popolo non era conciliante come i Padri Conciliari e voleva la sua morte (5). Dovette quindi scappare dalla Francia. Si rifugiò in Inghilterra dove però ad aspettarlo c’era un campione dell’ortodossia, il Primate Sant’Anselmo d’Aosta (1033-1109). Come ogni eretico che (non) si rispetti, la frustrazione derivata dall’impossibilità di attaccare direttamente la Santa Madre Chiesa sul piano dottrinale, lo portava ad attaccare i costumi «lassisti e corrotti» (6) dei religiosi. La generalizzazione dei mali di certi ecclesiastici a danno dell’Unica Santa Cattolica Apostolica e Romana Chiesa, è sempre stata la misura degli eretici. Dovette quindi fuggire anche dall’Inghilterra e l’unico posto dove poté ripararsi fu proprio Roma. Lì le autorità avevano più presa sulla popolazione e non rischiava il linciaggio. Dopo essersi riconciliato con la Chiesa, fece ritorno in Francia ancora a Compiègne, ma non senza sferrare nuovi attacchi all’integrità della Fede. Questa volta la severa ma giusta reazione non si fece attendere: «fu sottoposto a bastonatura da parte dei canonici del luogo, suoi confratelli» (7). Non è un caso se, più recentemente, la sua losca figura è stata rivalutata proprio da uno dei capi storici del modernismo, Ernesto Bonaiuti (1881-1946): «è stato senza dubbio un individuo dalla vita specchiata, su cui non si è potuta esercitare la malevolenza dei suoi formidabili avversari; un individuo devoto alla professione cattolica, flagellatore di vizi e di abusi ecclesiastici» (8) (sic!). Il Vescovo, cronista e storico Ottone di Frisinga (1114-1158) scriveva che «Roscellino, nei nostri tempi, fu il primo che introdusse nella logica la dottrina delle parole» (9). É opinione comune che il chierico di Compiègne fu l’iniziatore del nominalismo. Il filosofo, scienziato e magistrato tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) affermava che «sono nominalisti coloro che credono che, ad eccezione delle sostanze spirituali, non ci sono che i puri nomi, e quindi eliminano le realtà delle cose astratte e universali» (10). Prima di indagare la natura del nominalismo e qual è il suo rapporto con la verità che la ragione può raggiungere, poniamoci una duplice domanda. Prendiamo come esempio l’automobile. (a) È a partire dalle singole automobili che produciamo mentalmente (post rem) la generica parola automobile, parola che ha lo scopo di rappresentare i caratteri comuni delle singole automobili, o (b) è a partire dall’idea creativa e progettuale dell’inventore (ante rem) dell’automobile, che si possono produrre una serie di singole automobili che sono tali perché costruite e assemblate seguendo pedissequamente il relativo progetto (in rem), che diversamente non funzionerebbero? Continua
NOTE 1 - Secondo l’accezione tardo antica introdotta, in sede storiografica a partire dal VI sec. d.C., nell’Imperium romanum orientalis che si definiva tale (si veda lo storico della corte imperiale Marcellinus Comes) in contrapposizione alla parte occidentale, che definiva Occidentalis respublica, Occidentale imperium, Occidentale regnum, Hesperium regnum…, laddove la parte occidentale, per sé, si definiva semplicemente Imperium romanum, in AA.VV., Occidente e occidentalismo, Edizioni Maniero del Mirto, Roma, 2022, pp. 66-67. 2 - Mons. Umberto Benigni, Storia Sociale della Chiesa, vol. 4 – t. 1, Centro Librario Sodalitium, Verrua Savoia, 2018, p. 210. 3 - Card. G. Hergenröther, Storia universale della Chiesa, vol. 5, Edizioni Radio Spada, Cermenate, 2022, pp. 109-110. 4 - L. Gentile, Roscellino di Compiègne ed il problema degli universali, Editrice Itinerari, Lanciano, 1975, p. 76-77. 5 - Ad esempio, «in Francia sotto il Re Roberto II (996-1031) [primo successore del casato dei Capetingi], quando cominciavano i processi contro i primi catari ad Orléans, la folla urlava che si cessasse dai giudici di discutere con essi, e si punissero subito. Bastava esser pallidi per esser sospettati di catarismo (che era vegetariano perché la carne proveniva dal Male). Il Vescovo di Liegi e teologo belga Wazone (985-1048) ebbe a protestare contro tali eccessi», in Mons. Umberto Benigni, Storia Sociale della Chiesa, vol. 4 – t. 1, Centro Librario Sodalitium, Verrua Savoia, 2018, p. 216. 6 - L. Gentile, Roscellino di Compiègne ed il problema degli universali, Editrice Itinerari, Lanciano, 1975, p. 76-77. 7 - Ibidem. 8 - E. Bonaiuti, Un filosofo della contingenza nel secolo XI: Roscellino di Compiègne, in Rivista storico-critica delle scienze teologiche, Roma, 1908, p. 212. 9 - Gesta Friderici imperatoris (Imprese dell’Imperatore Federico), in Monumenta Germaniae Historica, SS. XX, 376, reperibile su https://www.thelatinlibrary.com/ottofreising/1.html, Capitulum XLVIIII. 10 - G. W. Leibniz, De Stilo philosophico Nizolii, reperibile su https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/dissertatio/article/ view/8631/5654, p. 343. 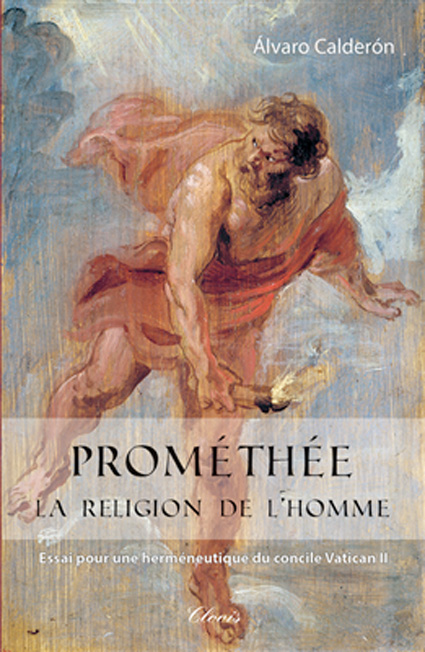 |