 |
 |
| La bottiglia e il vino Seconda parte di Francesco Gisci Prima parte Seconda parte Terza parte Quarta parte Quinta parte Sesta parte Settima parte Ottava parte Nona parte Decima parte Undicesima parte  Quando un pragmatico affermava che per lui era vero ciò che vedeva (quindi ciò che si può conoscere), Sant’Agostino (354-430) rispondeva che «se così fosse, le pietre che si trovano nelle viscere della terra non sarebbero vere pietre, dal momento che non si vedono» (1). Invece, «la verità oggettiva è prima di essere conosciuta e tale resta anche se mai alcun soggetto pensante la conoscesse o la cercasse» (2). E infatti San Tommaso dice che «se la verità fosse solo nell’intelletto nulla sarebbe vero se non in quanto è conosciuto. Ma questo è l’errore di certi antichi filosofi che dicevano che è vero ciò che appare tale all’intelletto» (3). Quest’errore è sopravvissuto anche alla correzione del Dottore Angelico e continua a minare il buon senso fino ai giorni nostri. Uno dei capiscuola del Liberalismo, G. Berkeley (1685-1753), affermava che «l’esistenza delle cose corrisponde al loro essere percepiti (esse is percipi), e non è possibile che esse possano avere una qualunque esistenza fuori dalle menti o dalle cose pensanti che le percepiscono» (4). Ma se così fosse, «seguirebbe che affermazioni contraddittorie sarebbero simultaneamente vere, poiché tesi contraddittorie possono apparire vere a più soggetti» (5). Qui l’Aquinate ci ricorda che la verità si fonda sul principio di non contraddizione, secondo cui «è impossibile per una stessa cosa essere e non essere contemporaneamente» (6). Da cui si deduce, per esperienza, che è vero che le determinazioni contraddittoriamente contrapposte di una cosa, possono trovarsi in quella cosa soltanto in successione. Dedichiamo qualche riga a questo fondamentale argomento. Il prof. Michele Malatesta (1950-2018), fondatore e direttore della rivista internazionale di Logica pura e applicata Metalogicon, il cui titolo ricorda il trattato filosofico del Vescovo e filosofo inglese Giovanni di Salisbury (1120-1180), ci fornisce esempi pratici. Per esempio, «è possibile essere bambino e non bambino (adolescente, adulto o vecchio) ma solo in tempi diversi; è possibile essere malati di cuore e non essere malati di polmoni nello stesso tempo, ma è impossibile nello stesso tempo essere malati di cuore e non essere malati di cuore» (7). Il principio di non contraddizione, che è il cardine su cui si regge la verità di ogni giudizio, è un principio immediatamente evidente in ogni manifestazione della realtà. Il pensiero classico, che ha per oggetto ciò che permane al di sotto dei mutamenti, «poggia sulla nozione di incontraddittorietà dell’esperienza, sia come innegabilità dei dati che essa presenta (certezza del senso comune) che come necessità di problematizzare questi dati, trascendendo e cercando di risolvere le contraddizioni apparenti» (8). Taluni (9), invece, affermano che la realtà si fondi sulla contraddizione. «Ma la tesi che nel mondo si dia contraddizione sorge dalla illusione della spazializzazione del tempo, cioè dalla illusione che l’ordine del tempo sia ordine di coesistenti come l’ordine dello spazio. [Ad esempio], se ieri è piovuto l’intera giornata, il tempo è univocamente determinato e non si dà contraddizione, e la stessa cosa ha luogo se non è piovuto l’intera giornata. Ma se nella mattinata, poniamo dalle 6 alle 12, è piovuto, e nel pomeriggio, poniamo dalle 12 alle 18, non è piovuto, i sostenitori della contraddizione affermano che ieri è piovuto e non è piovuto. La contraddizione in realtà è apparente perché è dovuta all’imprecisione del linguaggio della vita quotidiana. È scorretto dire ieri è piovuto e non è piovuto, mentre è corretto affermare che ieri nelle ore antimeridiane è piovuto e nelle ore postmeridiane non è piovuto, dove le ore della mattina e quelle del pomeriggio si trovano tra loro in un rapporto d’incompatibilità, il che è tutt’altro che contraddittorio. L’espressione ieri è un nome per indicare la sommatoria non certo di momenti coesistenti ma di momenti reciprocamente escludentisi. A questa maniera la contraddizione è risolta. Se sorge una nuova contraddizione, basta ripetere l’analisi esaminando con cura la temporizzazione, e la contraddizione scompare. Ogni qual volta appare o si impone una contraddizione vuol dire che la situazione non è stata analizzata fino in fondo e ci si è fermati a mezza strada» (10). Sempre in modo arbitrario si commette un analogo errore quando si tenta di ridurre la conoscenza alla soggettiva percezione dei propri sensi e, riscontrando che questa è differente e contraria nei vari individui rispetto a una stessa realtà, si sostiene che non è possibile dire come tale realtà sia fatta, o meglio si può dire di essa una cosa e, insieme, un’altra contraria. Anche in questo caso, l’affermazione si fonda su un’illusione. Ad esempio, uno stesso vino può sembrare una volta dolce e un’altra volta no, e ciò accade perché o si è alterato il vino o perché è cambiata la nostra disposizione. Ma il dolce quando c’è non cambia mai. Il dolce sarà sempre dolce secondo il proprio modo di essere, cioè sempre secondo le stesse caratteristiche chimiche. Quindi, in generale, quando si elabora una teoria che vuole rappresentare una realtà e si giunge ad una contraddizione, questa deve essere abbandonata, perché se si assume la contraddizione allora si può derivare qualsiasi proposizione (11) «che conduce inevitabilmente allo sragionamento radicale» (12). In ambito scientifico, la moderna narrazione teorica parla di apparente “natura duale” onda-particella della luce (13). In realtà ciò appare secondo la considerazione non simultanea di un duplice e diverso ordine di fenomeni, ovvero, così è se vi pare. «Il che non vuol dire che non possa darsi contraddizione nel pensiero umano. Le contraddizioni possono essere proficue e portatrici di progresso ma solo nella misura in cui siamo decisi a non rassegnarci di fronte alle contraddizioni e a cambiare qualsiasi teoria ne comporti. […]. Non bisogna confondere il piano della realtà con quello della fantasticheria. Si può fantasticare che un uomo pesi esattamente la metà di quanto pesa e fare di questa ipotesi la base di una serie di deduzioni» (14) che, però, non avranno nessuna corrispondenza con la realtà. Continua
NOTE 1 - S. T., I, Q. 16 a. 1.1. 2 - M. F. Sciacca, Filosofia e metafisica, vol. 1, Editore Marzorati, Milano, 1962, p. 54. 3 - S. T., I, Q. 16 a. 1.2. 4 - G. Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana, stampato da Jacob Tonson, Londra, 1734, p. 38, reperibile su https://wellcomecollection.org/works/aec2hw55/items?canvas=42. 5 - S. T., I, Q. 16 a. 1.2. 6 - Tommaso d’Aquino, Commento al IV libro della Metafisica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2005, lect. 6. 7 - M. Malatesta, Dialettica e Logica formale, Editore Liguori, Napoli, 1982, p. 46. 8 - Antonio Livi, Il principio di coerenza, Editrice Leonardo da Vinci, Roma, 2020, p. 38. 9 - Su tutti il filosofo tedesco G. W. Friedrich Hegel (1770-1831) che ha costruito tutto il suo sistema su una dialettica che assume la contraddizione come legge motrice del sistema, equivoco ingenerato dalla confusione tra opposizione e contraddizione: «mentre l’opposizione, il contrasto, l’antinomia, l’antitesi sono concetti che appartengono alla logica della non contraddizione, non è così per il concetto di contraddizione. Non è affatto contraddittorio asserire che un concetto si opponga ad un altro concetto, che un gruppo di potere contrasti con un altro gruppo, che un’affermazione sia antinomica rispetto ad un’altra affermazione, che una teoria scientifica sia antitetica rispetto ad un’altra teoria scientifica. È contraddittorio invece asserire che un concetto si opponga e nello stesso tempo non si opponga ad un altro concetto, che un gruppo di potere contrasti e nello stesso tempo non contrasti con un altro gruppo di potere, che un’affermazione sia antinomica e nello stesso tempo non sia antinomica rispetto ad un’altra affermazione, che una teoria sia antitetica e nello stesso tempo non sia antitetica rispetto ad un’altra teoria. Il primo ordine di concetti appartiene alla logica formale della non contraddizione, il secondo invece alla [il]logica dialettica». M. Malatesta, Dialettica e Logica formale…, p. 34-35. Per la confutazione logico-formale della formulazione hegeliana dei primi principi: Ibidem, pp. 39-45. 10 - Ibidem, pp. 111-112. (Cfr. Ibidem, pp. 113-116). 11 - Cfr. Ex falso sequitur quodlibet (“dal falso segue qualunque cosa”), teorema dello Pseudoscoto. 12 - Ibidem, p. 60. 13 - https://cdnassets.hw.net/dims4/GG/2c09c11/2147483647/resize/ 876x%3E/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcdnasse ts.hw.net%2F6f%2Fab%2F52d551f44ba3a41b357360a96ffb %2F0917-blaine-landing-tcm20-2167508.png 14 - Ibidem, p. 110. 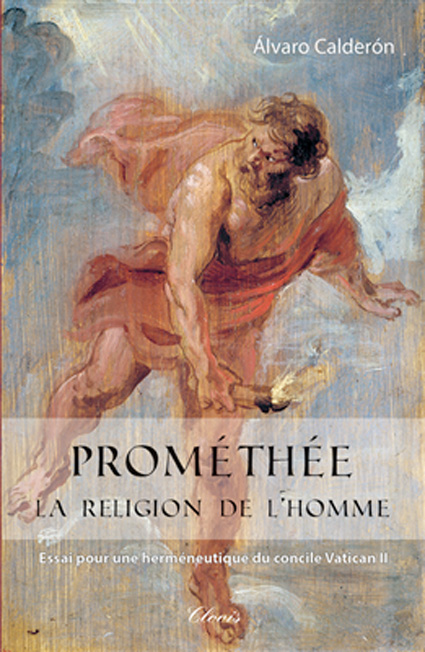 |