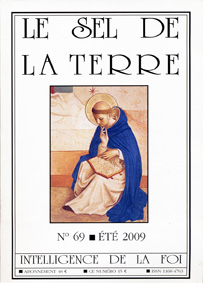|
||
 |
||
| S. Ecc. Mons. Bernard Tissier de Mallerais della Fraternità Sacerdotale San Pio X LA FEDE IN PERICOLO PER LA RAGIONE ERMENEUTICA DI BENEDETTO XVI POSTFAZIONE - CRISTIANESIMO E LUMI
Indice Prefazione Introduzione Cap. 1 - Ermeneutica della continuità Cap. 2 - Itinerario filosofico di Joseph Ratzinger Cap. 3 - Itinerario teologico di Joseph Ratzinger Cap. 4 - Un’esegesi esistenzialista del Vangelo Cap. 5 - Ermeneutica dei tre grandi dogmi cristiani Cap. 6 - Personalismo ed ecclesiologia Cap. 7 - Il personalismo politico e sociale Cap. 8 - Cristo Re rivisto dal personalismo Cap. 9 - La fede personalista di Benedetto XVI Cap. 10 - Un supermodernismo scettico Epilogo: Ermeneutica dei fini ultimi Postfazione: Cristianesimo e Lumi Ringraziamenti Postfazione Cristianesimo e Lumi --- Ringraziamenti Ho ricordato l’auspicio espresso da Benedetto XVI, dopo il suo ritorno dalla Turchia, il 22 dicembre 2006, davanti ai membri della Curia romana, di vedere l’Islam che si aggiorna con l’aiuto dei Lumi, un processo già effettuato nella Chiesa col Vaticano II, «al termine di una lunga e difficile ricerca», confessa il Pontefice; che spiega: Si tratta dell’atteggiamento
che la comunità dei fedeli deve assumere di fronte alle
convinzioni e alle esigenze affermatesi nell’illuminismo. Da una parte,
ci si deve contrapporre a una dittatura della ragione positivista che
esclude Dio dalla vita della comunità e dagli ordinamenti
pubblici, privando così l’uomo di suoi specifici criteri di
misura. D’altra parte, è necessario accogliere le vere conquiste
dell’illuminismo, i diritti dell’uomo e specialmente la libertà
della fede e del suo esercizio, riconoscendo in essi elementi
essenziali anche per l’autenticità della religione (223).
Lascio al lettore la cura per l’apprezzamento della giustezza del libero esercizio delle «fedi», del vantaggio dell’«autenticità» dell’Islam e del grado di realismo circa l’apertura dell’Islam ai Lumi piuttosto che la conversione dei musulmani alla vera Luce «che illumina tutti gli uomini» (Gv 1, 9); da parte mia guarderei alla natura dell’accoglimento, da parte della Chiesa del Vaticano II, della quintessenza dei Lumi: i Diritti dell’uomo. Questo accoglimento, Joseph Ratzinger lo descriveva come un’«acquisizione» e un «equilibrio»: Il problema degli anni
sessanta era di acquisire i migliori valori espressi da due secoli di
cultura «liberale». Sono infatti dei valori che, anche se
sono nati fuori dalla Chiesa, possono trovare il loro posto, epurati e
corretti, nella sua visione del mondo. È quello che è
stato fatto. Ma bisogna confessare che delle speranze senza dubbio
troppo ingenue sono state deluse. Si tratta di trovare un nuovo
equilibrio (224).
Questo testo è una citazione implicita del testo di Yves Congar che ho riportato nella mia introduzione, a cui rinvio il lettore. Il Padre Congar, fin dal 1938 (e nella sua opera del 1950 per una «vera riforma nella Chiesa (225)») proponeva l’assimilazione da parte del cristianesimo degli «apporti validi» del mondo moderno, dopo che la Chiesa il avesse «decantati e all’occorrenza purificati». Questo è ciò che ha tentato il Concilio, ma in fatto di sintesi non si è constatato un equilibrio instabile e non ancora raggiunto? Chi dice infatti equilibrio, non presuppone un rapporto di forze tra due antagonisti? Questo è quanto mi sembra risulti da una conferenza di Joseph Ratzinger che tratta proprio di una mutua purificazione e di una correlazione tra cristianesimo e Lumi (226). Ne riassumo il testo. 1. - Per un verso, la religione farebbe ragionare la ragione positivista facendole ammettere, in scienza come in politica, che «la fede in quel Dio che è in persona la Ragione creatrice dell’universo deve essere accolta dalla scienza in modo nuovo come sfida e chance (227)». Ma insieme non si chiederebbe alla ragione positivista di accettare il diritto naturale – il cui legislatore è Dio, autore della natura umana: Ma questo strumento [dice
Ratzinger] è purtroppo diventato inefficace, e non vorrei
basarmi su di esso in questo intervento. Il concetto del diritto
naturale presuppone un’idea di natura in cui natura e ragione si
compenetrano, la natura stessa e razionale. Questa visione della
natura, con la vittoria della teoria evoluzionista, si è persa.
La natura come tale non sarebbe razionale, anche se in essa v’è
un atteggiamento razionale: questa è la diagnosi che per noi ne
deriva e che oggi appare per lo più inoppugnabile [p. 75].
Ma la natura umana non
è razionale per Dio che l’ha concepita e ne ha fissato i fini?
Non è razionale per l’uomo che, con la sua ragione naturale,
apprende le sue inclinazioni naturali come buone e quindi come dei fini
da perseguire con la sua azione (228)?
C’è da credere che Joseph Ratzinger sia inadatto a sostenere una tale argomentazione, non tanto perché adotta l’antitesi evoluzionista che richiama, ma perché rifiuta l’idea di finalità e la nozione di causa finale. Tuttavia, egli è disposto ad ammettere come un residuo di diritto naturale che sarebbero i Diritti dell’uomo: Come ultimo elemento del
diritto naturale, che vuole essere il più profondamente
possibile un diritto razionale – almeno nell’età moderna – sono
rimasti i diritti umani. Essi non sono comprensibili senza presupporre
che l’uomo in quanto tale, semplicemente per la sua appartenenza alla
specie umana, sia soggetto di diritti, che il suo essere stesso
comporti valori e norme che devono essere individuati, ma non inventati
[p. 75-76].
Il mio lettore si
indignerà, spero, per questa «specie d’uomo» senza
natura conoscibile che serve da fondamento non a dei diritti (a
ciò che è diritto,
perché questo conviene alla natura
umana e ai suoi fini), ma da
fondamento ad un «soggetto di diritto», che dice solo
«io ho il diritto», senza sapere prima a che ha diritto,
né da dove gli venga questo «ho diritto». Egli si
indignerà anche per questi «valori» che, senza
essere l’ordine dovuto al fine conveniente alla natura, sono quanto
meno «dei valori che valgono per se stessi, che provengono dalla
natura umana e perciò sono inattaccabili per tutti coloro che
possiedono questa natura» (p. 69). E si indignerà
altresì per queste «norme» che apparentemente non
hanno autore, nemmeno quel Dio che tuttavia è «la Ragione
creatrice dell’universo». E si indignerà infine per il
fatto che questi «valori» e queste «norme»
debbano essere, secondo Joseph Ratzinger, completate, limitate con una
lista dei «doveri dell’uomo» Un decalogo? Al posto delle
norme del diritto naturale derivate naturalmente dai comandamenti di
Dio, avremmo dei doveri dell’uomo antagonisti e regolatori dei suoi
diritti:
Forse oggi la teoria dei
diritti umani dovrebbe essere integrata da una dottrina dei doveri
umani e dei limiti umani, e ciò potrebbe però aiutare a
rinnovare la questione, se non ci possa essere una ragione naturale, e
dunque un diritto razionale […]. Per i cristiani ciò avrebbe a
che fare con la creazione e con il Creatore. Nel mondo indiano
corrisponderebbe al concetto di dharma,
la legge interna dell’essere, nella tradizione cinese all’idea degli
ordini celesti [p. 76].
Il Creatore non è
più il legislatore unico della natura? È solo il gendarme
dei Diritti dell’uomo? Tra la fede cristiana (o le altre tradizioni
religiose) e i Lumi (e i loro
Diritti dell’uomo), l’assimilazione sognata da Yves Congar,
l’acquisizione auspicata da Joseph Ratzinger, l’equilibrio richiamato
da Benedetto XVI, si rivelano essere un braccio di ferro.
2. - Per altro verso, il cristianesimo (come tutte le religioni) – guarito dalle sue «patologie» (p. 79) con la purificazione della sua tendenza ad essere, invece che una forza di salvezza, «un potere arcaico e pericoloso, che crea falsi universalismi [il regno di Cristo o la Jihad] e perciò induce all’intolleranza e al terrorismo» (p. 71) – convaliderebbe i Diritti dell’uomo, debitamente purificati e limitati, come «la traduzione delle convinzioni codificate dalla fede cristiana nel linguaggio del mondo secolarizzato», secondo l’espressione di Jürgen Habermas nello stesso dialogo (229). (su)
Mutua rigenerazione e correlazione polifonica Riassumendo, Joseph Ratzinger dichiara: «…mi trovo in ampio accordo con ciò che Habermas ha esposto sulla società post-secolare, riguardo la disponibilità ad apprendere e la autolimitazione da entrambe le parti»; e spiega: - In primo luogo, abbiamo
visto che ci sono patologie nella religione, che sono assai pericolose
e che rendono necessario considerare la luce divina della ragione [sic] come un organo di controllo,
dal quale la religione deve costantemente lasciarsi chiarificare e
regolamentare […].
- Ma […] si è anche mostrato che esistono patologie anche nella ragione […], una hybris [furore] della ragione, che non è meno pericolosa […]: la bomba atomica, l’uomo visto come prodotto. Perciò anche alla ragione devono essere rammentati i suoi limiti ed essa deve imparare la capacità di ascolto nei confronti delle grandi tradizioni religiose dell’umanità. […] Kurt Hübner ha brevemente formulato una simile esortazione dicendo che con una tesi del genere non si tratterebbe di un «ritorno alla fede», ma della «liberazione dall’errore epocale, che essa (cioè la fede) non abbia più nulla da dire ai contemporanei, perché in contrasto con la loro idea umanistica di ragione, illuminismo e libertà». Di conseguenza parlerei della necessità di un rapporto correlativo tra ragione e fede, ragione e religione, che sono chiamate alla reciproca chiarificazione. […] [Quanto alle altre componenti culturali e religiose] È importante accoglierle nel tentativo di correlazione polifonica, in cui esse si aprano spontaneamente alla complementarità essenziale di ragione e fede, cosicché possa crescere un processo universale di chiarificazione, in cui infine le norme e i valori essenziali in qualche modo conosciuti o intuiti da tutti gli essere umani [sic] possano acquistare nuovo potere di illuminare, cosicché ciò che tiene unito il mondo possa nuovamente conseguire un potere efficace nell’umanità [pp. 79-81]. *
Così, l’ermeneutica di Benedetto XVI va molto più in là di quanto avessi intuito all’inizio: più che di una rilettura, si tratta di una rigenerazione; ed essa oltrepassa i soli rapporti della religione cattolica con la razionalità occidentale. Essa è innanzi tutto una mutua purificazione della fede e della ragione che correggerebbe la deriva intollerante della prima e la cieca autonomia della seconda. Essa comporterebbe poi una mutua rigenerazione della fede e della ragione che arricchirebbe la fede con i valori liberali, debitamente limitati, della ragione dei Lumi, e guadagnerebbe la ragione all’ascolto della fede, debitamente decodificata e trascritta in linguaggio secolarizzato. E questo processo si estenderebbe universalmente a tutte le fedi religiose e a tutte le razionalità. Senza realizzare un unico ethos mondiale (p. 79), si darebbe così vigore ai valori che reggono il mondo. *
Non sembra al mio lettore che ciò che mantiene il mondo non sono i «valori» di Max Scheler, né l’uomo «soggetto dei diritti» dei Lumi, ma Gesù Cristo, autore, riformatore ed elevatore dell’umana natura? «Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo» (1 Cor 3, 11). Di fronte a questo convincimento fornito dalla fede cristiana, ogni costruzione funambolesca di un teologo da salotto – salva reverentia – crolla come un castello di carte, come crollerà il Nuovo Ordine Mondiale che egli vuol servire. Alla ragione secolarizzata, la fede ha una sola vera parola da dire: «Omnia instaurare in Christo (Restaurare ogni cosa in Cristo)» (Ef 1, 10). (su)
NOTE 223 - DC n° 2373, 4 febbraio 2007, p. 108. [il testo in italiano è disponibile nel sito della Santa Sede]. 224 - J. RATZINGER, «Pourquoi la foi est en crise», entretien avec Vittorio Messori, Jesus, novembre 1984, p. 72. [Cfr: Rapporto sulla fede, Vittorio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Edizioni Paoline,1985, p. 34]. 225 - Y. CONGAR, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Paris, Cerf, 1950, pp. 345-346. 226 - JOSEPH RATZINGER, «Democratie, droit et religion» in Les Fondements prépolitiques de l’État democratique, Dialogue avec Jürgen Habermas, Munich, 19 janvier 2004, traduction de Jean-Louis Schlegel, nella rivista Esprit, juillet 2004, pp. 5-28. [HABERMAS, RATZINGER, Ragione e fede in dialogo, Marsilio, 2005, pp. 65-81] 227 - Discorso alla Curia del 22 dicembre 2006, DC n° 2373, 4 febbraio 2007, p. 207. [il testo in italiano è disponibile nel sito della Santa Sede]. 228 - SAN TOMMASO, I-II, q. 94, a. 2. 229 - Vedi: J. RATZINGER, discorso del 22 dicembre 2006, DC n° 2373, 4 febbraio 2007, p. 207. [il testo in italiano è disponibile nel sito della Santa Sede]. (su)
Per chiudere questo studio, ringrazio i miei confratelli Don Benoît de Jorna e Don Jean-Michel Gleize per il loro impegno intellettuale, sia metafisico sia ecclesiologico, che mi ha fornito idee e documenti preziosi. Ringrazio ugualmente il Padre Jean-Dominique Favre per il suo aiuto nella filosofia tedesca e Don François Knittel per i suoi lavori di etica che ho saccheggiato senza vergogna; Don Renaud de Sainte-Marie per la sua tesi di dottorato in filosofia su Le Rôle du bien sensible dans la représentation et l’obtention du bien moral chez saint Thomas d’Aquin et Kant [Il Ruolo del bene sensibile nella rappresentazione e nell’ottenimento del bene morale in San Tommaso d’Aquino e in Kant] (Istituto Universitario San Pio X, giugno 2006); Don Alain Lorans per la sua «Analisi» del discorso del 22 dicembre 2006, in DICI, n° 148, 13 gennaio 2007, pp. 11-12, che ho copiato; Don Dominique Bourmaud per la sua opera Cent ans de modernisme: Généalogie du Concile Vatican II [Cent’anni di modernismo: Genealogia del Concilio Vaticano II], Clovis, 2003, e il suo articolo Karl Rahner, fils du modernisme, in Fideliter n° 179, settembre-ottobre 2007, p. 29; Don Christian Thouvenot per il suo articolo La foi selon Joseph Ratzinger, apparso nello stesso numero di Fideliter, p. 32; Don Xavier Beauvais per il suo articolo sulla fede modernista contemporanea apparso in Le Chardonnet, n° 236, marzo 2008, secondo Marcel De Corte; Don Grégoire Celier per i suoi consigli metodologici; e il Padre Pierre-Marie de Kergolay per le importanti correzioni che mi ha suggerito. Grazie a ciò che ho appreso da tutti loro alla scuola di San Tommaso d’Aquino, posso osare dire, con il saggio re Salomone: «Senza frode imparai e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze» (Sap 7, 13). PIndice Prefazione Introduzione Cap. 1 - Ermeneutica della continuità Cap. 2 - Itinerario filosofico di Joseph Ratzinger Cap. 3 - Itinerario teologico di Joseph Ratzinger Cap. 4 - Un’esegesi esistenzialista del Vangelo Cap. 5 - Ermeneutica dei tre grandi dogmi cristiani Cap. 6 - Personalismo ed ecclesiologia Cap. 7 - Il personalismo politico e sociale Cap. 8 - Cristo Re rivisto dal personalismo Cap. 9 - La fede personalista di Benedetto XVI Cap. 10 - Un supermodernismo scettico Epilogo: Ermeneutica dei fini ultimi Postfazione: Cristianesimo e Lumi Ringraziamenti febbraio 2011 AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI |